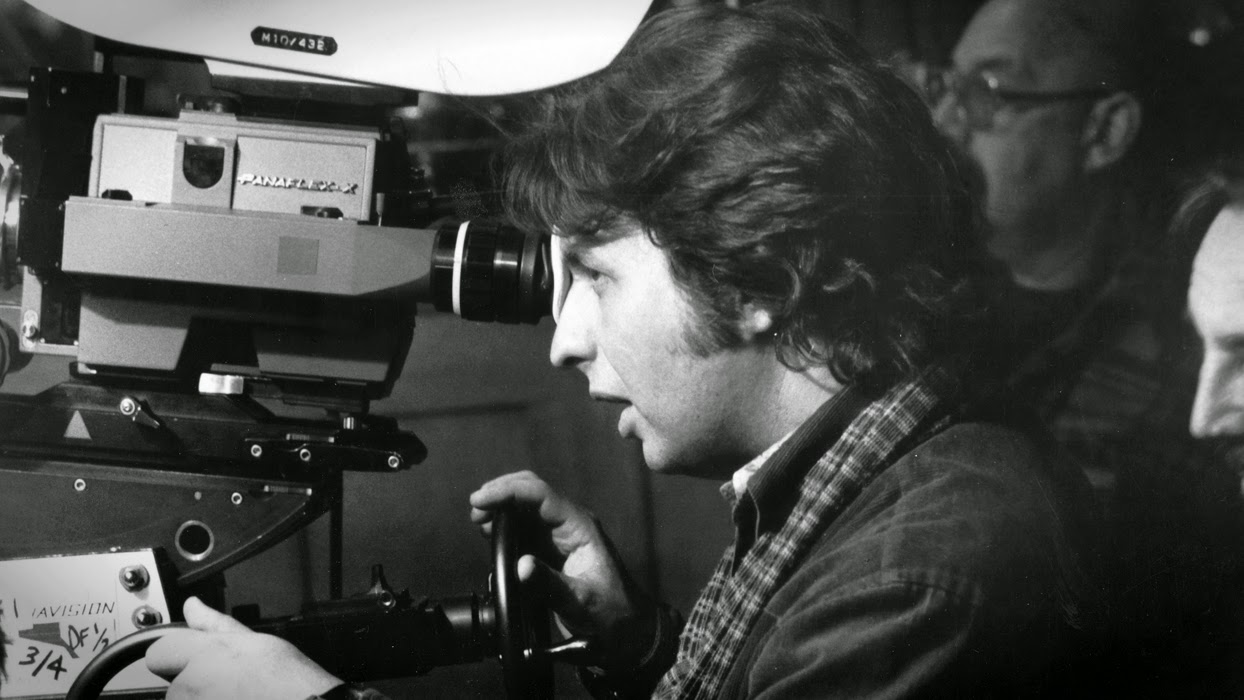Intervista di Herb Lightman pubblicata in American Cinematographer n. 11, novembre 1980
Qual è stato il più grosso problema che ha avuto nel fare un film complesso come Heaven’s Gate?
Uno dei problemi più difficili è stato mettere assieme un numero sufficiente di artigiani in ciascuna categoria di produzione. A un certo punto avevamo quattro squadre di costruzione al lavoro, due nel Montana (una ad est del Continental Divide, l’altra ad ovest, ambedue su terreno montuoso), un’altra a Denver (alla costruzione del treno che fu poi trasportato nel Montana e nell’Idaho), e una quarta squadra, la più grande, a Wallace, nell’Idaho, dove si costruiva il set più importante, la città di Casper. Oltre a questi c’erano i cow boy (che raggiungevano le 80 o 90 unità), più il regolare organico di produzione. Penso che il totale si aggirasse sui 400. Abbiamo avuto problemi enormi nel trovare così tante persone dotate e competenti, specialmente quando si trattava di specializzazioni in cui non c’è stata attività negli ultimi tempi: costruttori di ruote, sellai, gente capace di costruire carri. Il numero di quel tipo di artigiani sta diminuendo, e si stanno anche disperdendo perché non sono più concentrati nell’area di Hollywood. È un problema che affligge un po’ tutta la nuova Hollywood, anche in altri generi, come la fantascienza e gli effetti speciali. I produttori devono sempre affrontare la possibilità di dover assumere personale ormai non più attivo per fare lavori speciali.
Quali ritiene fossero gli elementi potenzialmente più drammatici degli anni ’9, il periodo in cui si svolge la parte centrale del film, quella che ha girato nel Montana?
L’ultimo decennio dello scorso secolo è un periodo di cui non ci si è occupati molto, in senso drammatico. Eppure penso che siano stati anni interessanti. Erano anni immediatamente successivi alla guerra civile, e ricchi di fermenti. Quasi tutti i discorsi inaugurali delle università avevano qualcosa da dire a proposito di ricostruzione, di riconciliazione, del bisogno di andare avanti per creare qualcosa di nuovo e vivo. Avevano un tono piuttosto idealistico e responsabile. Il loro spirito doveva essere molto simile a quello che abbiamo conosciuto durante il periodo che ha visto la nascita del movimento pacifista in cui si respirava un certo tipo di idealismo, fatto di grande fiducia nella vita, in ciò che poteva migliorare nell’ordinamento sociale del paese. Penso che questa fiducia nel futuro fosse caratteristica dell’800 e penso che Heaven’s Gate sotto molti aspetti ritragga ciò che succedeva quando si lottava disperatamente per diventare americani. Una parte della popolazione era già integrata, un’altra non lo era ancora, ma ce la mettevano tutta a diventarlo. Direi che è un film sull’America che tenta di diventare America.
Dal punto di vista della messa in scena vera e propria quali sono state le sequenze più impegnative?
Credo quasi tutte. Mi è difficile pensare, almeno così al momento, a qualcosa che non sembrasse particolarmente impegnativo. Tutto lo era. Alcune cose richiedevano più tempo di altre. Per esempio la sequenza a Wallace, nell’Idaho, dove avevamo più di mille comparse nella strada, 80 o 90 paia di cavalli, e un set la cui costruzione aveva richiesto più di 3 mesi, e dove avevamo fatto arrivare un treno facendogli attraversare cinque stati. Solo il fatto di disporre la gente, dividere la folla, piazzare i volti in modo da ottenere gli effetti desiderati richiese un’enormità di tempo. Penso al tempo che occorre per scegliere gli immigranti da mettere a sedere sul tetto del treno piuttosto che sul marciapiede, distinguendoli dalle persone arrivate da più tempo, che sarebbero stati nella strada, creando una composizione di volti, in modo che, senza alcuna istruzione verbale, si potesse ottenere una sensazione di struttura sociale, mettendo in scena l’azione in modo tale che il solo movimento della strada rendesse manifesta l’esistenza di ben precise differenze sociali tra poveri e ricchi, tra vecchi e nuovi arrivati, e gente di passaggio… Rendere tutto ciò in maniera naturale e spontanea richiede evidentemente molto tempo.
Quanto importanti sono i luoghi’ nella produzione dei suoi film?
John Ford diceva che tutte le sue idee erano ispirate dai luoghi dove si girava, e, penso che ciò sia vero anche per me. Mi è assai difficile pensare di mettere in scena un’azione, lunga o breve che sia, senza conoscere perfettamente il luogo dove essa si svolgerà. È il luogo in cui si svolge la scena ad ispirare la scena stessa, e questo è valido sia per un set costruito artificialmente, sia per una montagna o un fiume reali. Bisogna conoscere i luoghi, perciò preferisco occupare molto del mio tempo cercandomeli da solo, interessandomi da vicino ad ogni fase del progetto, della costruzione, della pittura e dell’arredamento di ogni cosa. Lo faccio per due ragioni: mi assicuro che tutto sia giusto, ma acquisto anche una tale familiarità con la scena da conoscerla fin nei minimi particolari. È proprio questa conoscenza che indica come sviluppare la scena, e attraverso una combinazione di intensa familiarità con i luoghi e una simile familiarità con i volti che formano parte della composizione, si comincia ad abbozzare la composizione stessa, dopo la si ritocca gradualmente fino a che è pronta per essere girata.
Che tipo di carattere voleva dare a questo film dal punto di vista estetico?
Di nuovo, penso siano i luoghi delle riprese a imporre le scelte estetiche. Non penso si possa partire da un predeterminato carattere estetico, si comincia a lavorare ad ogni elemento del film in tutti i suoi particolari ed il carattere comincia ad evolversi. Si comincia a lavorare sul guardaroba e, con le scelte dei tessuti, dei colori e dei disegni, gran parte del colore del film viene determinato automaticamente. Quando le scene vengono costruite, pitturate, rifinite ed arredate, il colore continua a prendere forma, il che non vuol dire che non ci sia un senso estetico, ma di solito non viene articolato. È una specie di scelta dettata dall’inconscio, un istinto più che una decisione specifica ed obiettiva.
Lei aveva già lavorato con Vilmos Zsigmond in The Dear Hunter. Può parlarmi dei suoi rapporti di lavoro con lui in questo film?
Una piacevole scoperta che ho fatto lavorando in questo film, è che il rapporto con Vilmos è continuato e migliorato, si è arricchito, ed è stato per me estremamente gradevole, nel senso che mi sono accorto che entrambi aspiriamo alle stesse cose. So che posso contare sulla tenacia e la resistenza di Vilmos, e so che per quanto stanco egli sia, e per quanto si continui a lavorare, non scenderebbe a compromessi. Credo che tra di noi ci sia questa tacita intesa, ed è un appoggio stupendo sapere di avere persone che non scenderebbero a compromessi nel loro campo, sapere che si può contare non solo sulla forza del loro impegno, ma anche sulla forza della loro ostinazione, che è una cosa meravigliosa, poiché la gente tende ad assentire troppo spesso, troppo facilmente e senza discutere troppo. Avere un nucleo di persone che non lo fanno e di cui ci si fida, è terribilmente importante.
Ha avuto molti problemi a causa del tempo durante le riprese?
Nel Montana il tempo era talmente variabile che spesso nello spazio di una sola giornata ci poteva essere il sole, nevicare, piovere, fare caldo e gelare. A volte sembrava anche che le quattro stagioni si susseguissero nel corso di una mattinata. Nevicò per la maggior parte di giugno, luglio e agosto, e fu incredibilmente caldo in ottobre e novembre. Si poteva avere trovato il luogo più incredibilmente bello e avere il rischio che il cielo diventasse nuvoloso. Le nuvole si muovevano col vento che le soffia, mentre il sole è lassù nel punto più perfetto oltre la montagna, e la montagna ti fa aspettare, e tu ti siedi lì e devi decidere se girare con la luce che c’è, o aspettare che migliori, il che potrebbe anche non succedere. Quando si devono rispettare dei limiti di tempo e di soldi, e si hanno centinaia di persone attorno, bisogna prendere decisioni del genere tutto il tempo.
Può parlarmi della città che ha costruito nel Glacier National Park?
La città si chiamava Sweetwater ed era stata costruita sulle sponde del Two Medicine Lake, che si trova appunto nel Glacier National Park. È lì che abbiamo costruito un insediamento di emigranti, completo di chiesa, pista di pattinaggio, tende varie, bar e ristoranti. Per proteggere l’ambiente naturale del Parco si dovette posare l’intera città, strade comprese, su di una piattaforma sollevata di un metro dal suolo: non era possibile costruire direttamente sul terreno e il lavoro fu complicato e difficile. Naturalmente, alla fine delle riprese dovemmo smantellare tutto, e riportare il luogo allo stato in cui era prima del nostro arrivo.
Ha girato lì sia gli interni che gli esterni?
Alcuni edifici – quattro o cinque – dovettero essere costruiti due volte. La prima volta li costruimmo a Kalispell, essenzialmente per gli interni, e poi li replicammo identici, soprattutto per gli esterni, nel Glacier National Park. Il viaggio fino al Park era tanto lungo che non avremmo mai potuto portarvi tutti quanti. Un gran numero di luoghi di ripresa era talmente lontano e giungervi era talmente difficile e richiedeva talmente tanto tempo, che in molti casi fummo costretti a ricostruire alcune strutture.
Era a Kalispell il set principale della pista di pattinaggio, quello in cui sono stati girati gli interni?
Si, ma fu distrutto due volte dal vento. La notte in cui tornammo da Wallace, nell’Idaho, lo trovammo raso al suolo. I ragazzi lavorarono tutta la notte e lo ricostruirono nel giro di 48 ore. Il vento soffiava con violenza laggiù. Abbiamo avuto dei giorni con vento a 75-80 nodi.
E le riprese girate in Inghilterra?
Avevamo bisogno di un’atmosfera universitaria, di un vero e proprio clima accademico, tale da riuscire a comunicare un senso di storia e di privilegio, poiché I privilegi sono la cosa più importante. Andammo a Harvard, che, tra l’altro, ci poneva seri limiti d’azione, non essendovi molte costruzioni di quell’epoca che fossero ancora architettonicamente pure. Saremmo stati costretti ad utilizzare essenzialmente tre edifici. Essi si trovavano ad un angolo dello Yard, e ciò significava che si sarebbe dovuto girare in una specie di L, in un angolo, con pochissime possibilità di voltare la cinepresa. Avremmo avuto limitazioni in ogni movimento.
Inoltre a quell’epoca Harvard aveva dei problemi causati da un film che vi era stato fatto in precedenza, ed era sempre minore l’entusiasmo per l’idea che ne venissero girati degli altri. Andammo fin lì, osservammo il posto, e mandammo delle persone dappertutto negli Stati Uniti, in Inghilterra, perfino in Irlanda, a cercare un luogo adatto. Alla fine, Oxford, ancora una volta, ci parve essere il luogo giusto. Esso non è Harvard più di quanto i Cascades non siano le montagne della Pennsylvania, ma entrambi vanno bene per il racconto. Lo spirito e il carattere erano quelli che cercavamo, e dopo tutto non stavamo redigendo un documento storico. Si trattava di un’opera narrativa, e dovevamo trovare un luogo che ci entusiasmasse, ci affascinasse, ci ispirasse; lo trovammo lì. Sia gli interni che gli esterni furono entusiasmanti da quel punto di vista, e la maggior parte delle difficoltà sorsero dal fatto che lavorammo quasi esclusivamente non rispettando l’ordine delle sequenze. Girammo infatti l’inizio per ultimo, e per ovvi motivi non fu certo facile. Kris Kristofferson all’inizio del film è un uomo di vent’anni. A metà del film ne ha quaranta, e alla fine cinquanta, e ciò pone diversi problemi.
Può parlarmi dell’albero che ha costruito per quelle riprese?
Il copione richiedeva un albero di notevoli dimensioni, e il cortile dell’unico college di Oxford che soddisfacesse alle nostre esigenze ne era privo. Fortunatamente riuscimmo ad accordarci con la direzione del college per sistemarcene uno. Ma ci serviva di dimensioni tali (15-20 metri) da superare largamente quelle concesse dai regolamenti britannici sui trasporti stradali. Così l’albero dovette venire segato in centinaia di pezzi e rimontato con viti e tiranti sul luogo della scena. Lo si dovette numerare tutto, pezzo per pezzo, e per tenerlo in piedi occorsero circa 40 tonnellate di cemento. Fu proprio un lavoro imponente, e ci vollero diversi mesi per trasportarlo sul luogo e rimontarlo tutto.
Ha incontrato difficoltà per ottenere il permesso di abbattere un albero?
No. Si trattava di un vero albero, ma vecchio e ammalato, e lo acquistammo da un fattore.