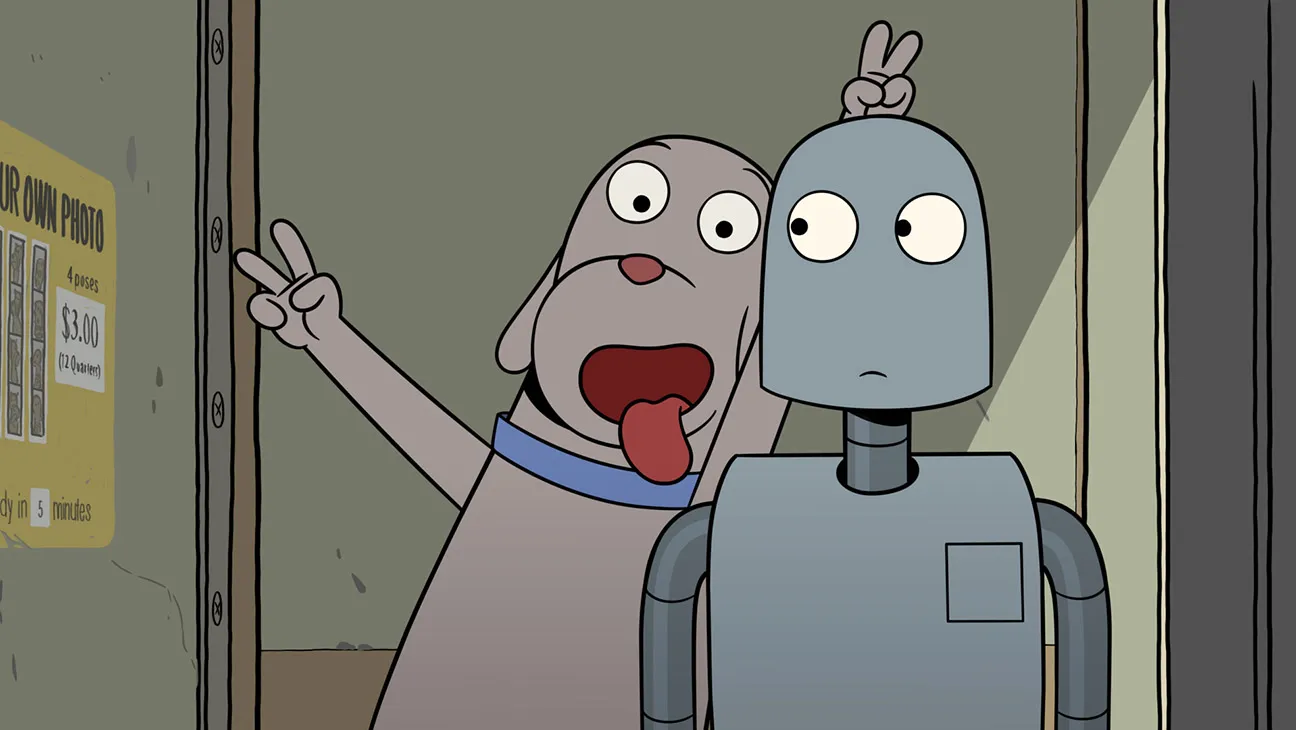di Mario Verdone
Se vorremo, per questa stagione cinematografica, indicare un film che raggiunge come pochi altri altezze di purezza e di poesia, pur nella diversità di risultati tra prima e seconda parte, dovremo fermarci, anzitutto, su Uccellacci e uccellini di Pier Paolo Pasolini. Se vorremo, anche, indicare un’opera che raccoglie insieme a vividi frammenti di smalto, sconnessioni e detriti, magari travestendoli da fonèmi («dove vanno gli uomini? -Boh!»), e che, pur nato in clima strutturalista, manca di architettura, faremo bene a non disinteressarci di Uccellacci e uccellini.
Infine, parleremo ancora del film di Pasolini se vorremo scegliere, nella produzione cinematografica internazionale, un’opera che affronta coraggiosamente e con novità, sul piano tematico e linguistico, le crisi di valori, di credenze, di sistemi ideologici, che sono caratteristiche del nostro tempo. Ecco un certo numero di motivi, ci sembra, che danno a sufficienza una prima idea del peso che acquista Uccellacci e uccellini nella produzione attuale, e che depongono sulla singolarità, sulla opportunità e sulla necessità, direi, del film, che è ora opera poetica, ora discorso serio e utile, e non importa se non conclude, se non rompe del tutto gli schemi delle nostre concezioni di vita, da una parte, e del linguaggio usato, logorato, dall’altra, per imporre qualcosa di nuovo: perché anche tutto ciò che appartiene a questi anni della nostra vita non riesce a concludere e non riesce a rompere. Anche noi viviamo a fianco di un corvo moralista, come i protagonisti di Uccellacci e uccellini, che ci redarguisce, che ci fà la lezione, che ci richiama all’ordine, e che alla fine, dopo averlo subito, forse anche superato, divoriamo sia per liberarcene, sia per assorbirlo. Mai come oggi gli uomini hanno divorato tanto se stessi e il prossimo, le idee proprie e quelle degli altri. La fagocitazione simboleggia «ad abundantiam» una condizione morale che è tipica del nostro tempo.
Uccellacci e uccellini riprende un tipo di film appena apparso nella storia del cinema, e rimasto inavvertito, dimenticato, fino a ridiventare, con Pasolini, del tutto nuovo. Questo tipo di ironica fiaba ideologica (che, civettando coi neologismi, l’autore chiama «ideocomica») non l’abbiamo trovato, al cinema, che nel disegno animato. Non dico quello di Walt Disney, che è proprio la fiaba tradizionale, senza nessuna sorpresa, ma di Masereel, di Bartosch, di Rolland: ancora dei marxisti, o assai vicini ai marxisti, credo. Il rimando è all’Idée, che Masereel e Bartosch realizzarono tra il 1930 e il 1934, e che era un discorso tutto di carattere ideo-drammatico (allineiamoci con la terminologia dello scrittore) e sociologico; alla Revolte des machines o La Pensée dechainée che Rolland e Masereel non riuscirono a portare compiutamente sullo schermo; al Film-Grootesk di Masereel, che rimase come «Libro d’ore».
Nei tentativi cinematografici o para- cinematografici che ora ho citato è un dibattito di idee che è proprio degli anni venti, e trenta: la critica del mondo moderno dominato dalle macchine, nella Revolte; un attacco al capitalismo e al clericalismo nell ‘Idée, figura di una donna inseguita che rappresenta la verità. Allora, quell’invito al dibattito, alla «tribuna» viva, non ebbe un seguito. Riuscirà questa riproposta di Pasolini a farlo accettare?
L’assenza, in questo dibattito ideologico in forma fiabesca, di un episodio di circa dieci minuti, quello indicato come «L’uomo bianco», o «Il domatore e l’aquila», che l’autore ha abolito — se ne ha purtuttavia lo scenario nel volume « Uccellacci e uccellini » edito da Garzanti — può giustificare, dal punto di vista estetico, la carenza di taglio che nel film — realizzato, come accennavamo, con ambizioni strutturaliste — sussiste, giacché Pasolini l’aveva originariamente ideato e costruito in quel certo modo. I valori poetici, tuttavia, non per questo si attenuano. Il racconto dei due frati giullareschi che cercano di capire il linguaggio degli uccelli e che dopo lungo studio riescono a comunicare con loro è di una altezza poetica esaltante, che il cinema ci ha dato poche volte. Bisogna pensare a Francesco giullare di Dio di Rossellini per trovare qualcosa di altrettanto puro nel cinema italiano. V’è la semplicità della pittura primitiva — si pensi ai quadretti di Sano di Pietro —, la divina stoltezza delle cantiche francescane, la autonomia e il rigore — almeno qui — della musica da chiesa. Lo stesso paesaggio ha la felicità di scelta del Vangelo secondo Matteo.
La grande trovata è di affidare a Totò il ruolo del frate Ciccillo. E v’è trovata anche nello scegliere quel prato solcato da pietre, dove Totò danza la lingua degli uccelli senza tradire le sue origini di «slogato», di «pazzariello», di «marionetta» disossata e umanizzata. Abbia Pasolini di queste intenzioni, di questi adattamenti geniali, al proprio linguaggio, di elementi linguistici preesistenti: ma non ci obblighi a chiamarli «cinèma», «grafèma» e «fonèma!». Li crei poeticamente, ma non ci vincoli poi anche a una terminologia che qui è il frutto di una creazione cerebrale, senza convincente rispondenza nella sostanza, e che farebbe saltare dai tùmuli i «pionieri», che verrebbe rigettata dal senso assoluto di libertà, dal dispregio degli schemi, di «maestri» che sono i veri genitori-costruttori del linguaggio cinematografico e delle sue problematiche!
Nella terminologia proposta da Pasolini troviamo anche gli «imsegni» (immagini significanti) e i «linsegni» (parole), che fanno tanto «Congresso dei Dantisti Dentisti». Viene a mente una battuta ironica nel giardino di villa Generone: «Sono disposto ad ammettere un polilinguismo in Dante …». A queste prezioserie non arriverebbero neppure gli «specificatoli» dell’Opojaz, spesso ignorati — qui Pasolini non c’entra — da certi trattatisti di semiologia, che sanno tutto su Barthes, poco o niente sulle ricerche di Ejzenstein e Sklovskij, cui si riferisce anche Barbaro nel suo «Film: soggetto e sceneggiatura» in pagine ove mostra di non ignorare i problemi del «quod significai» e del «quod significatur».
Barbaro aveva dato un senso anche a «prosa» e «poesia» nel cinema, che hanno avuto accezioni diverse nel problema teorico del film — basti pensare che a un certo momento si considerava «prosa» il film di finzione e «poesia» il documentario —; e poi v’è chi ha considerato il film, come la letteratura, d’arte o trattenimento, oppure d’autore o di mestiere. Anche la suddivisione che Pasolini propone, di «cinema di poesia» e «cinema in prosa», ignorando questi precedenti, può risultare, se non improvveduta, almeno arbitraria.
Che legame resta tra le premesse teoriche, strutturaliste, del volume occasionato dal film, e l’opera in sé?
Uccellacci e uccellini non riesce minimamente — mi sembra — a dare l’idea di quel che potrebbe essere una opera concepita strutturalisticamente. Per avere un esempio di film di questo tipo bisogna ricorrere ad Aleksandr Nevskij: qui c’è la costruzione costante che esige lo strutturalismo; ma quanti altri autori di film ne sono capaci? L’artista, il più delle volte, e non solo quello cinematografico, è capace solo di correlazioni formali. Quasi tutta l’arte moderna — eccettuati i costruttivisti — ne è testimonianza, e non per questo dovrebbe esser meno degna di stima. Ma l’opera «strutturalista» che Pasolini farebbe intendere nei suoi saggi teorici premessi allo scenario (Garzanti, op. cit.) qui assolutamente non sussiste: si è accennato dell’abolizione di un episodio e dello sbilancio tra una parte e l’altra, un episodio e l’altro: e tutto ciò non è strutturalista!
Vedrei nell’episodio «der concime», nella topografia di Borgo Monnezza e di Via Mangiapasta o Strappalenzuola, negli scanzonati, sarcastici titoli di testa, sulla musica del cantastorie Domenico Modugno, più Carmelo Bene (e ne sono un ammiratore) che lo strutturalismo! E in mezzo al film, isolata, una parabola che è un capolavoro: il colloquio dei francescani Ciccillo e Ninetto con gli uccelli.
Il film è tutto metaforico e simbologia); prima d’ogni altra cosa, però, è autobiografico. E qui va riconosciuto che Otto e mezzo, nel presentare la crisi di un regista, ha fatto scuola. Sono venute Les Créatures della Varda, cioè la crisi di uno scrittore (fumettistico, popolaresco, sia pure, ma scrittore); ed ecco, in pari tempo, Uccellacci e uccellini, che è la crisi di un intellettuale. Più delle Créatures, questo, affine ad Otto e mezzo, del pari autobiografico, anche se l’intellettuale non è «rappresentato»: ne prendono il posto due personaggi, Totò e Ninetto, incamminati in una interminabile strada. Sono personaggi che, al modo loro, cercano la verità, che sono alle prese con la realtà di ogni giorno, che si imbattono in un corvo sgradevole che fa loro la critica, e non sanno far di meglio, per farlo tacere, che mangiarlo. La strada percorsa da Totò e da Ninetto — dall’autore, quindi — rispecchia la necessità di progredire e la realtà del mondo, con la esigenza di AMORE, più volte riaffermata; con l’incontro di Luna, che per loro è semplicemente la beatitudine possibile, la donna, e la purezza nell’ingenuità — anche se trattasi di passeggiatrice —, l’empireo a portata di mano; con la visione del funerale di Togliatti che è mortalità della politica («la politica e la morte unite con la violenza» dice Pasolini) di fronte alla eternità della poesia.
Sì, tutto l’apologo degli uccelli conta, ma le centinaia di migliaia di cittadini ai funerali di Togliatti sono una realtà, la politica è una realtà: e qui è uno dei significati del film. Che però non ne esclude un altro, e potrebbe identificarsi in questo estremo confronto, in questo estremo «scandalo»: attraverso lo «scandalo» di questa sincerità (la politica è mortale) allo «scandalo» della poesia (l’amore è eterno).
Bianco e Nero, N.11, Novembre 1966