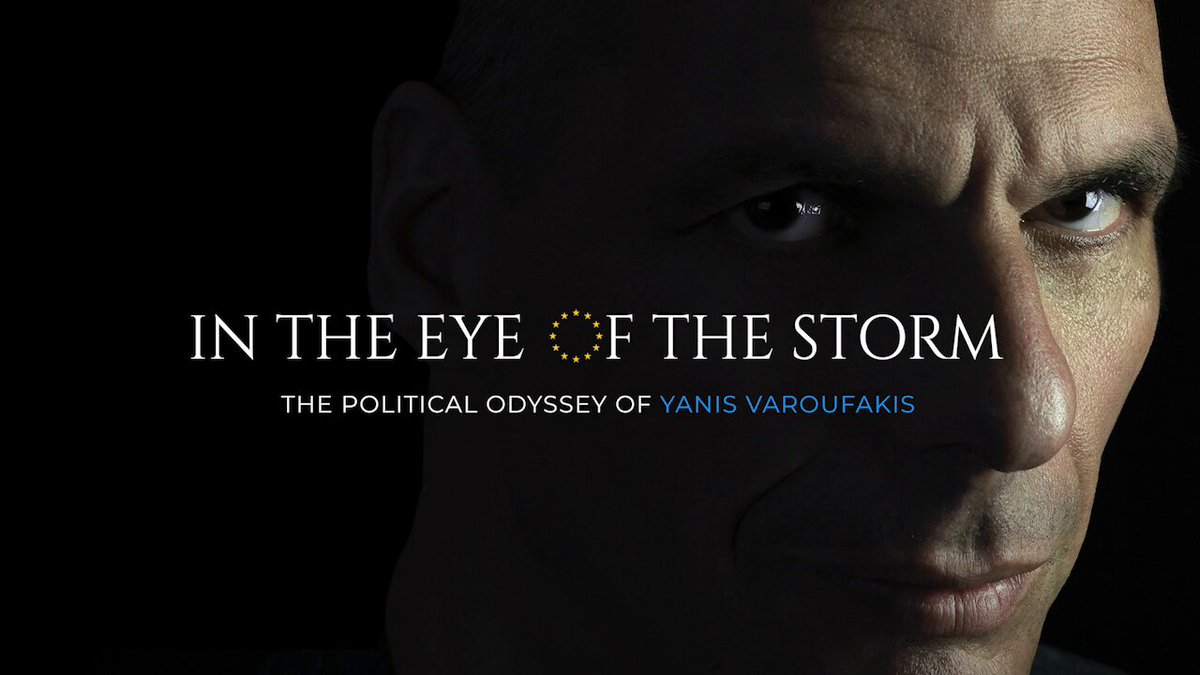Storia del cinema – Parla Mario Monicelli
di Orio Caldiron
Nel cinema italiano nessuno più di Mario Monicelli evita la retorica e pratica l’autoironia. Se lo incontrate vi accorgete che a 88 anni ha la freschezza di un ragazzo e la lucidità di un saggio che ne ha viste di tutti i colori senza rinunciare al sorriso e, quando ci vuole, alla battuta fulminante. Viareggino, è figlio di Tomaso Monicelli, un importante giornalista di origine mantovana che prima del fascismo è stato direttore dell’Avanti! e del Resto del Carlino, drammaturgo e critico teatrale. Imparentato con i Mondadori, sino dagli anni di scuola è amico di Alberto, il figlio del grande Arnoldo. L’ambiente tra giornalismo, teatro, editoria ha indubbiamente avuto il suo peso nella formazione del giovane Mario.
Nel cinema, come aiuto-regista, sceneggiatore, regista, c’è da oltre 50 anni. Ha sperimentato tutti i generi, ma ha scoperto molto presto di avere una predilezione per il comico e la commedia, trovando il punto d’equilibrio tra il cinema d’impegno e il cinema commerciale, senza tradire le attese del pubblico.
Da solo o con Steno ha fatto alcuni dei più memorabili film di Totò, da Totò cerca casa (1949) a Guardie e ladri (1951) e Totò e Carolina (1953), inserendo il grande funambolo nel contesto realistico del dopoguerra: una scelta che sacrifica le potenzialità surreali dell’attore, ma ne fa un personaggio di toccante umanità.
SECONDO LUI, LE PRIME AVVISAGLIE DELLA COMMEDIA ALL’ITALIANA si possono trovare già nei film con Totò della fine anni quaranta e dell’inizio dei cinquanta, in cui la comicità si mescola al drammatico, i temi attuali sono visti con lo sberleffo intinto di amarezza. Ma ci vorrà ancora qualche anno perché la formula sia messa a punto. Nella complessa alchimia del genere forte del nostro cinema, il ruolo di Mario Monicelli è fondamentale. È considerato con pochi altri uno dei padri fondatori della commedia all’italiana, che fa propria la sfida del neorealismo, di conoscere e fare conoscere il “bel paese”, mostrando anche i lati peggiori, i difetti più vistosi, le segrete debolezze degli italiani, ma riuscendo a stabilire il forte rapporto con il pubblico delle sale che al cinema d’impegno era clamorosamente mancato. Sono film come I soliti ignoti (1958), La grande guerra (1959), L’armata Brancaleone (1965), Amici miei (1975), che decretano il successo internazionale della commedia senza lieto fine, amara e grottesca, un ricamo di invenzioni narrative, ma anche di abilità di attori, che ha la forza di un pugno in faccia. Non sono pochi i registi americani, dal mago Billy Wilder amabilissimo Martin Scorsese, a confessare in varie occasioni di avere studiato con grande attenzione i capolavori di un genere inimitabile come la commedia all’italiana, che ha imposto l’immagine del nuovo cinema italiano nel mondo. Nella sua casa romana, il 13 febbraio di quest’anno, abbiamo parlato con Mario Monicelli per quasi tre ore, senza formalità, con la schietta immediatezza e la puntualità di riferimenti che gli è abituale. Ma i suoi rapporti con la società italiana del «secolo breve» sono talmente intensi e sfaccettati che, alla fine, ci sembra di avere appena cominciato a scalfire un percorso straordinario che va dallo scenario del fascismo anni trenta agli slanci utopici del dopoguerra, dalle commedie con morti come La grande guerra agli anni di piombo di Un borghese piccolo piccolo, dove la tentazione del «giustiziere della notte» innesca una spirale agghiacciante. Se gli dite che con Speriamo che sia femmina (1985) ha dimostrato di capire le donne, di trattarle alla pari e non come cittadine di serie b, Monicelli quasi si arrabbia e vi ricorda di avere fatto film ancora più femministi come La ragazza con la pistola (1958) e Romanzo popolare (1974); nei quali la donna si sottrae allo stereotipo di sedotta pronta alla vendetta o di oggetto del desiderio conteso da due uomini, con un rovesciamento di posizioni attraverso cui si riappropria della sua libertà di scelta. Un altro aspetto del mosaico di speranze e di contraddizioni, di tensioni e di inquietudini in cui la commedia ha saputo scavare per restituirci un ritratto impietoso della nostra società.
IL CINEMA MUTO NON ESISTE. «Sono nato nel 1915 e quindi ho l’età per avere visto il cinema muto. Dal ’20 al ’30 ho visto moltissimi film, ma non ricordo di averne mai visto uno muto. Ho un ricordo della mia fanciullezza legato alla sala sempre strapiena, traboccante, con la gente seduta ovunque. Si gridava, ci si chiamava. Gli spettatori piangevano, singhiozzavano, ridevano, si agitavano. Anche nei silenzi la sala vibrava. Senza parlare dell’accompagnamento musicale del pianoforte che non ci dava requie. Non c’era insomma quel silenzio di cui si parla. Non ho mai visto un film completamente muto. Da bambino vedevo soprattutto quelli americani. Il mio eroe era Tom Mix, ma mi piaceva molto anche Douglas Fairbanks. Avevo una predilezione per i film d’azione e d’avventura, mi annoiavo con i film romantici, d’amore. Ma mi esaltavo ai film di Ridolini, aspettavo con ansia il momento delle comiche, da cui ho imparato il gusto della farsa, che è difficilissima da fare. Non mi dispiacevano le attrici famose come Mary Pickford, anche se trovavo più affascinante Vilma Banky. La diva italiana che ricordo meglio è Leda Gys. Più tardi abbiamo cominciato a frequentare i cineclub, a scoprire i grandi film sovietici. Io e i miei amici eravamo molto presi dal cinema francese tra le due guerre, dai film di Carnè, di Duvivier e Renoir. Ci sembravano molto più coinvolgenti dei film italiani. Mi piaceva moltissimo l’attore Michel Simon, i suoi gesti esagerati, la sua mimica irripetibile».
I RAGAZZI DEL PASSORIDOTTO. «Il primo premio della mia vita l’ho avuto nei 1935 con I ragazzi della via Paal alla Mostra di Venezia. Non la grande mostra del cinema professionale, ma il concorso del passo ridotto che le era abbinato. L’avevo fatto con Alberto Monda- dori, Alberto Lattuada, Cesare Civita, lo stesso gruppo con cui l’anno prima nella cantina di casa Mondadori era avvenuto il nostro debutto con Il cuore rivelatore dal racconto di Edgar Allan Poe, suscitando scalpore ai Littoriali della cultura. C’erano gare di letteratura, di pittura, di atletica e anche di cinema. Gli studenti universitari vi partecipavano con brevi film a 16 millimetri. Negli ultimi anni di liceo e nei primi dell’università, che io viareggino ho fatto a Milano, con Alberto Mondadori e gli altri pubblicavamo anche una piccola rivista, Camminare, dove io scrivevo di cinema prendendo di mira soprattutto i film italiani. Il premio veneziano non consisteva in statuette e cavallucci, ma nell’essere inseriti subito nel set di un film normale ed entrare nella produzione vera. Magari come decimo assistente, quello che va a prendere le sigarette. Ma era un modo di iniziare. Ho cominciato così, facendo prima l’assistente e poi l’aiuto, dal 1935 fino al 1940, quando mi hanno chiamato sotto le armi».
LA PRIMA LEZIONE. «Il primo film in cui faccio l’assistentucolo è Ballerine, girato a Tirrenia, un posto bellissimo sul mare, con grandi teatri, grandi spazi. Il regista era cecoslovacco, Gustav Machat, famoso per Extase, presentato a Venezia un paio d’anni prima con grande scandalo. Era un matto, un personaggio strambo, stravagante, isterico. Un po’ lo era, un po’ ci faceva. Si era portato con sé il direttore delle luci, il montatore, tutta una piccola troupe di sua fiducia. A me piaceva molto perché pensavo che il regista dovesse essere un demiurgo, un po’ folle, ispirato. Il secondo film in cui mi ritrovo è Squadrone bianco di Augusto Genina, un’avventura oltremare ambientata in Libia, nel deserto vicino a Gadamez. Siamo stati quasi due mesi in un fortino diroccato e poi abbiamo girato qualche interno a Roma. L’incontro con Genina l’ho vissuto all’inizio come una delusione. Era remissivo, tranquillo, non si arrabbiava mai. Se il direttore delle luci gli proponeva di fare un’inquadratura in un certo modo, l’accettava senza tanti problemi. Lo stesso se un attore gli chiedeva di modificare una battuta. È stata la mia prima, grande lezione. Quando nell’inverno uscirono insieme Ballerine e Squadrone bianco cominciai a capire cosa fosse il cinema. Ballerine era una vera stupidaggine, una cosa del tutto sconclusionata che non stava in piedi nonostante i preziosismi fotografici e le manie formalistiche di Machat. Squadrone bianco invece fu uno dei pochi film italiani che ebbe un certo successo anche all’estero, perché era girato dal vero, con il deserto, i soldati, gli scontri. C’era un’aria di verità insolita nel nostro cinema. Genina era uno che sapeva il fatto suo. Da allora imparai a diffidare dei registi esaltati, ispirati dal demone della creazione, e a dare più fiducia a quelli tranquilli, esperti, disponibili, che ascoltano chi hanno intorno».
SE LA TROUPE È UNA FOLLA. «Facendo l’assistente e poi l’aiuto continuo a curiosare nel mondo del cinema, guardo quello che fanno i registi e cerco di imparare. Ho lavorato parecchio con Giacomo Gentilomo, bravissimo e misconosciuto. Da lui ho appreso molto perché veniva dal montaggio e girava pensando già a come avrebbe dovuto essere il film finito. Ho lavorato con Mario Camerini in Il documento e in altre occasioni. Era un maestro: nel linguaggio e nel modo in cui trattava la macchina da presa. Sapeva dirigere gli attori. Aveva le idee chiare, era una persona seria. Avendo fatto lo sceneggiatore, come regista girava anche lui in funzione del montaggio. Ho imparato molto da lui. L’altro grande dell’epoca era Alessandro Blasetti. Era una sorta di capitano di una nave, con la visiera, i famosi stivaloni, l’andatura solenne, autorevole. Sapeva quel che voleva e voleva cose maestose, grandi. Aveva una sua megalomania, ma diresse film importanti. Era uno che conosceva bene il suo mestiere. Era un grande entusiasta, spesso più travolgente del necessario. C’era comunque da imparare anche nella conduzione della troupe, che poteva essere composta da 50 ma anche da 700 persone. Bisogna avere la capacità di governare questa folla che ti sta intorno. E nel governare lui era bravissimo. Anche da lui ho imparato molto. Ma forse, alla fine, ho imparato più dai cattivi registi che da quelli bravi, perché dai cattivi capisci ciò che non devi fare e questo è già un grande passo avanti».
SI FORMANO I QUADRI. «Quando dal ’39 non arriva più il cinema americano, da noi si comincia a produrre molti più film di prima. È il periodo in cui si formano i quadri, che sono importantissimi: gli aiuto-registi, gli scenografi, i truccatori, gli addetti alle luci, gli attori. Sono i quadri che hanno fatto la fortuna del cinema italiano anche nei decenni successivi. La mia generazione è cresciuta sotto il fascismo. Ma il cinema è sempre stato in qualche modo di sinistra. Già nei primi anni quaranta era antigovernativo. In realtà il fascismo non ti spingeva a fare film di propaganda. Se ne contano pochi, a differenza di ciò che succedeva in Germania, dove se ne facevano a getto continuo. Certo, c’era la censura. Una censura preventiva con pruriti e ossessioni molto cattoliche; in Italia non si poteva neppure parlare di adulterio. E allora si ambientavano le storie in Francia e in Ungheria. Soprattutto in Ungheria, dove si era liberi di immaginare vicende più audaci, scollacciate, con personaggi femminili più disinvolti. Naturalmente non si andava mai in Ungheria. Si girava tutto a Roma nel quartiere Coppedè, che era diventato la nostra Budapest».
QUELLA VOLTA AL CSC. «Nel cinema non avvertivamo tutta l’influenza del fascismo che ci si poteva aspettare. Anche se c’erano registi fascistissimi come Giovacchino Forzano, che dirigeva gli stabilimenti Pisorno di Tirrenia. Sono stato a scuola con suo figlio Giacomo e ho avuto occasione di incontrarlo, anche se nei teatri di posa non si vedeva mai. Non si capiva chi facesse veramente i film che firmava. Era pieno di idee, di impegni, di cose da fare, stava sempre a Roma e alla fine sul set ci stava pochissimo. Era molto amico di Mussolini e con lui aveva anche scritto per il teatro Villafranca e Campo di maggio, dai quali aveva ricavato i film omonimi.
Il solo rapporto che ho avuto con un’istituzione del regime, oltre ai Littoriali della cultura, è stato con il Centro sperimentale di cinematografia, che doveva essere nato da pochi anni. Una volta mi presentai con Carlo Cassola e Manlio Cancogni per vedere se ci prendevano. Erano miei grandi amici, volevano fare i giornalisti, gli scrittori. Ma il cinema li interessava molto. Ci fanno entrare nell’ufficio di Luigi Chiarini, che dirigeva il Centro con la sua divisa d’orbace e la testa pelata che faceva concorrenza a quella del duce, e gli presentiamo un filmatino in 16 millimetri fatto alla meglio da noi tre. Era una cosa folle, c’era persino un nasone finto che usciva da un cespuglio. Era una cosa tra lo scherzoso e il fantastico, decisamente troppo carnevalesca. Chiarini ci trattò male. Ci disse di ripassare quando avremmo avuto le idee più chiare».
C’ERA MOLTA LIBERTÀ. «L’Italia dopo la guerra era un cumulo di macerie, ma c’era anche tanta libertà. Eravamo tutti liberi, dal macellaio al tranviere al pittore, fino a noi che facevamo il cinema. Eravamo tutti felici di vivere, di affrontare la ricostruzione. Non ci importava di essere malnutriti, mal alloggiati. C’era proprio la sensazione di scavalcare un’epoca, di appartenere a qualcosa di nuovo, di importante, anche se poi tutto ciò si è perso. Ci sentivamo tutti così, anche i giornalisti, gli scrittori con i quali ci si incontrava spesso. C’era la trattoria Menghi, dove si ritrovavano soprattutto pittori, scenografi e anche cineasti; e poi c’era Otello, a via della Croce, dove andava gente come Age, Scarpelli, Pontecorvo, Germi. Qui ti facevano credito, pagavi quando lavoravi.
Alla fine della guerra eravamo convinti che il cinema americano ritornasse alla grande e invece Hollywood perse molto. Roma città aperta di Roberto Rossellini aveva spalancato una porta attraverso cui passa un modo nuovo di fare cinema. Gli attori si prendono dalla strada e dall’avanspettacolo, una miniera inesauribile. Le storie, più o meno divertenti, si inventano attingendo dall’attualità e cercando la collaborazione degli amici che scrivono sui giornali umoristici come Bertoldo e Marc’Aurelio. Si lavorava moltissimo con Steno e con altri. Sceneggiavamo di tutto, dai film comici per Macario diretti da Carlo Borghesio ai film avventurosi per Riccardo Freda, un tipo stravagante e intelligente, ai melodrammoni per Raffaello Matarazzo, un sedentario sempre pieno di dubbi che avrebbe preferito scrivere. L’avventura della regia in coppia con Steno comincia con Totò cerca casa. L’avevamo appena finito di sceneggiare per Carlo Ponti e non si trovava il regista. «Perché non lo fate voi?», ci dice Ponti. È cominciata così, con un film che se vogliamo è già una commedia all’italiana su un tema come la crisi degli alloggi non proprio da ridere, che anzi contiene aspetti drammatici, ma può essere visto con una vena umoristica.
La straordinaria libertà del dopoguerra era finita con le prime elezioni e la vittoria democristiana. Il cinema ha bisogno di libertà e invece si trovava a combattere con la censura. Quando con Steno facemmo Guardie e ladri fu una lotta perché il fatto stesso che una guardia e un ladro simpatizzassero, che le loro famiglie si frequentassero, era inammissibile. Sembrava avessimo fatto chissachè. Con Totò e Carolina andò ancora peggio, figurarsi, perché lì c’è il poliziotto che aiuta la ragazza di vita, rifiutata da tutti, dalla sua stessa famiglia. Dovemmo subire tantissimi tagli. Ogni riferimento all’arma, al socialismo, al comunismo era censurato, ogni cosa sembrava una specie d’assalto al Palazzo d’inverno. Poi però tutto il cinema, facendo scioperi, marce, sit-in, si è imposto. Alla fine siamo riusciti a venirne fuori. La commedia all’italiana è nata proprio contro i tabù, le resistenze tradizionaliste, la religione più bigotta, l’ossessione della verginità, il delitto d’onore. Soltanto con il ’68 si arriverà finalmente a un profondo rinnovamento del costume, alla rivoluzione sessuale».
GLI ABBIAMO CAMBIATO LA FACCIA. «Quando con Steno decidemmo di separarci, i produttori non volevano perché, con noi insieme, si sentivano più sicuri, ormai eravamo una coppia supercollaudata. Ma alla fine l’abbiamo spuntata. Tra i miei primi film da solo ricordo Padri e figli e Il medico e lo stregone, entrambi con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni. Lavoravo bene con De Sica perché conosceva profondamente il lavoro del regista. Anche Marcello era uno che stava lì tranquillo, si preoccupava solo di sapere dove si andava a mangiare. Aveva la sua teoria personale di non studiare troppo il personaggio, leggeva sì la sceneggiatura, ma sul set non faceva troppe prove, aveva paura della routine. Si ricordava tutto. Si provava due, tre volte e basta, riprovare di più lo peggiorava. E anche durante la lavorazione si battevano pochi ciak sempre per la stessa ragione, perché rischiava la routine e allora si annoiava.
Subito dopo mi sono molto divertito a fare I soliti ignoti, una specie di film riassuntivo in cui c’erano tutti: Totò, Gassman, Mastroianni, Salvatori e Carotenuto, che veniva dall’avanspettacolo. La lavorazione fu lunga, più di un anno, perché Gassman era impegnato in teatro. All’inizio la produzione non lo voleva perché era troppo intellettuale e al cinema risultava antipatico. Gli abbiamo dovuto cambiare i tratti del viso fino a farne un sottoproletario, un pugile sfortunato un po’ sopra le righe.
Abbiamo vinto la scommessa. Alla fine dicevano tutti che era bravissimo anche nel comico. Quando Peppe er pantera, con tutte le arie che si dà non riesce a farsi capire perché zagaia, è irresistibile».
BASTA CON LE BUFFONATE! «Germi l’ho incontrato sul set di Il testimone, il suo primo film. Aveva fatto il Centro sperimentale, era giovane, il suo riferimento era Blasetti che lo stimava molto. Mi chiamarono perché il regista esordiente avesse accanto un aiuto-regista sperimentato, ormai ero un veterano. Ma ben presto mi accorsi che non aveva affatto bisogno di essere aiutato. Era molto chiuso, introverso, taciturno, interveniva poco sia durante la scrittura sia quando girava. Ma era attivo, stimolante. Mi ricordo che lo spingevo a girare film comici, a farla finita con quel Raf Vallone inquadrato dal basso; gli suggerivo di fare film più sciolti, che facessero ridere, ma lui pensava che fossero troppo superficiali. Ricordo una litigata da Rosati, con Germi che si allontana in campo lungo in piazza del Popolo gridando: «Basta con le tue buffonate!».
Quando finalmente si è deciso a fare Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata, si è visto quale contributo originale ha portato alla commedia all’italiana. Litigavamo, discutevamo, ma eravamo molto amici. Ci vedevamo anche quando non si lavorava. Verso le cinque del pomeriggio ci ritrovavamo in qualche osteria a bere un bicchiere di Frascati. Quando doveva girare Signori & signore, gli era appena morta la moglie e non voleva più farlo. Mi chiamò perché voleva che lo sostituissi. Il film era pronto e lo convinsi a realizzarlo. Quando invece stava male e mi propose di fare al suo posto Amici miei, accettai. Le storie mi erano familiari, conoscevo personalmente anche i personaggi ai quali erano attribuite, perché erano storie e personaggi toscani. Allora c’era il tabù per cui non si potevano fare film comici usando il toscano. Era considerato troppo aggressivo, poco simpatico. Germi, che era anche il produttore del film, voleva infatti girarlo a Bologna. Gli proposi di ambientare tutto in Toscana e lui acconsentì. Era ridotto malissimo, morì il primo giorno delle riprese a Firenze».
È IMPORTANTE ANCHE LA SCONFITTA. «Si sa che ho un debole per I compagni, anche perché ha molti punti di contatto con La grande guerra. Volevo mettere insieme un gruppo di sprovveduti che tentano un’impresa più grande di loro. Fanno di tutto, ma l’impresa fallisce e così nasce la commedia. C’è un misto di comico e di drammatico. Ci sono gli operai anziani, ma anche quelli giovani e dove c’è gioventù c’è comicità. Racconto uno sciopero come non si era mai raccontato prima. Al cinema si erano visti sino ad allora gli operai dal volto cupo e dallo sguardo severo. La storia era sempre la stessa. L’operaio si innamorava della figlia del proprietario delle ferriere, deciso a contrastare il rapporto. A me interessava invece la nascita dello sciopero, l’occupazione delle fabbriche che era profondamente rivoluzionaria, mi interessava com’era organizzato il lavoro negli ultimi anni dell’ottocento.
Il professor Sinigaglia, il personaggio interpretato da Marcello Mastroianni, non è un proletario ma un borghese, un ebreo, un organizzatore di scioperi. A questo gruppo di sbandati insegna che lo sciopero può anche andare male, ma rimane comunque un momento di forza, che un giorno porterà alla vittoria, nonostante la sconfitta momentanea. Andare alla rovina fa parte della loro storia, va accettato come qualcosa di positivo. I compagni è andato malissimo, con quel titolo sembrava un film di propaganda. Cadeva poi in un momento sbagliato, quando nasce il centrosinistra e i socialisti si staccano dai comunisti per andare ai governo con i democristiani. All’epoca non piacque neppure agli operai. Ma andò benissimo negli Stati Uniti. E mi ha ripagato dopo, nelle occasioni in cui è stato presentato».
GLI ANNI DIFFICILI DELLA PAURA. «Negli anni settanta con Un borghese piccolo piccolo, tratto dal libro di Vincenzo Cerami, ho fatto uno dei film più difficili della mia carriera. Era l’epoca dei “giustizieri della notte”, dei film americani che esaltavano i cittadini che si fanno giustizia da soli. Volevo fare un film contro un clima del genere che si stava diffondendo anche in Italia e per questo avevo bisogno di un attore che fosse molto amato dal pubblico. Sordi non lo voleva fare perché gli piaceva essere simpatico, popolare e temeva di incrinare la sua immagine. Sordi è un mostro di bravura, è uno dei più grandi attori della storia del cinema. È stato talmente bravo nell’interpretare un personaggio così difficile che la trasformazione del padre di famiglia in assassino, la deriva verso l’orrore, è colta così bene da fare paura. Quando il primo ragazzaccio in cui si imbatte gli dà una risposta che non gli piace, lo insegue per eliminarlo. La commedia diventa nera, nerissima. Il film è meno ambiguo di quello che dicono perché Sordi sapeva fare bene anche l’attore drammatico, com’era avvenuto in La grande guerra quando si fa ammazzare gridando. Era uno stato d’animo difficile da capire, un vigliacco come lui, un cialtrone che non dice il segreto gridando: “Non lo dico perché sono un vigliacco, sennò lo direi”, e poi non lo dice. Non so chi avrebbe potuto farlo meglio».
* * *
A DISPETTO DEI SANTI: LA GRANDE GUERRA
La grande guerra nasce da un soggetto scritto da Luciano Vincenzoni che dice di averlo tratto da un racconto di Maupassant. Il soggetto era stato acquistato da Tonino Cervi, che lo cedette a Dino De Laurentiis, il quale chiamò me. Ci conoscevamo, avevo già lavorato con lui. Nessun problema con i protagonisti, perché avevo in mente di prendere due attori di commedia e Dino aveva pensato di mettere in coppia Sordi e Gassman. Ma io volevo che gli sceneggiatori fossero Age e Scarpelli, assieme a Vincenzoni. Dino fece inizialmente resistenza. C’era poi il fatto della commedia con i morti. Nella commedia all’italiana ci devono essere i morti, non ci deve essere il lieto fine. La cosa stupisce gli stranieri che non capiscono come sia possibile una commedia senza lieto fine, come si possa ridere di morti e funerali. Invece in Italia si fa, da sempre si ride solo su questo. Da Plauto in poi si ride solo di truffe, infamie, morti, imbrogli, fame, miseria, malattie. Fa parte di noi. Da Arlecchino in poi c’è sempre stata l’arte di arrangiarsi, di truffare, di salvare la pagnotta. Questa è la nostra comicità, ce l’abbiamo nel sangue.
Il film va in porto, un film di morte e di risate, che inconsciamente volevo fare da quando ero bambino, da quando ho visto La grande parata di King Vidor, un film di guerra con momenti comici, umoristici. Mi aveva colpito perché non c’erano assolutamente eroi. All’epoca di La grande guerra non me lo ricordavo più, mi è venuto in mente dopo, in vecchiaia capii perché avevo fatto quel film dove c’erano i morti, la fame, il freddo, con due poveracci che venivano fucilati. Ma erano due ragazzi, e i giovani quando stanno insieme scherzano, litigano, si divertono. La gioventù e l’incoscienza devono venire fuori anche in guerra.
La prima guerra mondiale era però un mito. Quando scoppiò gli italiani si precipitarono da Trapani a Trieste per parteciparvi. E ci furono 600 mila morti. Le reazioni cominciano prima dell’uscita del film, all’inizio della lavorazione. Su La Stampa esce un violentissimo articolo di Paolo Monelli che invoca la censura preventiva per un film «scandaloso» e «dissacratore». Su Il Giorno gli fa eco Gaetano Baldacci. La polemica finisce in parlamento. L’idea che un gruppo di sciagurati, che fino a quel momento aveva fatto solo commedie, osasse occuparsi della grande guerra faceva arrabbiare molta gente. Solo l’incontro di De Laurentiis con Andreotti sembra risolvere il problema e dare il semaforo verde all’operazione. Ma quando faccio i sopralluoghi scoppia un’altra grana: se prima erano stati i giornali a tuonare contro di noi per impedire lo scempio di un film poco patriottico, ora sono i sindaci e l’esercito a ritirare la propria disponibilità. Ma la minaccia di andare a girare in Jugoslavia convince il ministero della difesa a concedere il nulla-osta. Il film viene girato in Friuli tra la primavera e l’estate.
Nel lavoro di sceneggiatura c’eravamo serviti soprattutto di due libri che erano in linea con la nostra intenzione antiretorica, cioè Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu e Con me e con gli alpini di Piero Jahier. Mi sentivo in colpa nei confronti di Lussu, da cui avevamo rubato qualche spunto. Andai personalmente da lui, che era molto incuriosito di tutta la faccenda e mi diede senza problemi il consenso a servirmi del suo libro, mentre la moglie mi cacciò via, infastidita dalle richieste di questo buffone della commedia all’italiana. Spesso le mogli degli intellettuali sono più realiste del re.
La grande guerra andò benissimo. Il pubblico ci seguì in questo modo nuovo di guardare alla storia del nostro paese. L’idea di raccontarla senza tabù, senza esaltazioni, senza mitologie si riproporrà con L’armata Brancaleone, con cui rappresentammo addirittura un medioevo fatto di cialtroni e di miserabili. Scrissero di tutto, non ce lo perdonarono molto facilmente. Quando andavamo nelle scuole i professori contestavano il film, ma gli studenti applaudivano con grande entusiasmo».
Millenovecento, n.5 marzo 2003, pp. 86-95