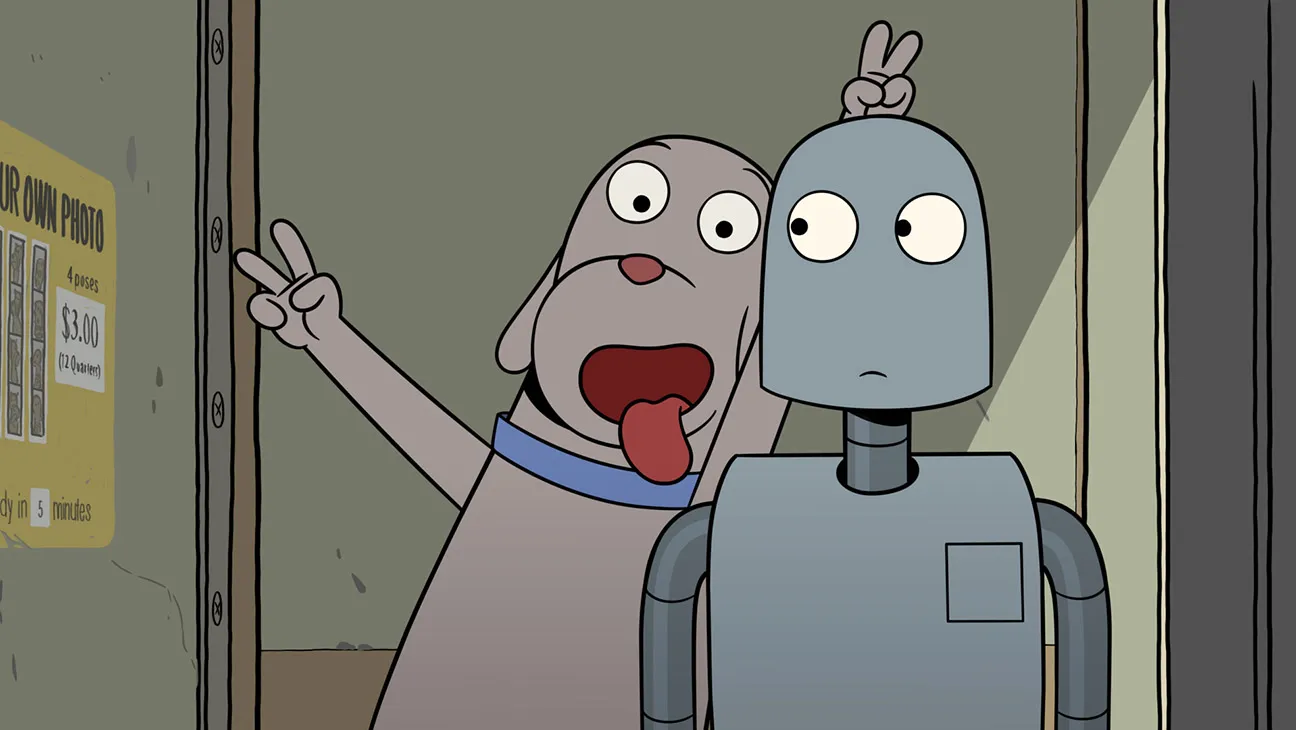di Gualtiero De Marinis
La storia
C’è un patto di non aggressione tra la polizia e gli «anziani» della comunità cinese di Chinatown. Ma quando al posto dell’opimo William McKenna arriva l’agile Stanley White le cose cambiano. Anche perché contemporaneamente il giovane Joey Tai sta tentando la scalata al potere della mafia cinese. Per questo fa uccidere l’«anziano» Jackie Wong e organizza una spedizione punitiva nel ristorante di un altro «anziano», nel quale White sta cenando con la giovane giornalista televisiva Tracy Tzu.
White cerca di convincere Tracy ad aiutarlo contro la mafia cinese, ma la ragazza è indecisa. White che ha già non pochi guai con la moglie decide di trasferirsi da lei e la costringe ad avere una relazione con lui. Ma i guai di White non stanno tutti qui: la sua ostinazione, l’arbitrarietà dei suoi metodi lo mettono immediatamente in contrasto con i suoi superiori, isolandolo.
Quando Tai, che ha compiuto un breve viaggio in Tailandia per contrattare l’acquisto di una partita d’eroina, gli fa uccidere la moglie, la lotta diventa personale e ancora più maniacale.
White riesce a infiltrare un poliziotto cinese nel locale di Tai. Il poliziotto va regolarmente incontro alla morte, ma non senza aver pronunciato in punto dì morte il nome della nave che porta il carico.
È quindi sui dock del porto che si consuma il duello finale che vede soccombere Tai.
* * *
Notizie d’agenzia ci rivelano che la comunità cinese in America ha fatto fuoco e fiamme contro il film. Ma non si capisce mai se si tratti di agenzie giornalistiche o di agenzie di stampa della produzione, secondo un trucco vecchio quanto il cinema, se è vero che già nel 1915 la Epoch Producing Corporation aveva accuratamente preparato l’uscita a Boston (dopo la prima insoddisfacente di Los Angeles) di Nascita di una nazione in modo da far leva sui risentimenti razziali. Ci abbiamo messo molto a capire che, per quante infamie quel film contenesse, si trattava comunque di una tappa fondamentale della storia del cinema (1). Il cinema americano successivamente avrebbe lasciato in pace i neri per prendersela invece con gli indiani, con i giapponesi e con i comunisti. Tutti soggetti muti a cui far sopportare la nevrosi d’onnipotenza dell’occidentale bianco civilizzato, in un circuito narcisistico di pura riconferma di sé.
Il guaio è che oggi non esistono più malcapitate, inconsapevoli categorie capaci di mimare l’esistenza fittizia dell’Altro. Ora che gli indiani sono stati sterminati, i comunisti non sono più facilmente caricaturabili come un tempo (lo fa soltanto Milius, ma Milius è da ricovero) e i giapponesi producono la metà dei videoregistratori venduti negli States, dove andare a pescare quel supporto incolpevole a cui agganciare le nevrosi di padronanza del bianco occidentale?
Si può provare con i vietnamiti (sono pur sempre musi gialli): lo ha fatto Ted Kotcheff in Fratelli nella notte, lo fa l’ultimo Rambo, ma anche qui si va poco lontano. Un po’ perché i vietnamiti non hanno perso e non sono stati sterminati e un po’ perché, come aveva già scoperto Cimino nel Cacciatore, i vietnamiti non solo uguali ai cervi. Ovvero non sono un soggetto muto, una comparsa, bensì sanno ritornare quello sguardo lanciato in un circolo narcisistico, infrangendo la circolarità, rompendo lo specchio.
Gli americani non esistono
Nel cinema americano (a parte The Deer Hunter che semmai parla di una sconfitta) si ha sempre l’impressione che le guerre si vincano in due, in tre al massimo se c’è un’infermiera innamorata del protagonista. In realtà quello che manca non è tanto un esercito, ma è il nemico. Non si lotta mai contro nessuno, ma all’intemo di se stessi. Ogni delirio di padronanza è una messa alla prova dell’unità del soggetto con lo scopo evidente di rafforzarne le certezze narcisistiche. Una prova fittizia (si scherza sempre col pericolo sapendo bene di essere intangibili: è così che capita al cinema) che serve a riconfermare quelle certezze che vanno sotto il nome altrettanto fittizio di democrazia, civiltà, amicizia, lealtà, ma che in realtà sono solo i puntelli su cui il soggetto sta in piedi. Da questo punto di vista la persistenza di film come Rambo è la misura esatta del misconoscimento a cui Il cacciatore è stato sottoposto.
Allora dove trovare questo soggetto muto, questo prestanome che si presti docilmente al gioco? La soluzione non solo non è facile, ma piuttosto non esiste. Perché ci sia una discriminazione è necessario un soggetto integro capace di discriminare. Insomma perché ci siano dei neri è necessario che ci siano dei bianchi e che questi siano sicuri di esserlo. Cimino scopre, ha già scoperto con Heaven’s Gate che gli americani non esistono. È la stessa scoperta che fa Wenders quando, dopo averli usati per un’intera adolescenza per tappare un buco di storia pluriennale del proprio Paese, va a trovarli in America, non li trova e non sa più cosa fare. Cimino scopre, ha già scoperto da tempo, già da quella lussuosa carcassa, da quello splendido troncone morto che è I cancelli del cielo, che esistono gli immigrati polacchi, russi, tedeschi, quindi gli ebrei, gli italiani, i cinesi, i portoricani, ma non gli americani. Ovvero che il mito del melting pot, del crogiuolo di razze che miracolosamente si sarebbero unite nel nome dell’ideale superiore della nazione americana non esiste più; peggio, non è mai esistito. Con Heaven’s Gate Cimino mostra come la storia americana non sia stata altro che una guerra per bande, una lotta fra diversi clan.
Heaven’s Gate è un episodio d’intolleranza alla nascita di una nazione. The Year of the Dragon è la lotta tra un uomo di un clan contro un uomo di un altro clan. Se cioè nei film precedenti esiste ancora una retorica di gruppo, un’esaltazione dell’amicizia virile, nell’Anno del dragone tutto si riduce alla solitudine di due uomini in lotta tra loro. E col mondo.
Il primo è cinese, ha un nome proprio occidentale, Joey, e un cognome orientale, Tai. Il secondo è polacco, si chiama Stanley White, ma è un falso nome con cui s’è affrettato a dichiarare la sua appartenenza alla razza, in realtà si chiama Wyzinsky. Cosa stiano a fare in America lo sa solo il cielo.
Lui e lui
Il fatto che Tai sia un mercante d’eroina della mafia cinese e White sia un poliziotto (il più decorato della città) dice quasi tutto della trama di questo che è per molti versi un «semplice» film d’azione. Ma con qualche particolarità.
White accusa Tai sulla base di un sapere che non si fonda su nulla (2), che sembra non avere bisogno di prove. Anche il carico d’eroina (l’unico resto tangibile dello scontro) stivato nel ventre di una nave maternamente polacca rimane fuori dalla narrazione: non lo vedremo mai.
In qualche modo White sceglie Tai. In nome di cosa cominci a perseguitarlo, faccia intercettare le sue telefonate, infiltri un poliziotto nel suo locale, è difficile dire. Non di certo dell’ordine: «Voglio che creiate il caos» dice ai suoi uomini; né in nome di una Legge da far rispettare o di una gloria personale da guadagnare agli occhi degli altri (i suoi superiori lo vedono come il fumo negli occhi, sono convinti di avere a che fare con un pazzo). Resterebbe l’ipotesi dell’ansia di giustizia personale (che s’avvalora quando Tai manda ad uccidergli la moglie) che, se vera, non spiega comunque il furore maniacale e l’arbitrarietà con i quali White si getta fin dall’inizio nell’impresa.
White è reduce dal Vietnam (anche lui!) dove è rimasto sconfitto senza — dice lui — aver mai visto in faccia il nemico. E adesso, a Chinatown, si inventa un’altra guerra, si sceglie un nemico, ma solo dopo essersi assicurato che questo avesse un corpo e uno sguardo. È Tai il suo nemico (per quanto innocente o colpevole possa essere), è lui il suo Doppio. Entrambi sono uomini di un clan. Entrambi sono malvisti dalle rispettive organizzazioni. Entrambi si muovono secondo logiche non conservative, bensì micidiali, autodistruttive, imprevedibili. Se appartenessero ad altri clan sarebbero dei terroristi. L’uno vuole bruciare le tappe dell’organizzazione mafiosa, l’altro vuole ripulire Chinatown. Ma è poco più che una scusa. In realtà sono entrambi dei disadattati, degli ingranaggi illogici. In realtà ciò che vogliono fare è misurarsi e guardarsi negli occhi.
E se Tai è fin dall’inizio restio a concedersi al gioco, sta sulla difensiva, fugge e si lascia braccare, White non molla la preda fino alla fine, fino alla classica sparatoria finale in cui Joey non scappa più, ma corre incontro al suo doppio come ad uno specchio, in cui sono le mani di Joey e la pistola di Stanley a dare il colpo di grazia.
È ciò che capita quando Michael e Nick giocano attorno alla stessa pistola alla roulette russa. È ciò che capita quando il cervo si ferma a restituire lo sguardo.
Gli altri
«Lascia stare, questa è Chinatown» dicono a J.J. Gittes nel finale del film di Polanski. Il cadavere della figlia incestuosa del patriarca Noah Cross non insiste più sul clascon della macchina. Nicholson si volta a va via.
Quando dicono una cosa del genere a Stanley White finisce a pugni, con Luis Bukovski, quello che ha un nome polacco e non l’ha cambiato. White sta cercando un proprio Vietnam di simulazione, un inferno: è proprio Chinatown che vuole. Da un certo momento in poi nulla vale più per lui: né l’affetto della moglie, né quello di Tracy Tzu, né tantomeno gli ordini dei superiori. White salta le buone maniere, ma anche le organizzazioni: quello che cerca è il corpo a corpo, non lo scontro tattico, la strategia generale.
Nella sua follia tutti risultano spersonalizzati, divengono poste in gioco nel duello con Tai. Dal poliziotto infiltrato che va incontro a morte sicura, al grasso aiutante che si becca un colpo in pancia senza fiatare (il film gli dedica una mezza inquadratura di sfuggita), dalla moglie che viene sgozzata nel bagno alla giornalista Tracy che, come avvertimento, viene violentata da tre uomini di Joey.
La solitudine di White è totale. E singolare che tra ì vari personaggi non si trovi nessuno disposto a dire di lui cose men che volgari. E si badi che non si tratta di banali personaggi di contorno (come potrebbe capitare in un film di Eastwood), ma di presenze antagoniste all’eroe che pretendono anche una partecipazione commossa da parte dello spettatore (cfr. il pregevole monologo ridente – piangente della moglie quando lo lascia).
Ciò che gli altri pensano di lui è facilmente immaginabile. Il meno che possano dire è che è pazzo. Che sia bastardo lo sa già: è americano.
Il tempo
Ci sono registi che fanno film brevi e altri che fanno film lunghi. C’è chi fa film inutilmente lunghi (vedi C’era una volta in America) e chi fa film strutturalmente, concettualmente lunghi. Cimino è costituzionalmente incapace di stare dentro i 90 minuti. La sua è una scrittura enfatica, seriosa, dove all’acutezza e alla velocità del montaggio a pezzi brevi si sostituisce la sontuosa, sorniona opacità del piano – sequenza. Sono numerosissime in questo film le scene girate in un unico piano, sono innumerevoli i dolly, le carrellate, i movimenti di scoperta, i movimenti in profondità, gli scambi tra primo piano e sfondo.
È questa variazione dei punti di vista in rapporto all’evoluzione dei personaggi a rendere centrale il problema della durata, del prolungamento enfatico, del preambolo rituale e propiziatorio, dell’accumulazione dei tempi. È così che i suoi film assumono cadenze poliritmiche, tempi spezzati, variazioni improvvise e scioglimenti repentini (vedi la placidità della sequenza che precede l’assassinio di Connie).
Da questo punto di vista L’anno del dragone è un film che presenta una disfunzione essenziale: è un film di oltre tre ore che ne dura due e un quarto. Non so se De Laurentis abbia imposto dei tagli in extremis o se Cimino, come il famoso scrittore Tullio Herrera (3), abbia evitato di «scrivere» certe scene nel timore di doverle «cancellare». Sta di fatto che al film mancano le scene di raccordo, quelle di contorno, i preparativi, le allusioni, manca insomma il respiro. Year of the Dragon sembra un film liofilizzato in cui ci sia tutto l’essenziale, ma in cui manchi l’aria tra le cose.
Cosa sappiamo del rapporto di Stanley con la moglie? Perché Bukovski dice: «lo conosco Connie da molto più tempo di te»? Che ruolo svolge la mafia italiana citata in due o tre punti apparentemente senza scopo? Erano vere o no le pretese amicizie del negoziante italiano che si fa sparare dopo cinque minuti di film? E infine cos’è la spinetta che White porta sulla cravatta, a cui accenna quando dice di essere polacco?
Curiosità forse inessenziali, queste. Ma che rimangono comunque inspiegate a meno di postulare altre sequenze tagliate via dall’edizione finale.
Sembra cioè che pur di farci entrare tutto (tutta la sceneggiatura) Cimino abbia «risparmiato» sui particolari. Ne risulta una narrazione a blocchi, perfettamente armoniosi al loro interno, ma disarmonici e ingombranti quando si considera il prodotto finale. Cimino, si sa, non è un buon diplomatico, in fatto di compromessi è un disastro e poi, l’avevamo già visto in Heaven’s Gate, non sa tagliare. In virtù di questo rimangono nel film tutti e soli i momenti forti, tutte le sequenze d’azione, le scene plateali (preziosissime tra le altre la parentesi tailandese, l’inseguimento delle due ragazze in discoteca e l’alba nell’appartamento di Tracy che effettivamente sta tra il Brookling Bridge e il Manhattan Bridge), ma manca l’acqua in cui farle nuotare. Insomma, se l’avessero tagliato di un’altra mezz’ora sarebbe diventato un buon telefilm.
Public relations
Certo che ci vuole del coraggio a scegliere Mickey Rourke per la parte di un poliziotto criminale, fervente cattolico (vedi il crocifisso e la foto del Papa in casa e le stimmate che si procura nel finale) e furiosamente monomaniacale. Rourke, che è la faccia più interessante uscita al cinema negli ultimi cinque anni, ha tutto meno che l’aspetto del pazzo che si lancia in una crociata. Alla sua aria placida e sorniona si devono tutte le cose più wendersiane di Rumble Fish. Eppure, per quanto miscasted, è proprio alla sua placidità, all’ironia del suo sguardo che si deve se il suo personaggio non sconfina definitivamente nel patologico. Cimino, va detto, non sempre ha il senso della misura, Rourke sì.
Alla fotografia non c’è più Zsigmond (e me ne dispiace), ma Alex Thomson, meno pastoso dell’ungherese, ma tutto sommato efficace. Chiamato ad un lavoro improbo (ogni set di Cimino è di una complicazione indescrivibile), oltre che ad una fotografia molto più sporca di quei lindi compitini che sono stati Excalibur e Legend, Thomson accondiscende essenzialmente ai desideri di Cimino dividendo il film tra la luce chiassosa e volgare di Chinatown, la luce più secca e netta della parentesi tailandese e quella morbida e azzurrata dell’appartamento di Tracy. Ma se non mostra molta personalità, la sua abilità come operatore di macchina è indiscussa. L’operatore al dolly invece si chiama Tony Cridlin e ha fatto gavetta con Kubrik. Normalmente non lo sarebbe, ma in un film del genere diviene un personaggio insostituibile. Cimino intanto sta lavorando ad un western (con soli indiani, senza un solo bianco) intitolato Conquering Horse oppure ad un film su Frank Costello: scegliete voi. Sono le solite, inutili interviste a dare notizie del genere che non combaciano mai perché se le inventano i giornalisti o perché sono i registi a divertirsi a dare delle notizie false. D’altra parte cosa potrebbero dire di originale e di diverso a 50 giornalisti nello spazio di 10 giorni? Delle balle!
All’epoca di Heaven’s gate Cimino (intervistato) aveva dichiarato di preferire la seconda versione (quella rimontata e più corta) alla prima. Oggi, sorridendo, agli intervistatori dei Cahiers confessa che non era vero.
Non c’è niente da fare, Cimino non ha proprio il senso delle public relations.
Note:
(1) Il riferimento è meno campato in aria di quanto appaia, giacché anche qui l’accusa è di razzismo. Del resto la leggenda ricorda che se è vero che fu Griffith assieme a Mary Pickford, Chaplin e Fairbanks a fondare nel 1919 la United Artists, è anche vero che Cimino nell’80 ha contribuito ad affondarla. A questo si potrebbero aggiungere la comune tendenza allo spreco, all’andare cioè fuori budget, la sfortunata e analoga sorte subita da Intolerance e da Heaven’s Gate ecc…
(2) cfr. L’échappée romanesque di Alain Manon, Positif 297, articolo peraltro ignobile che a partire da considerazioni del genere si lascia andare a desolanti luoghi comuni contro il cinema di Cimino.
(3) Si tratta dello scrittore inventato da Borges e Casares in Quel che manca non fa danno compreso in Le cronache di Bustos Domecq, Editorial Losada, 1967.
Cineforum n. 250, dicembre 1985, pp. 43-48