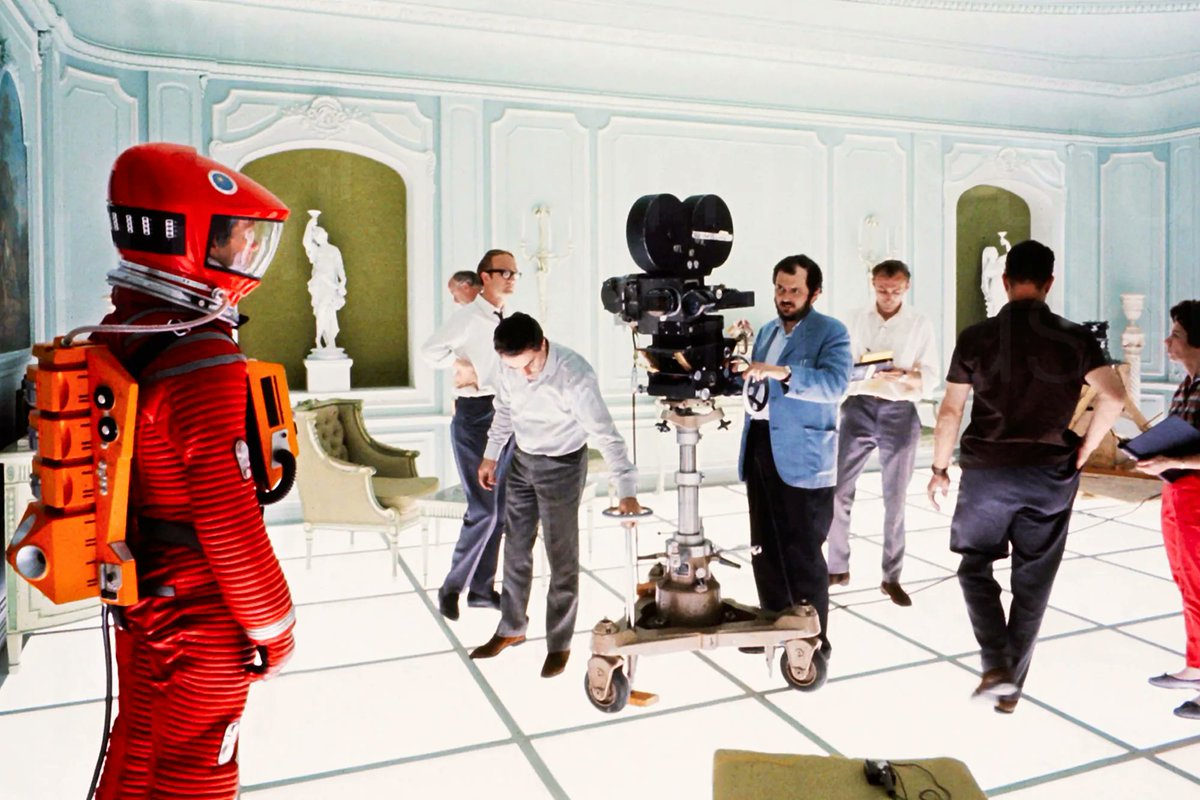di Enrico Ghezzi
[…] Sono proprio i contrasti con Douglas [protagonista e produttore del precedente film di Kubrick, Orizzonti di Gloria], che ha l’ultima parola su tutto ed è timoroso di essere sovrastato come «star» del film dal giovane regista, a convincere Kubrick a tornare subito con Harris e a giurare che d’ora in poi la prima clausola di qualsiasi contratto sarà quella della sua libertà di controllare ogni stadio della realizzazione. Malgrado che all’amorfo clima eisenhoweriano siano succedute negli USA le speranze kennedyane, Kubrick si sposta in Inghilterra (per restarvi, fino ad oggi) con la stessa facilità con cui si era spostato da New York a Beverly Hills. Il motivo è ancora una volta casuale; i fondi che la MGM mette a disposizione per Lolita, dopo che Kubrick e Harris si sono assicurati per 150 mila dollari i diritti del romanzo, sono congelati in Gran Bretagna e devono essere spesi lì. Il film, molto atteso dopo il successo di Spartacus e per la piccante notorietà del romanzo da cui è tratto, viene presentato nel 1962 al Festival di Venezia, con esito mediocre. Rimarrà il film di Kubrick più discusso e meno apprezzato. Principalmente, a causa dell’inevitabile solito confronto che vien fatto tra libro e film, come (senza mai nuovi argomenti) accade ancora oggi per qualsiasi adattamento da un testo di una certa importanza. Per lo stesso motivo, in Italia, dove il romanzo non è neanche stato “letto” ma semplicemente respinto come sottocultura semi–pornografica o al massimo come insignificante esercitazione stilistica (da noi arriva insieme allo Zivago di Pasternak, che monopolizza ogni tipo di nobile attenzione), il film viene trattato con condiscendenza, quale prova di una progrediente commercializzazione di Kubrick (in USA il film ha incassi enormi), o benevolmente rifiutato come si trattasse di un lavoro su commissione. Non si sa o non si tien conto della precisa volontarietà nella scelta del testo. È invece proprio con Lolita che si delinea in modo definitivo il «viaggio nello spazio»: l’artificialità di Lolita (che molto acutamente Marcorelles chiama «clima da serra») è già l’atmosfera di un’astronave. Dato il globale disinteresse filmico di Kubrick per i problemi della sentimentalità amorosa, è abbastanza evidente e significativo il motivo della scelta. Nel romanzo di Nabokov (scacchista, gozzaniano collezionista di farfalle, disegnatore finissimo e ironico di mortali arabeschi linguistici) è sviluppato con chiarezza accecante quello che è il tema dei temi kubrickiano, quello da cui si produce ogni suo film: l’ossessione.
Humbert Humbert, professore di letteratura francese e inglese di provenienza mitteleuropea ma trasferito in America per lavoro, sui quarant’anni, va a pensione da una giovane vedova in una cittadina della nuova Inghilterra vicino alla quale ha avuto un breve incarico universitario. Da sempre facile alla passione per le giovanissime, si invaghisce della dodicenne Dolores (Lolita) figlia della padrona di casa. Per mantenersi aperta la possibilità di soddisfare un giorno (ma presto, prima che passi l’età di lei) le sue «insane voglie» Humbert accetta anche di sposare la madre. Dopo la morte casuale ma «provvidenziale» di costei in un incidente, Humbert riesce a dar corpo ai suoi sogni. In una sorta di folle «viaggio di nozze» attraverso i motel degli Stati Uniti, consuma il suo febbrile legame con la ragazzina. Un giorno, ciò che il possessivo geloso e impaurito Humbert sospettava, accade. Lolita gli viene rubata da un bizzarro individuo, maturo commediografo di successo, Gare Quilty. Per mesi Humbert insegue ovunque, invano, la coppia. Rivede Lolita solo un anno dopo quando, sposata con un giovane, e incinta, gli scrive chiedendogli soldi. Humbert rivedendola, ormai priva della sua grazia di ninfetta, si accorge di «amarla», ma lei non accetta di seguirlo, e gli racconta la storia del suo rivale, col quale lo aveva tradito già prima di lasciarlo e che l’aveva poi scaricata dopo averla «usata». Conosciuta l’identità del «turpe individuo», Humbert lo va a trovare nella sua barocca dimora e lo uccide. In carcere, prima di morire, scrive la sua storia.
Non interessa qui la fedeltà o infedeltà verso Nabokov, il quale firmò la sceneggiatura che fu però da Kubrick ampiamente e liberamente manipolata. Rispetto al problema dell’età di Lolita, che Kubrick avrebbe sensibilmente aumentato scegliendo la quindicenne Sue Lyon per la parte, Kubrick stesso ha ironicamente notato (a proposito di «normalità») che il pubblico americano maschio medio ha evidentemente la tendenza (invero perversa) a raffigurarsi le dodicenni come bambine di nove o dieci anni. Kubrick ovviamente non ha potuto mantenere il fascino «linguistico» del testo originale, ma è stato in grado di conservare l’humour sottile ma dilagante, l’aspetto di «pastiche» tra diversi elementi culturali (popolari e non), e l’ossessionalità. Il romanzo abbonda in accenni alla possibilità che avrebbe la cinepresa di immortalare ora Lolita che gioca a tennis, ora il suo sorriso a metà tra il malizioso e l’incosciente, ora un paesaggio attraversato (Nabokov è un appassionato di cinema), ma l’idea di una semplice traduzione visiva di immagini letterarie sarebbe stata del tutto errata, dato che il fascino del monologante raccontare di Humbert Humbert è proprio nel tentativo continuo di rendere il ricordo, lo struggimento, l’indefinibile incomprensibilità di momenti e visioni in realtà profondamente soggettive, con il vertiginoso e barocco ricorso alla parola («Oh, mia Lolita, io non ho che le parole da far giostrare sulla scena!»). Anche il gioco di Kubrick quindi, dopo le forzose semplificazioni di Spartacus, torna a farsi complesso, come già il soggetto impone, se P. Citati definisce Humbert Humbert «un simbolo collettivo: una “summa” stilistica del nostro tempo». Che Kubrick punti molto di più sull’ossessione in sé che sul suo oggetto (Lolita), è dimostrato già dal principale spostamento operato rispetto al romanzo: l’insediamento all’inizio della sequenza dell’uccisione di Quilty, che vedremo ripetuta in coda (come è nel romanzo). Ciò, oltre a introdurre il suspense che provocherà in seguito ogni apparizione di Peter Sellers (Quilty, mascherato da professore tedesco – Zempf, stranamoresco – o da poliziotto logorroico), incornicia tutto il film in un’atmosfera onirica, di soliloquio onirico (nabokoviano) profondamente soggettivo: e si capisce quindi anche qui in quale senso è ormai orientato il «realismo» kubrickiano. Ancor più, rammentandoci The Killing, l’accorgimento costruisce un tempo particolare e sospeso in attesa di richiudersi, ma comunque tutto incentrato sulle relazioni tra Humbert e i modi temporali della narrazione. Dopo i titoli e la sequenza citata, si ha infatti il lungo flashback (preceduto dalla scritta «Quattro anni prima») introdotto in prima persona da Humbert e da lui diverse volte commentato fuoricampo, quindi la ripetizione dell’omicidio, e infine un’altra scritta finale: «Humbert Humbert morì in prigione di trombosi coronaria in attesa di essere processato per l’assassinio di Clare Quilty». Ma l’idea della «fine» posta in partenza non serve solo a produrre un genuino suspense che rimpiazzi, quale elemento di interesse immediato, la quasi assoluta castrazione (obbligata, data la censura del periodo) degli aspetti visibilmente erotici del rapporto ossessivo tra Humbert e Lolita, ma soprattutto a portare in primo piano un elemento meno accentuato –ma sempre alluso –nel romanzo. Cioè, il carattere di «doppio» che ha Quilty rispetto a Humbert. Nel film, alla maschera un po’ grigia e immota di Humbert (un James Mason che fa ricordare la non minore fissazione ossessiva – là per il denaro – del suo Cicero nel film di Mankiewicz, e del personaggio di Bigger than Life – Dietro lo specchio – di N. Ray) si contrappone a più riprese, come manifestazione estroversa di uno stesso «vizio» ossessivo, il cinico vivacissimo fregolismo di Quilty–Sellers, che segue passo passo l’itinerario del protagonista per sostituirsi infine a lui e realizzare anzi il suo stesso sogno. Se nel libro Quilty era percepito da Humbert più che altro come «doppio culturale», con il suo stesso gusto per la citazione letteraria e per il calembour («benché più volgare e superficiale»), qui, prima di essere ucciso, Quilty addirittura invita Mason a una partita a ping–pong (scacchi volgarizzati, e «sport» preferito di Kubrick), gioco in cui la medesima pallina è oggetto della stessa maniacale (ma ludica) attenzione da parte di due giocatori vicinissimi che si specchiano l’uno nell’altro: la didascalia ultima, infine, lega nella morte i due nomi, uno all’inizio e l’altro alla fine della frase, in modo inequivocabile, e senza neppure nominare Lolita (di cui invece nel romanzo si annunciava la morte per parto).
Il tutto avviene in una dimensione di fiaba (e poi di fiaba–mito, con l’apparizione di Lolita–Jean Harlow, LolitAlice che si muove dentro al cerchio dell’hula–hoop, centro per Humbert irraggiungibile anche quando raggiunto, corpo–centro che lo porta a distruggersi) che darà in seguito un tono étrange anche alle notazioni realistico–satiriche del film (il ritratto ora pietoso ora spietato di Shelley Winters, la madre di Lo, «madre» che tornerà invecchiata e del tutto disillusa nel Bloody Mama, Il Clan dei Barker di Corman; la provincia americana). Humbert scivola all’alba dalla porta socchiusa nel cadente «maniero» incantato di Quilty, si muove allucinato nelle stanze sottosopra per le orge della notte precedente, entra nel luogo della perversione e per non contaminarsi neppure si toglie il cappotto, di fronte a Sellers che lo accoglie in pigiama e si avvolge in lenzuola posando da antico romano (le sue prime parole, «Sono Spartaco. Siete venuto forse a liberare gli schiavi?», giocano col film precedente) provando ancora a giocare la commedia dei travestimenti e delle parole da mago sapiente. Ma se la prima sequenza ha questa fruizione di proporre le chiavi di tutto il film prima ancora dell’apparizione di Lolita, e se propone il gioco temporale come essenziale per una storia che nel romanzo era tutto un mescolarsi di date e ricordi, un procedere e tornare indietro, necessariamente e ironicamente, visto che l’ossessione erotica di Humbert si definisce per la precisa limitazione temporale dell’età del “ninfaggio” (dodici–tredici anni); è solo nella ripetizione finale che si chiarisce il suo senso segreto, il segreto kubrickiano nascosto nella chiarezza. L’ovvio amore di Kubrick per l’ossessione messa in scena da Nabokov è infatti dovuto alla rivelazione (gradualmente preparata ma sorprendente nel libro; più «chiara» –lamenta Kubrick – nel film perché mancando l’occhio erotico della permissività l’infatuazione di Humbert visibilmente casta, ha fin da principio un che d’amourfou) di quale è il cuore di tale ossessione apparentemente fisico–meccanica: l’amore più estremo ed asociale (l’anormalità del desiderio di Humbert è tale solo in relazione ad una «norma» sociale), infine indifferente all’oggetto nonché all’età. Humbert si accorge di amare Lolita pur «invecchiata» e incinta e anche nella stupidità evolutasi fino a ricordare la madre, l’ossessione si mantiene e si fa pura supera l’oggetto quasi feticistico di sé (la ninfetta transeunte) e l’immobilità del fotogramma, per perpetuarsi in forma vuota dentro la quale torna però la «persona». Kubrick può far intravedere cosa può esserci al cuore dei suoi freddissimi meccanismi e della sua ossessione in (per) essi, nel suo folle perseguire il cinema come astrazione e insieme realizzazione assoluta. Quilty viene ucciso dentro al palese déco cinematografico che è la sua dimora, perché è il cinema–spettacolo cinicamente soddisfatto di sé (le sue parole al primo sparo di Humbert: «Smettiamola di giocare con la vita e con la morte. Io sono uno scrittore di drammi. So tutto su questo genere di tragedie e di commedia e di “fantasy” e di tutto. Ho al mio attivo cinquantadue drammi e sceneggiature di successo…»), colui che è riuscito in quello che sembrava il fine dello stesso Humbert, godere Lolita in pace e scriverci sopra (nel libro, si scopre che il lavoro di maggior successo di Quilty è stato, anni prima, La piccola ninfa). Il maniaco monomane Humbert, che pure è all’interno del cinema, uccide – per amore – la puramente meccanica esplicitazione di sé.
Non è possibile negare che la sofisticazione allusiva di questo gioco difficilmente si comunica allo spettatore, e che la critica stessa può trovare il film ora disorganico, ora troppo «freddo», ora incerto: sono in fondo aggettivi che delineano un disagio psicologico reale cui non è estraneo proprio il centro doloroso della struttura grottesca del film. Tuttavia sul popolare e sul comunicabile il film dice qualcosa. È organizzato infatti come una contaminazione di diversi generi, anzi di tutti i principali generi classici cinematografici (meno il western e il musical): dalla commedia (black comedy e delirio verbale alla W.C. Fields) al poliziesco e all’horror, dal dramma sentimentale borghese al melodramma. Una raccolta di diversi «spettacoli» quale si ritroverà in Arancia meccanica. Lolita diviene quindi anch’esso un spettacolo che si proietta su diversi «schermi», tutti quelli dell’universo spettacolistico della comunicazione popolare. (Ancora nel libro: «Lo, a quel tempo, aveva ancora per il cinema una vera e propria passione. Assistemmo, con voluttà e senza discriminazioni, oh, non saprei, a centocinquanta o duecento programmi cinematografici in quel solo anno. I generi che ella preferiva si seguivano in quest’ordine: film musicali, film polizieschi, western»).
E c’è nel film una sequenza – esaltata dalle ombre e luci del bianco e nero – in cui la strana futura famiglia assiste dalla macchina, in un drive–in, a un Frankenstein. Si hanno tre diverse reazioni: la vedova ha un sobbalzo di paura (reazione istericamente «vera» alla messa in scena fittizia dell’orrore), la figlia segue invece automaticamente assorta e dentro al gioco più che impaurita, mentre Humbert l’intellettuale approfitta della propria indifferenza per assaporare il contatto delle mani di Lolita, e il suo volto contratto testimonia di un’altra emozione «vera». La coscienza delle diversità nella fruizione permette a Kubrick di mantenere i diversi toni del film a un livello di comunicazione media, senza fuggire nel preziosismo stilistico che poteva essere l’approdo più facile. Troviamo insieme: il solito attento lavoro sulla profondità di campo, importante qui per il ruolo centrale dell’occhio geloso e goloso di Humbert che disloca i vari piani dell’inquadratura, e gli ammiccamenti ironici, come l’ultima inquadratura (Quilty, – ucciso dietro un ritratto di donna su cui si legge la data, 1776 e oggi che è passato il Bicentenario si capisce bene l’allusione all’America, ai suoi miti sognati, al puritanesimo e alla sessualità sessuofobica). Realismo e onirismo, sentimento e cinismo, si integrano perfettamente in sequenze come quella (memorabile e inventata da Kubrick) di Humbert che apprende della morte improvvisa e «casuale» («A nessun uomo può riuscire un delitto perfetto, solo il caso può farcela») della moglie: si raccoglie nella vasca da bagno a pregustare la gioia che avrà con Lolita, e in preda a lieve ubriachezza risponde alle condoglianze dei vicini. Il romanticismo razionale e la costruzione cosciente del labirinto fanno pensare a Poe; e il libro stesso era pieno di nascosti riferimenti a Poe, già citato in un «jeu de mots» Poe–Poe come H. H.) e (come mette in luce Fiedler nel basilare Amore e morte nel romanzo americano) lontano modello di Nabokov con le sue giovinette le Annabel delle poesie, e Annabel è il nome della causa prima di tutta la ninfolessia di Humbert. Con tutto ciò, il film conserva una fluidità notevole, e ancora quasi la semplicità delle fiabe. E ciò colpisce p. es., Godard (cit.), che scopre Kubrick con Lolita, pur travisato da lui come film critico e demistificante sul sesso americano, mentre altri (Marcorelles) si rendono conto del carattere logico–cinematografico dell’operazione kubrickiana, cui già alludeva M. Bernard quando recensendo Spartacus notava che «l’interesse del film è soprattutto sul piano della concezione» e nel modo «poliziesco» di trattare un soggetto «politico» (sul che Barthes sarebbe d’accordo). In realtà, Godard apprezza Lolita – illuso dalla classicità e dalla minor evidenza del progetto –come un «piccolo film» dalle ambizioni finalmente limitate, e, anche se il suo Pierrot le fou vorrà essere «un film alla Lolita» (come lui stesso dichiara; e lo baserà poi su un romanzo del White di The Killing), Kubrick resta un regista (in termini godardiani) «i cui movimenti di macchina non esprimono una concezione del mondo, come in Ophuls».
Il «vuoto» del film è invece proprio sul piano dell’amore, sessuale e non. L’erotismo, oltre che negli occhi vagheggiami di Mason, è tutto chiuso nella sequenza dei titoli, in cui si vede la mano di Humbert toccare un piede di Lolita e cominciare a laccarne con dolcezza e pazienza le unghie. Ma la piana relazione tra uomo e donna è assente nel cinema di Kubrick, dove se anche la donna ha un ruolo decisivo o spesso ribaltante (il finale di Orizzonti di gloria, la moglie fedifraga in Rapina a mano armata, la voce alla fine di Stranamore, la firma di Lady Lyndon) ha tuttavia uno spazio limitato, e la famiglia o è completamente esclusa o è una speranza troncata (Spartaco e Varinia) o un penoso sodalizio (Arancia meccanica). Sembra che solo rapporti abnormi o falliti abbiano posto, o lo spazio meta–sessuale di 2001, o la violenza di Arancia meccanica.
Pubblicato in Stanley Kubrick, di Enrico Ghezzi, Firenze: La Nuova Italia