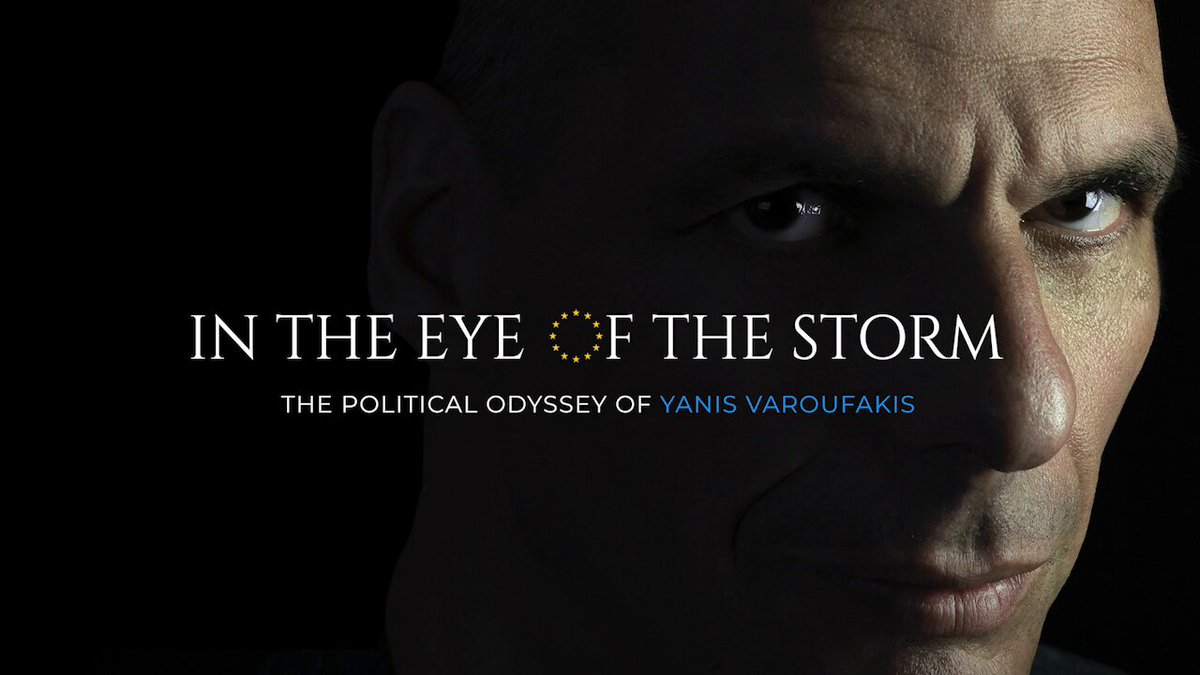a cura di Gianfranco Graziani
Filmcritica: Quali sono state le tappe salienti del tuo incontro con il cinema?
Sergio Leone: Il mio rapporto con il cinema nasce con mio padre addirittura che, come sai, è stato uno dei primi cineasti italiani avendo girato il suo primo film tra il 1910 ed il 1912.
Mia madre è stata un’attrice di teatro che ha iniziato insieme a Dina Galli.
Sono quindi figlio d’arte. A quindici anni, quasi per gioco, feci la mia prima esperienza cinematografica come assistente di Vittorio De Sica, in Ladri di biciclette. Poi, mentre studiavo, ho fatto da aiuto a Gallone, Bonnard, Camerini, passando successivamente alla sceneggiatura, contemporaneamente all’assistentato.
Prima di dirigere il mio primo film, Il colosso di Rodi, all’età di ventinove anni, avevo dovuto terminare Gli ultimi giorni di Pompei di Bonnard che era malato, con Corbucci e Tessari come assistenti.
Il colosso di Rodi è stato il mio primo film diciamo così alimentare. Mi ero sposato da poco, avevo bisogno di soldi e quindi feci questo film.
Il successo di questo film ha rovinato poi la mia vita: nessuno mi ha perdonato il successo.
Ennio Flaiano diceva: «L’insuccesso gli ha dato alla testa».
Anche il successo, posso rispondere a Flaiano, è qualcosa di terribile. Nessuno mi ha mai perdonato il successo. Ho passato la vita a rifiutare proposte di film su Maciste dopo il successo di quei primi due film, Il colosso di Rodi e Gli ultimi giorni di Pompei.
Ho resistito fino al 1964, anno della crisi del cinema italiano con il fallimento della Titanus per i film Il gattopardo e Sodoma e Gomorra. Di Sodoma e Gomorra avevo diretto la seconda unità, chiamato all’ultimo momento da Lombardo, nel tentativo di salvare il film.
Nel 1964 feci Per un pugno di dollari, prendendo lo spunto da un film di Kurosawa tratto da un racconto di Dashiell Hammett, «Red Harvest» (Raccolto Rosso), seguendo una mia vecchia idea, di applicare cioè gli schemi della commedia all’italiana al film western. Nella fattispecie abbiamo un personaggio che si vende a più parti, luna all’insaputa dell’altra, né più né meno come Arlecchino servitore di due padroni.
Nello stesso tempo credevo pure che delle ottime sceneggiature per film western si potessero ricavare da Omero: questo è il mio «modo di vedere le cose», come dice Robert De Niro in C’era una volta in America, il film che presento qui a Venezia.
Vorrei che con lo guardo di un padre mi facessi un po’ il punto sul cinema italiano.
Il cinema italiano attraversa un momento critico a mio giudizio per colpa dei produttori. Le televisioni private invadono tutta la giornata con dosi massicce di film scelti per lo più senza criterio. La televisione ha influenzato in modo deleterio l’odierna produzione contrabbandando l’equivoco dello standard medio.
Che pensi delle video-clips e dell’uso americano degli effetti speciali?
Quella della video-clip è una vecchia idea che può risalire alla nostra canzone «sceneggiata», da Merola, oppure da Infascelli.
Prodotti costosi ed effimeri, realizzati su criteri standardizzati che creano una noiosa omogeneizzazione.
La pubblicità americana con i suoi colori vivaci, col suo modo vertiginoso di girare e di montare crea indubbiamente effetti allucinogeni immediati.
Il contenuto è un’altra cosa: questo trionfo del «now» è un trionfo dell’effimero, destinato a perire miseramente da un giorno all’altro. Spero che queste mode televisive attuali, con la barbarizzazione del gusto medio dello spettatore perpetrata sia attraverso le voglie di tenerezza sia attraverso le telenovelas, passino presto.
C’era una volta il West è il film da cui prende le mosse C’era una volta in America: ripartiamo dunque da quel film.
C’era una volta il West doveva chiamarsi «C’era una volta la rivoluzione» e non ha avuto questo titolo per evitare confusioni con il film di Bernardo Bertolucci (Prima della rivoluzione).
Quando feci C’era una volta il West avevo già il progetto di fare C’era una volta in America, ma i produttori mi dissero che poiché il progetto era impegnativo e problematico preferivano che prima gli confezionassi un altro western.
Decisi allora di arrivare a C’era una volta in America attraverso un trittico che comprendeva C’era una volta il West, Giù la testa! e poi finalmente quest’ultimo, passando dalla rivoluzione di Pancho Villa per arrivare fino ad oggi, attraverso il ’68, di cui Giù la testa! rappresenta una sorta di metafora.
Questa trilogia è anche un tentativo di vedere la storia americana attraverso il cinema ed i suoi archetipi: ci sono infatti tutti gli archetipi della Hollywood classica.
È una sorta di «balletto di morte» della nascita di una nazione: tutti i miei personaggi guardano in faccia la morte.
Quando abbiamo fatto il soggetto con Bernardo Bertolucci e Dario Argento siamo partiti dal vendicatore per poi attraversare tutti gli archetipi della Hollywood anni quaranta, dalla matriarca americana fino al nuovo gangster-uomo d’affari (Fonda), mentre Ferzetti è l’uomo d’affari «tout court».
Giù la testa! rappresenta un momento intermedio, con il suo conflitto tra intellettuale e «peones», tipico di una fase del sessantotto.
C’era una volta in America è la fase finale del progetto e parte appunto dalla autobiografia di un gangster (Harry Gray, il libro è intitolato Mano armata ed è stato scritto a Sing Sing da questo gangster il cui vero nome è Goldberg, comprendendo memorie che vanno dalla seconda frontiera fino al periodo del 1968 americano).
Questo libro è molto sincero perché il gangster che lo ha scritto sapeva di dover affrontare la morte e non aveva alcuna pretesa commerciale. Ho inseguito per anni l’acquisto dei diritti su questo libro.
Sul filo delle memorie del piccolo gangster s’inseriscono le mie memorie, ricordi di un certo cinema che è stato parte fondamentale della mia vita.
È un poco una ricerca di un certo cinema perduto, se vuoi, alla Billy Wilder: un disperato tentativo per un impossibile ritorno alle origini.
Quali sono le fasi in ordine gerarchico della lavorazione del tuo ultimo film?
Debbo premettere che il mio cinema è fatto di metafore e di apologhi che vengono fuori da «favole» senza alcun nesso apparente con la realtà.
Dopo questo dirò che la fase della stesura del soggetto con le relative indicazioni, scena per scena, dei ruoli per gli attori è una fase fondamentale nel mio lavoro, che porta ad una stesura estremamente-precisa.
Il lavoro con gli attori è fondamentale in questa fase, mentre tutta la parte visiva viene da me sempre decisa direttamente sul set.
Alla stesura del soggetto con le indicazioni di scena dedico in genere, come in quest’ultimo film, alcuni mesi di discussione. Tornando a C’era una volta in America devo dire che attraverso la favola racconto poi anche tutti i miei fantasmi. La sceneggiatura dunque nasce dopo la discussione del soggetto e poi sul set vengono fuori tutte le indicazioni visive.
Per C’era una volta in America ci siamo serviti di interviste di documentazione a decine di gangsters americani.
Tornando alla morte…
Gli eroi dei miei film sono tutti in cerca della verità, ma come ho già detto guardano in faccia la morte.
Che pensi del vecchio Peckimpah?
Il vecchio Pelle Rossa Sam (un cui antenato ha dato il nome al monte Peckimpah) mi ha sempre interessato molto, dai tempi di Mucchio selvaggio. Ma gli ultimi due suoi film mi sembrano non molto forti sul piano dell’invenzione.
Filmcritica, Anno XXXV, n. 348/349 – Ottobre-Novembre 1984; pp. 452-455