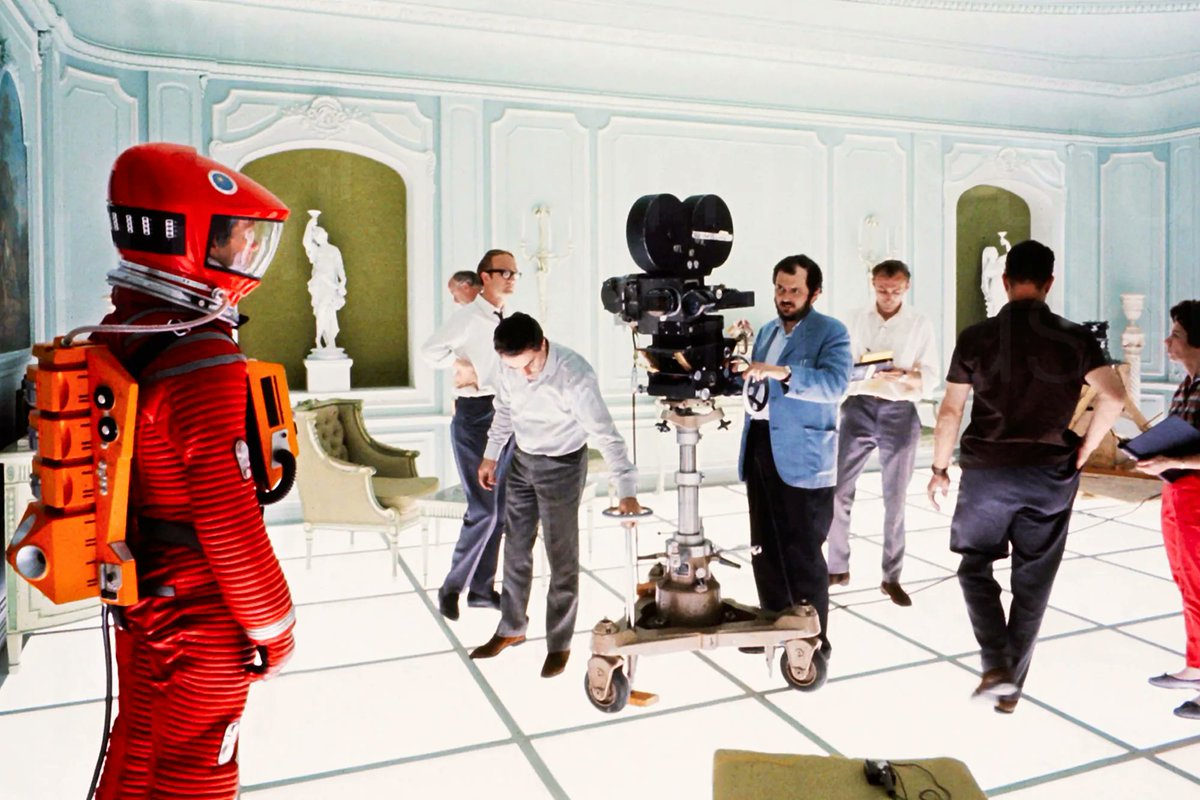Sappiamo che Kubrick rifiuta un contratto della stessa casa [la United Artists] per produrre filmetti di seconda serie: non gli interessa arrivare in qualche modo a fare comunque del cinema. In parte, proprio la chiarezza con cui dal suo comportarsi si delinea l’esistenza di un progetto di cinema rende oscuro tale suo progetto, che non è chiarito nemmeno in negativo non essendo visibili obiettivi, magari polemici. Il genere p. es., non è per Kubrick una struttura da aggiornare (come il western per Peckinpah) o con cui misurarsi ribaltandola all’interno (è il senso in cui opera Penn, dall’inizio fino agli ottimi Bersaglio di notte e Missouri), o lo è solo secondariamente, risultando in partenza semplicemente il «mondo–cinema» nel quale si deve entrare. Così, è indubbio che se The Killing (Rapina a mano armata, 1956) rientra a tutti gli effetti nel genere «nero» (e nel «gangster film»), non è certo come variazione all’interno di esso che viene progettato e realizzato. Fatto suo il mezzo, lo strumento–arma, la scimmia evoluta può ormai usarlo e lanciarlo in ogni direzione. Grazie al fortuito e decisivo incontro con James B. Harris, che anticipa 130 mila dollari ed esordisce come produttore, Kubrick riesce a farsi finanziare dalla United Artists (il costo finale sarà di 320 mila dollari, basso anche per lo standard delle medie produzioni).
Johnny Clay, malvivente da poco uscito di prigione, prepara insieme con quattro complici (tutti poveri diavoli, falliti, nessun criminale di professione; un cassiere tradito e sbeffeggiato dalla moglie, un barista, un pensionato, perfino un poliziotto nei guai per debiti) il «colpo grosso» della sicurezza economica. Si tratta di svaligiare la cassaforte di un ippodromo prima che vengano pagate le vincite. Per avere il tempo di compiere indisturbato la rapina, Clay assolda due individui esterni alla gang: un immigrato russo giocatore di scacchi e formidabile lottatore, che tenga occupati i poliziotti provocando una rissa e un cecchino che ha il compito di abbattere il favorito della settima corsa, per ritardare le decisioni della giuria e lasciare quindi piena la cassaforte. Compiti meno importanti ma necessari hanno gli altri, compreso il poliziotto, che deve portar via il denaro che Clay gli passerà. Il piano, perfettamente congegnato, sembra riuscire. Per Clay poi le cose sembrano mettersi in modo ideale, perché il resto della banda, a colpo avvenuto, viene sterminato in una sparatoria con amici della moglie del cassiere, che aveva avvertito l’amante sperando di poter abbandonare ricca la magra vita coniugale. Folle di rabbia e già morente, dopo aver provocato la strage, l’ometto prima di spirare uccide anche la moglie. Clay con i soldi e con la sua ragazza si avvia all’aeroporto, e quando già si avvia all’aereo un cagnolino taglia la strada al trenino dei bagagli, la valigia con i dollari cade in mezzo alla pista, i biglietti si sparpagliano nella notte, due agenti appaiono dietro la vetrata.
Il raccontino dà solo un’idea pallida del film, non tanto perché in questo vi sia molto di più (come si suol dire) o per scontate supremazie del «come» sul «cosa», quanto perché conta proprio come vi si racconta il racconto. Kubrick ha fatto le cose per bene, e si capisce lo stupore ammirato della critica statunitense di fronte a quello che in Europa poté sembrare al massimo un film interessante e originale (per squarci, per presunti barocchismi figurativi, o per la storia) ma che a chi vivesse lo spettacolo del cinema americano dimostrava chiaramente di essere un confronto totale col «cinema», nei limiti del genere adottato. Asphalt Jungle (Giungla d’asfalto, 1950) di Huston può essere il diretto punto di riferimento per il cinèfilo, i rimandi sembrano numerosi: l’attenzione al décor urbano, la preparazione del grande colpo da parte dell’uomo appena uscito di prigione, la presenza in entrambi i film di Sterling Hayden (Ciment elenca altri omaggi al genere nella scelta di attori come l’Elisha Cook del Grande sonno hawksiano, la Coleen Gray di Kiss of Death, o Ted de Corsia il «cattivo» di tanti film). Scherzando si può dire che il film di Kubrick comincia dove finiva quello di Huston: se in Giungla d’asfalto Hayden moriva «brucato» e annusato dai cavalli, qui le prime inquadrature sono dedicate all’ippodromo. Scherzando, perché i due film sono simili soprattutto nello scrupoloso rispetto dei romanzi polizieschi da cui sono tratti, ottimo quello di Bumett su cui lavora Huston, meno buono ma piacevole il Clean Break di White. Qui finiscono le somiglianze e qui partono le differenze. L’interesse precipuo di Clean Break sta infatti nel lambiccato montaggio temporale dell’azione, seguita a spezzoni con frequenti ritorni indietro, anticipazioni, ripetizioni; proprio questo colpì Kubrick, il quale dichiara di non essere stato minimamente interessato al soggetto. Eppure i personaggi non si dimenticano, i dialoghi sono «superbi» (a curarli Kubrick chiamò l’amico Jim Thompson, autore di buoni romanzi e racconti «neri», tra cui The Getaway da cui Peckinpah trarrà nel 1972 il film omonimo, su un’ottima sceneggiatura di Walter Hill, infatti poi buon esordiente con Il re della strada), pieni di continua e fin troppo sottolineata ironia. (Questa p.es. dopo la sequenza dei titoli dell’ippodromo, è la prima frase detta dalla voce recitante, mentre si passa all’interno della sala–corse: «Alle 3.45 esatte di un sabato pomeriggio di settembre, Marvin Unger si avviò verso gli sportelli dei cassieri dell’ippodromo. Nonostante la sua innata antipatia per il gioco, aveva puntato su tutti i cavalli in una stessa corsa. Sapeva che questo metodo alla lunga lo avrebbe fatto perdere, ma stava mirando a una vincita ben più alta»).
Ogni dettaglio è in effetti curato, non per il genere tuttavia, ma per un meccanismo che è in buona parte indipendente da esso. In Giungla d’asfalto, e ancor di più ne Il tesoro della Sierra Madre (altro film di Huston cui riferirsi è d’obbligo per l’immagine finale dei soldi sparsi al vento), il meccanismo della derisione ironica è più umanamente corposo, la spietatezza delle leggi etiche che regolano il mondo del crimine ripropone in ogni caso una socialità e il contrasto doloroso con essa del mito romantico individuale. In essa esplodono le risa e le urla che ritroveremo nel recente magnifico L’uomo che volle farsi re, mentre in Kubrick il riso (come la relazione d’amore) è sempre distorto, ridotto a ghigno o insolenza, più spesso assente, se mai potremmo immaginare qualcosa di vagamente simile all’isterica risata finale di James Mason in Five Fingers (Operazione Cicero, 1952) di Mankiewicz: un altro film con bigliettoni (per lo più falsi) sparpagliati infine, e un altro cineasta restio alle interviste, un altro salutato enfant prodige agli esordi.
Qui, il meccanismo ha un aspetto di gioco gratuito. Il film, perciò non «gratuito», è la messa in scena di giochi che si incastrano, un documentario «realistico» sui congegni –gratuiti ma non per questo meno logici – di essi. Vediamo come si realizza questo chiarissimo progetto, che sembra contrastare con la sostanza di genere del film, e con le stesse emozioni della visione. Intanto, Kubrick riprende e accentua il trattamento del tempo già presente nel romanzo, per niente artificioso ai fini dell’introduzione del gioco, delle sue pedine e dei suoi regolamenti. Già la sequenza iniziale mostra la funzionalità del procedimento, che permette di presentare i cari ambienti della vicenda, e la parata dei personaggi, in una successione logica e non affidata al modo disorganico in cui potremmo avere le stesse informazioni se seguissimo l’itinerario di un protagonista. La situazione dello spettatore è quella di Marvin Unger: magari non ama il gioco, ma segue il tutto, anzi punta su tutti i cavalli (seguendo tutti i personaggi). Neanche Clay è «colui che conosce» il gioco intero e come va a finire; è solo l’attore principale, e l’attore più stupendamente impassibile del cinema americano, e quindi il più adatto a passare attraverso uno dei film più romantici della storia del cinema (Johnny Guitar, 1952), contrastante con quello più caratteristico dei meno coscienti operai minori della fiction. La stessa voce narrante è solo un espediente tecnico, non rinvia ad alcun soggetto né ad una conoscenza assoluta: è la voce atona del tempo, e infatti ne annuncia il trascorrere, il tornare indietro, il dislocarsi nello spazio della storia; niente di più lontano dai cervellotici deliranti flashback che si trovano in altri esempi di «genere» (il più clamoroso: Dead Reckoning, Solo chi cade può risorgere, 1974, di Cromwell).
Insieme con le didascalie che scandiscono le ore e i giorni, è il lavoro di Kubrick sul tempo; la voce infatti ha la prima parola, mai l’ultima. Il meccanismo ne è solo innescato, corretto, ma poi procede da solo (cioè: tutti gli elementi concordano). Il segno è già nelle prime inquadrature, che mostrano i preparativi di un gioco (le corse dei cavalli) causa di altri giochi (le scommesse). La rapina conta, per riuscire, sulla provvisoria interruzione traumatica del gioco, ma comincia ad essere narrata essa stessa nella sala–giochi in un esordio minuzioso e rituale in cui tre dei partecipanti al colpo si scambiano furtivi messaggi come per scherzo bambini a scuola. Lo spettatore inizia a seguire i personaggi, cioè il meccano. Visto nel complesso, il gioco è aspramente ironico, quasi sarcastico, in un’interrotta serie interna di volute. La banda è composta da falliti, eppure il piano si svolge alla perfezione, grazie al contributo determinante dei due buoni «tecnici» esterni. Clay l’esperto, il freddo che sembra condurre il gioco, lo vedrà fallire; sarà lui per caso a perdere tutto, dopo esser stato sul punto di ottenere il massimo. Il cecchino, che rischiava meno di tutti («Il peggio che ti potrebbe capitare sarebbe di essere arrestato per aver sparato a un cavallo fuori stagione», gli dice scherzando Clay), per un caso sfortunato viene ucciso dalla pistolettata di un agente, e gli era stato appena regalato un ferro di cavallo; un altro riferimento simmetrico lega la sua morte alla sua prima comparsa nel film, quando lo vedevamo esercitarsi in campagna su sagome di cartone raffiguranti uomini con la pistola puntata. Ma il gioco più vertiginoso è quello in cui si coinvolge lo spettatore. La storia infatti, col perfetto gioco d’incastri, si fa seguire agevolmente, e anche il fatto che una medesima sequenza (lo scatenamento della rissa all’ippodromo) sia ripresa due volte non è artificioso ma avvertito come funzionale. È «divertente» in fondo: si tratta di un puzzle del quale man mano vengono forniti i pezzi; tutto combacia, tutto torna senza bisogno di sforzi. In questa prima visione d’assieme l’acme è la sequenza in cui Clay, calcatasi in testa una bizzarra maschera ghignante, compie la rapina vera e propria: la m.d.p. lo segue con un lungo carrello laterale attraverso diverse stanze (puzzle come ricostruzione di una superficie–fiction: durante tutto il film la m.d.p. si limita a scivolare lungo di essa mediante i carrelli laterali. Altman mostrerà in Images l’utopia e il terrore e i problemi di un puzzle che sia del tutto «filmico», cioè che utilizzi anche la terza dimensione, risultando impossibile a risolversi), lo mostra mentre si fa riempire di soldi un sacco. Poi lo vediamo buttare il sacco dalla finestra –vedremo in altra sequenza il sacco spuntare da essa e cadere vicino all’auto del poliziotto complice –, quindi tornare sui suoi passi. A questo punto il resto, fino alla caduta finale («crime does not pay»), potrebbe essere previsto e accettato da qualsiasi cultore di film del genere.
Per un lato infatti il film soddisfa la non troppo nascosta predilezione – da parte di chi guarda in un’ottica di genere per il perfetto combaciare non tanto di un piano quanto delle sequenze nel loro insieme, uno scivolare meccanico di ogni film sui passi del precedente, nel mare degli archetipi e del sempre previsto imprevisto. Il piacere infantile della «costruzione» e del gioco maniacalmente ripetuti (specchiati in catena lacaniana), della fiaba reiterata. Dall’altra parte, il gangster film «nero» (come ogni altro genere) accoglie al suo interno momenti di dissoluzione o di messa in questione, anche perché, nelle necessarie pur lievi successive variazioni di personaggi, se ne creano di abnormi: isolati romantici eroi, perdenti nati che perdono ancora una volta per una donna, psicopatici (James Cagney nello straordinario White Heat, Furia umana di Walsh), mostri. O almeno, ogni genere ha le sue figure tipiche, l’affetto per le quali occulta spesso il fondo reale del piacere che il film di genere può dare. In The Killing lo spettatore ha pure l’illusione di ritrovare –oltre la struttura affascinante – qualche figuretta nota (gli attori sperimentati nel genere), qualcuno dei miti abusati del genere (specie il più gratificante, quello dell’autodistruzione), un po’ di romanticismo del crimine. Il subplot (l’intreccio secondario), la storia triste e tragica del cassiere Elisha Cook e della moglie Marie Windsor, fornisce tutto questo. Non è un caso che le poche inquadrature espressionistiche, in un ambito fotografico mediamente realistico (la fonte di illuminazione spesso mostrata in campo contribuisce anzi a dare la luce dell’attualità e dell’autentico anche agli interni, tutti in studio), siano dedicate proprio alle scene in casa dell’infelice coppia, con la bionda macchia luminosa della donna indolente tra le ombre della camera e il bianco sfatto delle lenzuola, e dalla radio un improvviso sottofondo di vizioso be-bop (il resto dell’accompagnamento musicale è molto più duro e ritmato), fino alla caduta finale di Cook che muore finendo per terra col volto in primissimo piano, addosso alla gabbietta del canarino (piccole banali simbologie, a volte autoironiche per l’evidenza dello stereotipo estremizzato, che irritavano a ragione Godard, e mandano tuttora in visibilio l’esegesi anglosassone, in un seguito di «simbol of…»). In effetti, la loro vicenda è un momento di scollamento, con l’irrompere del barocco e l’attesa incrinatura del congegno, «piacevole» nella fluidità globale.
Non solo. Il titolo del film, un film per tre quarti occupato dai preparativi e dallo svolgimento di una rapina, segnala come apparente oggetto proprio la «storia secondaria», il suo effetto –la strage, «the killing» —; il quale effetto però quasi non si vede, sottolinea Ranieri. La scena della strage è brevissima, un’istantanea violentissima sparatoria, lampeggiano due inquadrature, poi il movimento di macchina sui corpi accatastati. Il titolo indica quindi ciò che in pratica appena si intravede. E se anche la storia del cassiere provoca autentico interesse dando sfogo al «dolore», nascosto nella perfezione di ogni genere, anche se per Clay e per noi l’apparizione dell’ometto ferito che barcollante attraversa la strada è «fantastica» (Ranieri parla apertamente di fantascienza: morti che camminano, l’incredibile precisione necessaria per colpire il cavallo in corsa…, «è il delirio calcolato, la notte di Valpurga a Capo Kennedy»): quello è in realtà il suo ruolo preciso, è lì per questo e basta, «funzione» che interviene al momento stabilito. Trasparente il modo in cui Kubrick ci indica che tutto è già compreso nel meccanismo, anche ciò che sembra corroderlo. Quando, con cenno autobiografico, fa andare Hayden in un club scacchistico a ingaggiare il lottatore (Kola Kwariani, un giocatore del Village, amico di Kubrick), un vecchio amico e i due siedono di fronte a una scacchiera, allora, il calvo e massiccio immigrato esce nella frase di massima gratificazione romantica in tutto il film («Gangster e artista hanno una cosa in comune. Ammirati e idolatrati da tutti quando le cose vanno bene, sono i primi che poi il mondo vuol distruggere, l’uno per paura, l’altro per invidia»; frase non ironica anche se potrebbe essere l’ironica enunciazione della morale del film «nero», il cui amato eroe lo spettatore vuol veder cadere). La dice e i due sono di fronte alla scacchiera in una stanza dove si gioca a scacchi.
Tutto rientra nel gioco che contiene tutte le passioni ma si manifesta nella obbligata rigidità delle traiettorie. E ogni gioco ha le sue traiettorie, diverse ma obbligate, ogni film ha i suoi carrelli e i suoi movimenti. Potrà essere difficile trovare il nascosto itinerario complessivo dell’opera kubrickiana, ma il movimento interno dei singoli film è sempre rintracciabile e definito, come l’esattezza dei suoi movimenti di macchina. Ci si potrà chiedere perché il meccanismo kubrickiano debba prevedere lo scacco, che qui sembra richiesto dalla morale anni ’50 del genere, ma che diverrà regola. Non direi che sia il piccolo particolare non curato per non «offendere gli dei», né un gusto puramente nullista o tetramente o beffardamente ironico per il fallimento che mina gli accurati congegni umani o meccanici (in questa prospettiva cambia poco). Al contrario, è se mai demiurgica riaffermazione del potere assoluto del regista che può far fallire qualsiasi costruzione (figura precisa di questo potere assoluto è il montaggio che Kubrick compie da solo, ma «ferocemente» contro il materiale da lui stesso girato), se vogliamo è l’ultima parola della ragione che si dice contro la circolare auto soddisfazione del chiuso meccanismo intellettuale. E ancora, più è perfetto il meccanismo e ambizioso, più si dimostrerà inadeguato a comprendere la vita che pure in esso sembrava esaurirsi. Che poi resti nel regista la capacità di costruire – lui sì – un congegno che soddisfi il suo progetto, è un altro discorso. Certo qualcosa della sua disperata utopia, del contrasto violento tra la chiusura del dominio e (gli effetti de) la non–totalità di esso, per quanto nascosto nel regista e nel momento della produzione, si comunica, se le lucide costruzioni ottenute – i film che sembrano poter fare a meno dell’uomo – provocano poi passioni ed emozioni e interesse alla storia e ai personaggi, oltre che ragionamenti. Il trucco c’è. Qui p. es. si vede «il nero» mentre si segue un meccanismo puro che ha ragione man mano di tutti i personaggi; non è presa in giro divertita e ripetuta, ma piuttosto (per questo alcuni critici e lo stesso Kubrick parlano di «cinismo») riproposta cosciente dell’inganno che da sempre ci offrono le apparenze del reale. Intanto sul set Kubrick – obbligato dalle leggi sindacali a valersi di un operatore registrato come tale – si era scontrato col grande Lucien Ballard (che ha lavorato con Walsh e Boetticher, diventando poi negli anni 60 collaboratore di Peckinpah) a proposito dell’uso di grandangolari (come il 25) ritenuti da quest’ultimo troppo distorcenti. La giovane scimmia–capo la spunta, filmando come vuole.