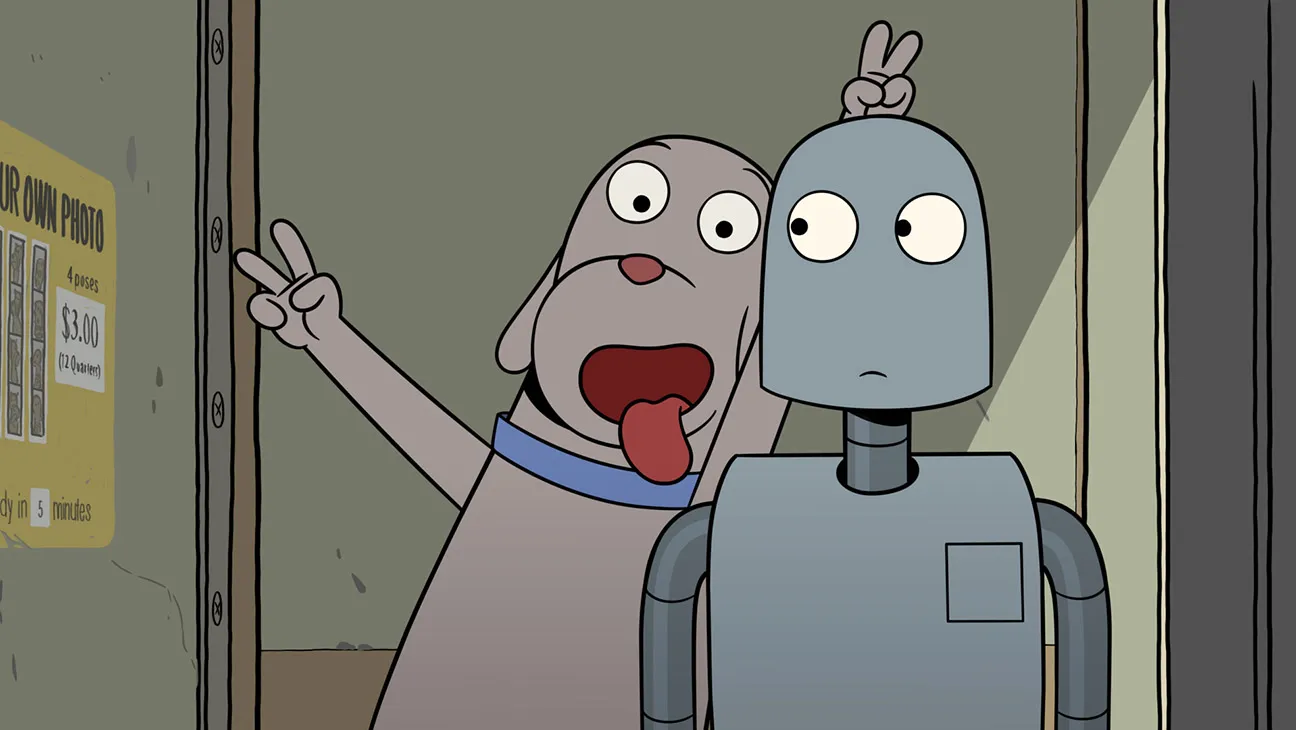Deserto rosso di Michelangelo Antonioni
di Giuseppe Grazzini
Povera Giuliana. Ha già tentato una volta di uccidersi, ma non ce l’ha fatta, e nell’incidente automobilistico ha preso una tal botta in testa che nonostante un mese di clinica non è più riuscita a trovare il suo equilibrio. Invece di mandarla in convalescenza in campagna, o a distrarsi in un’allegra stazione turistica, il marito, ingegnere, se l’è riportata, col figlioletto, sui luoghi dove lavora: nella zona industriale di Ravenna, tra altiforni, ciminiere, serbatoi, un paesaggio deprimente, grigio e fumoso. Sfido io, la poverina da fuori da matta. Anziché «reinserirsi nella realtà», continua a soffrire di angosce e di incubi notturni, striscia lungo i muri, è tutta un brivido. Ne il marito, che ha già dato prova di insipienza, muove un dito per aiutarla: non la incoraggia nel proposito, da lei manifestato, di aprire una boutique, anzi le mette intorno degli amici stupidi e sporcaccioni, con i quali la porta a passare una giornata in una baracca sul mare. La casa, povera Giuliana, è deprimente, arredata con mobili e soprammobili provvisori; il bambino, Dio mio, non ride mai, è un mostriciattolo che armeggia con giocattoli avveniristici, e si diverte a spaventare la mamma. E gli operai? Persino fra di loro la nevrosi ha mietuto vittime. Quando arriva Corrado, un collega del marito, Giuliana tenta di sciogliersi: un po’ impietosito dalle condizioni di lei, un po’ attirato dalla malattia della donna, in cui crede di riconoscere le proprie inquietudini di uomo randagio, Corrado le gironzola intorno. Vorrebbe aiutarla, e anche lei per un poco ci spera, ma tutto finisce in una camera d’albergo. Non sarà certo Corrado che potrà guarire Giuliana dalla nevrosi.
È il male del secolo, tutti ne siamo affetti. Matti incurabili, l’unico conforto ci viene dal tenere per mano un bambino e dall’avere coscienza della nostra condizione. La colpa di tutto? Innanzi tutto, della civiltà industriale. Gli uccellini, che hanno un cervello da uccellino, l’hanno capito che dalle ciminiere esce un veleno mortifero, e non ci passano più. Gli uomini, invece, testoni, ci vanno a vivere in mezzo, peggio per loro. Questo il nocciolo della storia raccontata dal Deserto rosso, il film di Antonioni presentato stasera alla Mostra di Venezia. La sua fragilità ideologica è evidente a chiunque non sia malato di intellettualismo. Antonioni non aggiunge nessun zuccherino alla sua pessimistica analisi del mondo contemporaneo, disumanizzato dal progresso scientifico; ma la sua condanna della civiltà delle macchine sembra ormai coinvolgere l’eterna condizione dell’uomo. Giuliana, per far star quieto il bambino, favoleggia di un mondo primitivo, di una ragazzina libera e felice nell’acqua di un’isola, e tuttavia inquietata da un’oscura presenza: qui (l’unica apertura ridente del film), non soltanto si proietta lo stato d’animo della novellatrice, ma lo stesso rimpianto del regista, che transita per «questa nostra dimora terrestre», come ama chiamarla, nostalgicamente rammemorando gli evi felici della pesca e della pastorizia, tuttavia già incrinati dalla minaccia dei mostri. Abbastanza superficiale nel voler far dipendere tutti i guai contemporanei, con un determinismo ottocentesco, dall’inferno industriale, il film rivela la sua origine intellettualistica nel fatto che la molla dell’ispirazione non è scattata per l’intuizione di un carattere o di un nodo sentimentale, già fusi con un’atmosfera, ma, per ammissione dell’autore, di rimbalzo a una visita agli stabilimenti di Ravenna, vedendo le risorse rappresentative che si potevano trarre da quel rauco paesaggio di bitume e di strutture meccaniche. Poiché l’ambiente preesisteva, Antonioni vi ha calato dentro dei personaggi che dovevano forzosamente aderirvi. Se sono risultati delle maschere schematiche, alle cui disavventure non partecipiamo, è perché la tesi era già risolta nel momento stesso dell’impostazione, e il rapporto fra i personaggi e i luoghi non comportava più, come ancora nell’Eclissi, alcuna dialettica. Si trattava semplicemente di un’opera di giustapposizione, alla quale erano estranei ogni senso del dramma e ogni palpito di passione. Se è questo che Antonioni voleva, ci è riuscito perfettamente. Usando il colore, con entusiasmo da neofita, e anche la musica elettronica, per esprimere unitariamente la desolazione del panorama e lo squallore dei personaggi, egli ha saputo con maestria costruire un universo disameno che riesce a deprimerci tutti, benché nessuno sappia dimenticare che il catalizzatore della storia è un caso clinico, e perciò scarsamente generalizzante. L’aver poi, come egli ha fatto, dipinto l’erba e gli alberi, per renderne il colore più funzionale, conferma quanto si diceva: che il regista, intervenendo sugli oggetti per farli combaciare ai sentimenti, ha coinvolto se stesso in quel processo che demolisce l’antico rapporto fra uomo e natura contro il quale protesta. Di per sé il colore è adoperato con bellissimi effetti: su una base neutra, il grigio della desolazione, Antonioni ha giocato estraendo dalla tavolozza del technicolor e dell’eastman-color pastosità che a tutt’oggi restano insuperate, e pongono il film fra le più alte conquiste della sensibilità cromatica del regista italiano. Il clima scenografico è perciò di straordinaria potenza evocatrice (come talune invenzioni, basti citare il bastimento che sembra navigare fra gli alberi, sono la conferma di un genio cinematografico su cui non occorre nemmeno discutere). Ma a che vale aver raggiunto con tanta gloria il traguardo del colore, se esso è messo al servizio di una tesi superficiale, di una storia priva di sviluppi narrativi sia pure interiori, di personaggi per i quali non proviamo ne simpatia ne pietà, e di una recitazione molto modesta? Se Deserto rosso non è stato una delusione, perché tale in ogni caso da suscitare polemiche culturali (e per scrupolo di informazione si aggiunge che qui a Venezia il film è piaciuto a molti), nell’interpretazione ha però mancato quasi tutte le promesse: l’esagitazione di Giuliana, interpretata da una Monica Vitti stanca di impersonare donne angosciate, è tutta rovesciata all’esterno. Richard Harris, nella parte di Corrado, è di una totale inespressività, degli altri non si ricorda nemmeno il nome. Perché anche la recitazione manca di fluidità e il difetto di un film pur figurativamente così suggestivo come Deserto rosso è nella visionaria fantasia di un intellettuale di provincia che ha identificato il diavolo con le fabbriche, e crede che tutta l’umanità sia chiusa in un cerchio di dannati, ciascuno nella sua gabbia. Andiamo a Ravenna, e vediamo quanti sono gli operai, gli ingegneri, le mogli dei tecnici che si comportano come nel film.
Il Corriere della Sera, 8 settembre 1964