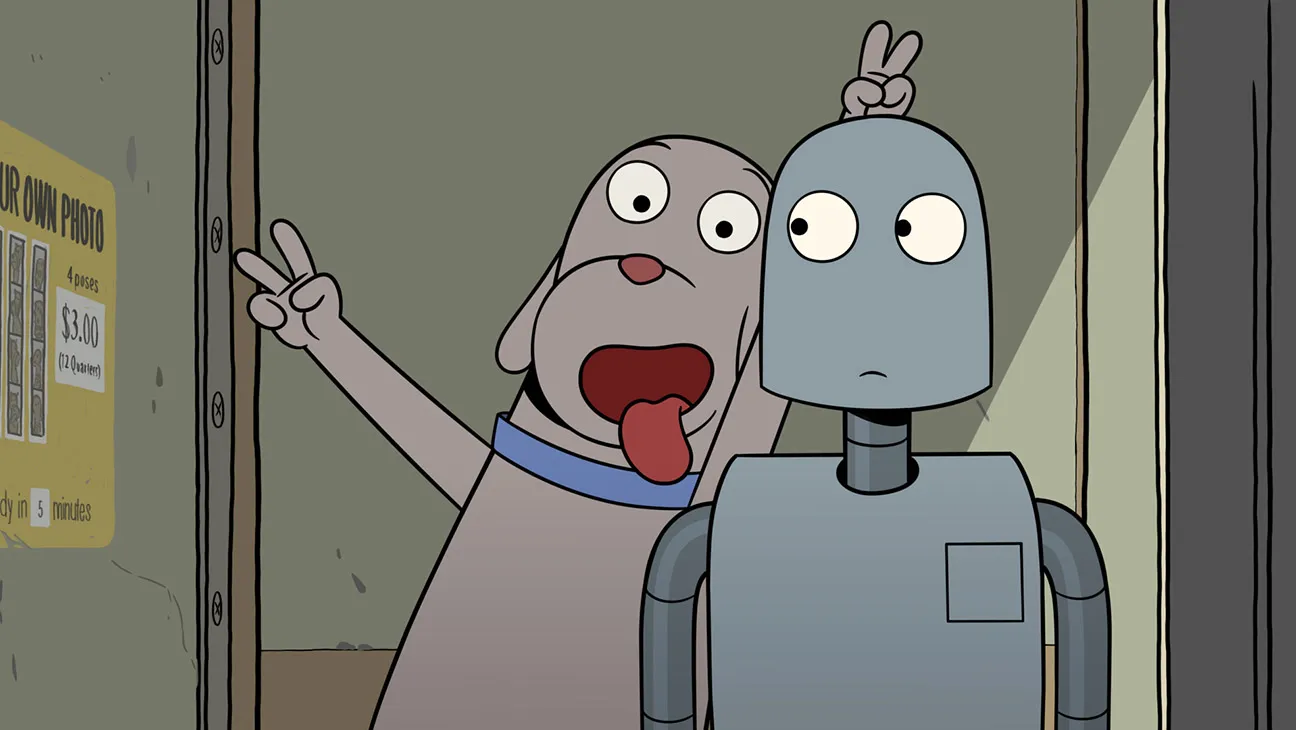di Gianni Canova
C’è qualcosa di commovente, nell’ultimo film di Martin Scorsese. Qualcosa di tenero e struggente. Nonostante la ferocia dei gesti e delle azioni che rappresenta, la barbarie che anima quasi tutti personaggi, il sangue che scorre a fiotti e i cadaveri che si accumulano senza posa, Gangs of New York colpisce e commuove in modo singolare. Per l’amore per il cinema che lo arde da dentro. Per la fiducia che col cinema sia ancora possibile costruire mondi, fondare epopee, intonare leggende. Soprattutto per la convinzione – che è di Scorsese come di tutti quelli che hanno lavorato con lui – che col cinema sia ancora possibile produrre senso. O dare un senso alle storie e ai mondi che si mettono in scena.
Gangs of New York è, da un certo punto di vista, un film crepuscolare. O terminale. Racconta la nascita di una città, ma lo fa con un linguaggio che ormai sa di essere destinato a morire. Lo fa adottando un modo di produzione che proprio qui, forse, emette i suoi ultimi bagliori. Con l’avvento del digitale, e con la sua diffusione capillare sul piano produttivo, probabilmente da qui a poco non si faranno più film così. Così giganteschi. Così epici. Così al contempo immaginifici e realistici. Non si faranno più perché non sarà più possibile farli. Non sarà economicamente conveniente produrli. Non sarà linguisticamente opportuno pensarli. Martin Scorsese e lo scenografo Dante Ferretti, come è noto, hanno ricostruito la New York della metà del secolo XIX negli studi di Cinecittà. Hanno usato in legno, il ferro della pietra per forgiare in essi la fatica e il dolore della Storia. Migliaia di comparse, spazi immensi, set faraonici: si sente la pesantezza della materia in Gangs of New York. Si sente l’odore di fango fetidoo e di neve marcia, di legno fradicio e di carne frolla, di sangue rancido e di fumo di fornace.
Forse, Gangs of New York è uno degli ultimi, grandi esempi di cinema fisico e materico, prima che l’elettronica e le nuove tecnologie trasferiscano anche i processi di produzione di mondi immaginari tra i bit, i pixel e i chip dell’immaterialità. Ed è proprio questo che commuove: per raccontare la fornace che era New York tra il 1846 e il 1863, Scorsese non usa le mirabilia del computer ma crea a sua volta un film-fornace, dove brucia – tra i corpi e i volti, le architetture e le armi, le etnie e i conflitti – anche quel sogno che il Novecento ha chiamato cinema.
C’è qualcosa di barbarico, in Gang of New York. Fin dalla bellissima sequenza iniziale, con la tribù dei “Conigli Morti” che indossa i colori di guerra e sfila dietro il proprio capo (Lian Neeson) per scontrarsi con la tribù rivale dei “Nativi” americani (che in realtà sono gli inglesi protestanti, emigrati in America qualche anno prima dei pezzenti irlandesi che dal 1840 sarebbero sbarcati ogni giorno a migliaia sui Docks dal porto di New York, accolti con diffidenza e ostilità dai migranti della generazione precedente).
Siamo nel 1846, ma potremmo essere nel Medioevo. O nella preistoria. Quelli che vediamo sembrano uomini delle caverne. Guerrieri bardati per il rito della lotta. Il rullo di tamburi ossessivo che scandisce i movimenti accentua l’impressione di tribalità. Di primitività. A poco a poco i guerrieri risalgono dalle viscere della terra verso la superficie, aprono una porta di legno e – come in una celeberrima sequenza di Sentieri selvaggi (1956) di quell’altro grande irlandese che era John Ford – vedono il “vasto mondo” fuori: ma ad attenderli non c’è la wilderness della Monument Valley, c’è la piazza sporca e innevata dei Five Points di New York, esattamente là dove qualche decennio dopo sorgerà il quartiere di Wall Street. I guerrieri si schierano in strada. Di fronte a loro c’è la tribù rivale. Come all’inizio di Il gladiatore di Ridley Scott, i guerrieri si fronteggiano e si insultano prima di scatenarsi nella lotta. In mano hanno mazze e alabarde, sul volto il segno livido di vecchie cicatrici. Il combattimento, quando scatta, sembra una mattanza. I corpi si avvinghiano furiosamente gli uni agli altri e cadono al suolo maciullati in un lago di sangue. La macchina da presa di Scorsese sta dentro la mischia e preme sui corpi da distanza ravvicinata. Mentre il montaggio di Thelma Schoonmaker cerca di cogliere la brutalità della violenza fissando rapide istantanee della morte e lavorando sull’accelerazione o sul ralenty per accentuare la grandezza della battaglia. Alla fine, il leader dei “Conigli Morti” resta sul terreno e il suo avversario gli rende gli onori militari: «orecchie e nasi saranno i trofei della giornata, ma lui andrà integro nell’aldilà», proclama Bill il macellaio (Daniel Day-Lewis) col viso incrostato di fango e di sangue rappreso. Ma intanto il figlio della vittima ha visto tutto, ha lo sguardo paralizzato dall’orrore della violenza e fugge via traumatizzato, sognando di poter vendicare un giorno la morte del padre barbaramente ucciso. Gang of New York è la storia di questa vendetta.
L’età della violenza
Martin Scorsese ha sempre raccontato storie di tribù in lotta fra loro. All’inizio erano le comunità italo-mafiose dei suoi primi film, poi le tribù di animali furenti sul ring in Toro scatenato (1980), quindi ancora le aristocratiche tribù di L’età dell’innocenza (1993). Questa volta, tuttavia, il suo sguardo da etologo sociale si fa ancor più lucido e penetrante, e scava negli strati sepolti della memoria e dell’inconscio collettivo per ricordare a tutti «di che lacrime grondi e di che sangue» la storia della sua città. Perché Gangs of New York dice prima di tutto questo: che la violenza è endemica nella storia americana. Che l’America, abituata a rappresentare se stessa con la maschera dell’innocenza minacciata o assediata, in realtà è nata da un crogiuolo di sangue e barbarie, di lotte di strada e faide feroci, di vendette brutali e massacri infiniti.
Molti, in America, non hanno gradito. Hanno storto il naso. Hanno stroncato. Buon segno: come riportando a galla il rimosso di un’intera nazione, Scorsese ha generato lo scandalo della verità. Ma non è tutto. Raccontando la sete di vendetta del giovane Amsterdam Vallon (Leonardo DiCaprio), figlio del “capo” ucciso nella battaglia iniziale e del suo tribolato amore per la ladruncola di strada Jenny Everdeane (Cameron Diaz), Scorsese ripercorre la tragica vicenda delle centinaia di migliaia di migranti fuggiti dalla vecchia Europa sognando un mondo migliore e accolti con inospitale ferocia da chi era giunto lì prima di loro. Tribù, ancora e sempre tribù: perché tribale è per Scorsese la storia dell’America, e del mondo. Se in L’età dell’innocenza (che comincia nel 1870, poco dopo i massacri di cui si narra in Gang of New York) aveva raccontato i riti tribali dell’aristocrazia newyorkese e dei suoi spiegati cerimoniali di classe, qui Scorsese scende invece nell’inferno dei poveri, dove si maciullano corpi umani con la stessa facilità con cui si sgozzano polli e maiali. Sa di mattatoio, la New York di Scorsese. È fatta di notti senza luce, di nevi arrossate dal sangue, di cattedrali illuminate dalle fiaccole della guerra oltre che da quelle della fede. Ma non è primitivismo artistico: Scorsese non è il Randall Wallace di Braveheart né il Ridley Scott de Il Gladiatore. La sua macchina da presa non va in cerca di eroi. Il suo sguardo non è quello di un Omero moderno, quanto quello di uno Shakespeare o di un Marlowe convertiti all’antropologia e all’etnografia sociale. Nelle sue inquadrature gremite, come quadri di Bosch o di Bruegel, da una folla dickensiana fatta di ladri, tagliagole, truffatori, avventurieri e disperati, Scorsese delinea l’antropologia di un paese che si è forgiato nel sangue, e che risuona ancora del clangore delle mazze e continua a emanare il tanfo e il puzzo dei cadaveri. Si prenda l’apocalittica e scioccante sequenza finale, quando le tribù di New York mettono a ferro e fuoco la città (sono i Draft Riots del 1863, un massacro che i libri di storia americani in genere tacciono) per protestare contro la leva obbligatoria che impone ai poveri di andare a combattere contro altri poveri con il pretesto di liberare i più poveri dei poveri (i neri) dall’orrore della schiavitù. L’atteggiamento di Scorsese è chiarissimo: il suo sguardo non è né quello di un pacifista indignato dalla violenza né quello di un moralista che deprechi a vuoto la follia umana. Al contrario, Scorsese mantiene uno sguardo asciutto e disincantato, coglie il senso politico di un massacro funzionale ai potenti («nulla di più facile che arruolare la metà dei poveri per mandati a sterminare l’altra metà»), freme con la folla riversa per le strade e abbraccia con pietas virile i corpi di coloro che subiscono l’oltraggio di morire così.
Grattacieli dai cadaveri
Ma questa volta la sua pietas non è più quella “umanitaria” di Al di qua della vita (1999) non è quella intrisa di senso del sacro che trapelava da alcune sequenze di Kundun (1997); Gangs of New York è da questo punto di vista un film spietato, non conciliante, feroce. Tanto più coraggioso quanto più ricorda all’America del dopo 11 settembre i mucchi di cadaveri su cui ha costruito la propria storia. Lo si vede benissimo nel rapido e coinciso finale, quando dall’inquadratura del cimitero in cui sono stati ammassati i cadaveri del massacro del 1863 Scorsese mostra – attraverso rapide e fulmine dissolvenze incrociate realizzate con immagini digitali – lo sviluppo successivo della città moderna, fino allo skyline dentro cui svettano le Torri Gemelle.
L’America, sembra dirci Scorsese, è nata e cresciuta sopra un gigantesco cimitero, da sempre. Come il mondo, del resto. È bene non dimenticarlo: soprattutto di fronte a un film che ha ancora la forza di usare l’immagine e i suoni per raccontare qualcosa di indispensabile e tremendo. Come avevano fatto in passato cineasti quali David W. Griffith, Cecil B. De Mille o John Ford. Come Sam Peckinpah o Sergio Leone. Scorsese, dopo questo film, è di fatto il loro più degno erede. L’ultimo, forse. Ma non per questo meno necessario.
Letture, Anno 58º – Quaderno 595 – Marzo 2003