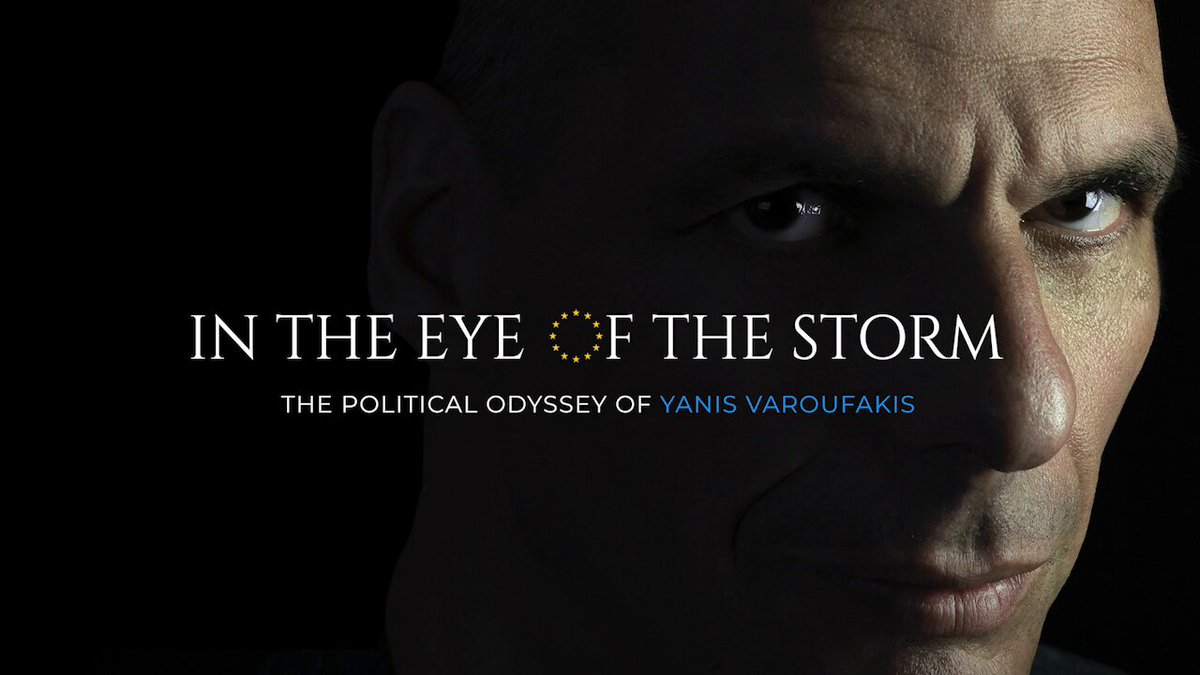di Robert Benayoun, Michel Ciment, Michael Henry
(Intervista realizzata a Parigi il 19 febbraio 1979 e pubblicata da Positif, aprile 1979)
Negli Stati Uniti si gioca un po’ il suo film contro quello di Coppola, perché esce per primo. Vengono anche paragonati in anticipo perché entrambi sono dei racconti barocchi, non realisti, scritti da due cineasti italo-americani che posseggono un senso lirico della metafora. Cosa ne pensa?
Penso che i due film saranno necessariamente complementari. Ne parlo solo per sentito dire, perché abbiamo molti amici in comune e non ho visto Apocalypse Now, benché sappia tutto sulla sua elaborazione e sulle riprese. Sarebbe bello vederli un giorno abbinati in doppia programmazione. Quando, l’estate prossima, Apocalypse Now sarà distribuito si riparlerà molto del mio film e, in fin dei conti, trarranno vantaggi l’uno dall’altro. Entrambi sono dei peripli dello spirito, delle avventure picaresche con un itinerario un po’ folle. Il mio pone la domanda: come si può continuare a condurre una vita normale dopo una tale esperienza? Mostra l’alternativa: o il suicidio o il ritorno alla vita con una dose di speranza; è una domanda che non ci si è ancora veramente posta negli Stati Uniti e, benché lo si ignori, si pone adesso. Coming Home (“Tornando a casa”), ad esempio, era un dibattito d’idee, mentre Deer Hunter (“Il cacciatore”) è un film fisico, con persone riprese in primo piano. Il primo mostrava un atteggiamento in rapporto alla guerra, che corrispondeva alle idee del cineasta, ma il dilemma posto direttamente da gente che si conosce da vicino ha tutt’altro impatto, a mio avviso, e per questo per me si è posta la necessità del lungo prologo che apre il film.
Precisamente, come ha concepito questa struttura sorprendente, un’ora di matrimonio, un’ora di Vietnam (che dura un secolo), un’ora di ritorno alla vita civile? È una costruzione molto poco classica per un film di questo genere.
Una mezz’ora fa, proprio qui, qualcuno mi diceva che la trovava classica (Ride). I miei produttori sono stati reticenti, hanno fatto a lungo resistenza, hanno subito voluto abbreviare questo lungo inizio. In effetti è un’idea pragmatica per risolvere il problema funzionale dello sviluppo dei personaggi. Nella maggior parte dei film contemporanei vi sono uno o due personaggi principali, qui ne avevo almeno una mezza dozzina. Per permettere al pubblico di conoscerli abbastanza bene e senza che se ne rendesse conto, in modo sottile, bisogna accordar loro un minimo di presenza sullo schermo; non ci si accorge che i personaggi vengono rivelati attraverso il matrimonio, ma invece è proprio questo che accade. Del resto, se non si prova nulla nei confronti dei personaggi, la stessa esperienza marziale non acquista alcun significato reale, profondo. La funzione di quest’ora è di farci condividere la loro vita, prima di farci condividere il loro incubo.
L’uso della roulette russa come forma di tortura, secondo le sue ricerche, era tanto frequente fra i vietnamiti quanto viene mostrato nel film?
Ci sono alcuni che testimoniano di aver vissuto quei momenti ed altri che trovano inconcepibile che ciò possa essere accaduto, che possa accadere. Nonostante tutto ciò che si può immaginare sul Vietnam sia accaduto, certi si sono commossi al punto da rifiutare l’idea che questo possa essere successo. Mentre ho parlato con gente che l’ha vissuto. Per me, era un modo per sciocchizzare lo spettatore, al punto da rimuovere il blocco su questa guerra che, per tanto tempo, ha persistito. Dato che si è imparato a conoscere nell’ora precedente e con uno stile di racconto tanto diverso (il film comporta tre stili distinti, diametralmente opposti gli uni agli altri), questi episodi di tortura costringono lo spettatore a reagire personalmente. Non dimenticate che, per gli americani, il Vietnam era caduto in una specie di anonimato, a causa dei filmati d’attualità provenienti ogni giorno dal fronte. Ci si può abituare a qualsiasi cosa durante dieci anni di familiarità. Le infermiere e i medici che lavorano negli ospedali imparano a bloccare le loro reazioni nei confronti della sofferenza, per essere in grado d’esercitare il loro mestiere. Non si può reagire ogni giorno agli stessi avvenimenti con la medesima intensità.
La roulette russa non è, a suo avviso, un modo per paragonare questa guerra ad una forma di suicidio collettivo e per dire che ci si può abituare al suicidio a tal punto che esso diventa una necessità permanente?
La roulette russa non è una metafora del suicidio di una nazione, è un mezzo per drammatizzare l’elemento casuale che sussiste in qualsiasi guerra. Non c’è motivo perché muoia un uomo piuttosto di un altro. Ho voluto comprimere l’esperienza quotidiana del combattimento e quest’attesa permanente della morte, quest’impossibilità di calcolare le probabilità di sopravvivenza. Non mi sorprende che in ciò si legga una metafora e non vi vedo alcun inconveniente, ma è una forma di tensione e di pressione costanti che alla lunga distrugge gli uomini. Anziché simboleggiare lo psichismo di un’intera nazione, ho voluto risolvere il problema di esprimere nel minor tempo possibile l’orrore della lotta. Tre ore non sono in sé sufficienti per esprimere tutto questo e io lo faccio in trenta minuti perché l’illusione del film comprime quest’impressione di vissuto, si vede molto meno di quanto si crede di vedere. Penso che queste scene durino in tutto due bobine. Questo esprime un anno d’incertezza di un soldato al fronte, che attende ogni minuto che una bomba gli scoppi vicino.
E il fatto che alcuni uomini alla fine del combattimento continuino a giocare alla roulette russa è immaginario o esprime l’assuefazione dei soldati alla droga, dato che si riteneva che il Vietnam trasformasse i soldati di leva in eroinomani?
Anche in questo campo alcuni sostengono che è falso, altri affermano di averlo fatto; ciò che la gente ignora è che i soldati, tutti giovanissimi, specie in Vietnam, provenivano da ambienti molto claustrofobici o isolati. E la guerra era la loro prima esperienza di vita con cui si trovavano improvvisamente a contatto, lontano dal loro ambiente d’origine. Uno shock altrettanto traumatizzante era il fatto di trovarsi calati nella cultura del sud-est asiatico, antica, corrotta e raffinata nello stesso tempo.
È stato anche lei in Vietnam?
No. Ero nell’esercito, di stanza nel Texas, ma per fortuna non sono stato mandato in Vietnam, benché abbia temuto a lungo di esservi chiamato.
Ci sarebbe andato o sarebbe stato tentato dall’idea della renitenza?
Non si può rispondere a questa domanda a posteriori. Al momento avevamo tre scelte: partire per il fronte come volontari, lasciare il Paese o aspettare di essere richiamati. In quel periodo la suspence era terribile, la gente era molto confusa, nessuno sapeva cosa fare, l’angoscia regnava sovrana. Il film tradisce quest’inquietudine. Un film esprime un uomo senza razionalizzarlo. Il film sei tu, rappresenta il tuo inconscio più di qualsiasi altra cosa.
Con quale dei richiamati si identifica maggiormente? Con tutti o con Michael?
Quando si scrive un film ci si divide un po’ fra i personaggi, ma evidentemente mi sono identificato soprattutto con Michael. Michael ha delle reticenze verso i suoi amici, è un leader naturale, ma soprattutto è un uomo di principi, ha un’etica di vita ben definita, che esprime del resto quando parla della caccia, quando parla dell’unico colpo. Si sente spesso tra i cacciatori quest’importanza dell’uccisione ‘pulita’, fatta secondo le regole. Michael ha un’affinità spirituale con il cervo. Non si è mai un buon cacciatore se non si è la preda stessa, se non ci si identifica col cervo. Tenta di condividere la sua etica con uno degli amici, ma il suo tentativo fallisce. Non può tenerla per lui solo, ma non la può realmente condividere.
Il fatto che s’innamori della fidanzata del suo amico viene dal bisogno di spartire qualcosa con lui, è un modo per avvicinarglisi dopo averlo perduto?
È qualcosa che capita naturalmente, in un dato gruppo d’amici. È comune a tutte le culture, è una cosa che, prima o poi, scaturisce spontaneamente in qualsiasi collettività di questo tipo.
La scena finale con l’inno “God Bless America” è stata interpretata in modo molto contradditorio.
Quando le persone, in un momento di crisi o di stress, si rivolgono automaticamente verso cose familiari e quando, nell’incapacità di esprimere la loro tristezza, ritrovano qualcosa che avevano imparato a memoria nell’infanzia, non c’è da parte mia alcuna ironia intenzionale^ Sapevo che era una scena pericolosa e che sarebbe stata attaccata e forse odiata. E un film molto personale, su dei rapporti personali, ma si può sempre interpretarlo come si vuole e fargli dire quasi tutto quello che si desidera. Sapevo che avrebbe prestato il fianco a controversie già prima di iniziarlo, a questo proposito non mi facevo alcuna illusione. Ma il sentimento di questa scena, ad esempio, è a volte sentito profondamente da quelli stessi che negano di provarlo. Il canto, anche se patetico, è un modo per affrontare un sentimento collettivo, soprattutto fra le classi d’individui che non sono inclini a discussioni elaborate. Quando uno comincia, gli altri gli vanno dietro, confermando così l’amicizia che li lega, la fiducia che provano gli uni per gli altri; ma, negli Stati Uniti, questo inno viene cantato automaticamente ad ogni partita di football, di baseball, di pallacanestro, ad ogni corsa o incontro di boxe. In questo caso il canto viene intonato da un mutilato e anche da un uomo letteralmente coperto di decorazioni, in modo che scaturisce in prospettiva in rapporto all’idea corrente del patriottismo; ma ancora una volta è un’idea molto semplice che mi è venuta in termini di condotta comportamentale.
Come avevano tentato di fare per la scena della tortura, i suoi produttori volevano farle tagliare questa sequenza?
Temevano assolutamente tutto di questo film, le scene di guerra, il matrimonio, la tortura, la caccia, la conclusione, la violenza deH’insieme. Non c’è scena che non li abbia messi in atroce imbarazzo. Li ho combattuti aspramente, utilizzando ogni sotterfugio. Tagliavo quello che volevano e di notte ce lo rimettevo: è stata una vera guerra, ancor più violenta di quella del Vietnam!
Come ha elaborato la sceneggiatura?
La Compagnia inglese EMI mi propose un film che non volli fare; poiché volevano assolutamente produrre un film americano, offrii loro l’idea di Deer Hunter. Con mia grande sorpresa furono d’accordo ed avevano una tale fretta che lo girassi che mi chiesero di prepararlo partendo dall’esposizione della storia che avevo loro fatto a voce, in due ore. Non c’era niente di scritto, ma poiché sapevo la linea del racconto, decisi di mettermi alla ricerca degli esterni dove girare, lavorando contemporanea¬mente alla sceneggiatura. Il risultato è quello che viene descritto nel film, molto preciso, in quanto basato su paesaggi e luoghi che ho visitato per andarvi a girare. E successa una cosa insolita: mentre continuavamo nelle nostre ricerche, avvenimenti di cui fummo testimoni e persone che incontrammo s’inserirono nella sceneggiatura. Mi ero sempre prefisso di non iniziare mai un film senza la sceneggiatura ed ecco che lo stavo facendo!
In che consisteva la sua presentazione a voce? I tre rituali (il matrimonio, la caccia, la roulette russa) ne facevano già parte?
Vi era contenuto tutto il film. Naturalmente vi furono poi dei cambiamenti, ma l’essenza c’era. Un altro esempio: il primo montaggio era di tre ore e diciannove minuti e quello definitivo di tre ore e tre minuti. Per Thunderbolt and Lightfoot (“Un calibro 20 per lo specialista”), il mio primo film, erano, rispettivamente, due ore e venti e due ore e undici.
Conosce la zona della Pennsylvania in cui si svolgono le prime sequenze?
Sì, vi ho trascorso un bel po’ di tempo quando giravo dei documentari. Era Dusquesne, vicino a Pittsburgh. Sapete, ho vissuto in molte regioni degli Stati Uniti, nelle riserve indiane del Nord e Sud Dakota, nel Montana, a San Antonio, nel Texas, dove ho fatto il servizio militare. Il Sud è l’unica zona che conosco poco.
Lei dimostra una tenerezza particolare per certi paesaggi americani: in Thunderbolt and Lightfoot ha filmato delle montagne quasi mai viste sullo schermo, tranne che in alcuni film di Anthony Mann, degli anni ’50.
La maggior parte delle persone non li considera importanti, è per questo che non si vedono mai. Per girare questi paesaggi bisogna uscire dai sentieri battuti, fare uno sforzo. E sono pochi quelli disposti a farlo. Per me, il paesaggio è essenziale. Thunderbolt and Lightfoot è stato girato nel Montana, a sud del ghiacciaio, nella regione esplorata da Lewis e Clark; The Deer Hunter nella regione delle Cascate, alla frontiera col Canada. E il film che sto preparando si svolgerà nel Parco Nazionale del ghiacciaio. Abbiamo percorso 400.000 chilometri in treno, in aereo, in automobile, per trovare gli esterni di Deer Hunter. Ho un’avversione per i posti come Tucson, dove sono stati girati duecento film. Tutti questi viaggi hanno costituito una strana esperienza. Chuck Aspegren, che impersona Axel, lavorava come caporeparto in un’acciaieria di Gary, nell’Indiana, ed è là che l’abbiamo scritturato. Come l’ho visto ho sentito che doveva partecipare al film.
Molti film americani contemporanei sono influenzati dal cinema europeo, con effetti di montaggio e un quadro ristretto. Al contrario, lei torna alla tradizione, ponendo sempre i suoi personaggi in un quadro largo.
Per me il personaggio è un attore del film, agisce sullo spettatore anche se lui non se ne accorge. Sono sempre sensibile al genio di un luogo. Per me deve avere una qualità spirituale, un valore nuovo e diverso. Sin dall’inizio, abbiamo girato in piano-sequenza per conservare unito il gruppo, perché lo spettatore partecipi all’esperienza, perché non sia distratto dal montaggio.
Qual è stato il contributo di Deric Washburn alla sceneggiatura?
Vi ha lavorato per circa sei settimane nello stadio preliminare. Come Louis Garfinkle e Quinn Redeker. Ma io ho scritto l’essenziale di quello che poi abbiamo girato. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nel novembre del 1976 e verso gennaio ho continuato a scrivere da solo. Prima dell’inizio delle riprese ci sono state sei versioni diverse della sceneggiatura. Non finivo mai di modificarla mentre preparavo il film: è stato un processo molto difficile. Gli attori, li ho scelti soltanto dopo aver terminato il copione e ho avuto fortuna perché – come per Thunderbolt and Lightfoot – tutti gli attori del film sono stati quelli cui avevo pensato fin dall’inizio. Abbiamo fatto il casting a New York e non a Hollywood, perché volevamo dei volti non troppo noti, come Christopher Walker e John Savage. Nel film vi sono pochi attori professionisti, la maggior parte dei ruoli secondari sono ricoperti da persone prese dalla strada.
In questo senso, come ha girato la lunga sequenza del matrimonio? Era già tutto scritto? Avete fatto molte prove?
Ha richiesto una lunga preparazione, in particolare per la festa, perché c’erano dialoghi e musica. Il coro doveva provare prima, bisognava conoscere la struttura esatta della cerimonia e abbiamo fatto una cosa insolita, in questa scena particolare: il dialogo, la musica e i rumori di fondo sono stati registrati simultaneamente e ciò che si sente lo dimostra. Non c’è stata post-sincronizzazione salvo che per una o due frasi. Come potete immaginare, il montaggio è stato difficile e complesso ed è durato quasi otto mesi. Non m’importava che brani di dialogo non fossero chiari, in un certo senso costringere lo spettatore a fare uno sforzo per sentire ciò che dicono i personaggi gioca a suo favore. Valeva la pena di affrontare questi problemi, perché in tal modo nel film non vi è nulla di artificiale; se guardate la gente che applaude e balla sullo sfondo, vi accorgerete che sono in ritmo, cosa che non accade quando si registra tutto in studio. Nella scena del bar, George Dzundza suona veramente Chopin. Ha dovuto studiare il pianoforte per tre o quattro mesi e non sarebbe capace di suonare altro che il brano scelto per il film! Volevo che fosse la sua emozione personale a trasparire nella musica e non quella di un professionista registrato in play-back.
Abbiamo trascorso molto tempo a mettere a punto la colonna sonora. Per esempio, ci sono voluti circa cinque giorni per ottenere il passaggio sonoro che volevamo tra la scena del bar e quella dell’elicottero. In pratica, il rumore dell’elicottero è composto da suoni a cinque livelli diversi ed è stato faticoso ottenere un equilibrio soddisfacente. Se vedeste il film a 70 mm. in stereofonia, su sei piste, notereste un gran numero di particolari nella colonna sonora.
Come ha lavorato con Vilmos Zsigmond?
Abbiamo voluto che le tre parti avessero un aspetto visivo diverso. È stato anche necessario stare molto attenti nelle sequenze in esterni, girate negli Stati Uniti, in quanto le scene invernali sono state filmate in estate. Non avevamo un gran margine per girare, perché fu una delle estati più calde del secolo. Dovemmo togliere le foglie agli alberi per suggerire l’inverno e non c’era modo di cambiare idea all’ultimo momento, dato che ogni inquadratura doveva essere preparata con una settimana d’anticipo. Due troupes lavoravano ventiquattro ore su ventiquattro per preparare il paesaggio invernale e se si modificava l’angolatura della macchina da presa, ci si ritrovava in piena estate! Abbiamo sperimentato diversi modi di solarizzazione e d’esposizione. Per le sequenze del Vietnam abbiamo desaturato l’immagine in laboratorio, arrivando fino a cinque stampe successive.
Sono state lunghe da girare le scene della roulette russa nella capanna viet-cong?
Molto, e per varie ragioni. A quello stadio delle riprese la troupe era esausta. Eravamo sul fiume Kway, cinque chilometri a nord del famoso ponte birmano. Le scene di Saigon sono state girate a Bankok, che, dal punto di vista architettonico, è la città più simile a Saigon del sud-est asiatico, dato che non potevamo girare in Vietnam. Il fiume era gelido, l’aria cocente e noi restavamo in piedi nell’acqua quasi tutto il giorno. Gli attori non erano professionisti: li avevamo scritturati sul posto in Thailandia e non parlavano né inglese né vietnamita. Ogni comunicazione doveva passare attraverso tre lingue, senza contare il linguaggio dei segni! Inoltre non vedevamo i ‘giornalieri’ e per mesi non abbiamo saputo che cosa avevamo girato. La EMI temeva che, se ci avessero rimandato le pellicole stampate, le autorità thailandesi potessero sequestrarle.
Ha studiato arte e architettura. Che influenza hanno avuto su di lei? Fa parte di quei cineasti che per ogni inquadratura tengono l’occhio sul mirino?
Sì. Ho un’idea precisa di quello che voglio visivamente. Ho anche una certa facilità nel coreografare il movimento. Ci sono dei campi che mi pongono problemi, ma non questo: mi fa anzi piacere. Mi piace far muovere la gente nello spazio. La mia collaborazione con Vilmos Zsigmond è stata molto felice, perché parlavamo lo stesso linguaggio e abbiamo il medesimo punto di vista sul cinema. Torneremo a lavorare insieme nel mio prossimo film, Heaven’s Gate.
In un certo modo, Thunderbolt and Lightfoot anticipava The Deer Hunter nel suo passaggio progressivo dalla commedia al dramma e alla malinconia, nel tema dell’amicizia, nel fatto che l’eroe della storia è un ex combattente in Corea che va a lavorare in fabbrica, nell’idea della scuola che rinchiude un tesoro, oggetto di ricerca.
E la Cadillac bianca! Non si fa altro che riprendere le stesse cose spingendole più oltre ad esempio quello che capita all’amicizia. Ma il mio prossimo film sarà prima di tutto la storia di una donna. E, contrariamente a quanto si creda, The Fountainhead è più la storia della donna che non dell’architetto. Lui non cambia fino alla fine del film. Ma lei sì. Questo è per dirvi che non sono ossessionato dall’amicizia: si è presentata come il tema dei miei primi due film, questo è tutto. Ma credo che, inevitabilmente, quando si parla dell’America, si arrivi inconsciamente a gravitare intorno al tema dell’amicizia. In un film metti quello che ti piace, quello che ti preoccupa, e avanzi fondamentalmente in modo intuitivo: solo più tardi comprendi quello che hai fatto. Quando dipingi, metti un certo colore sulla tela senza dame una spiegazione razionale. Agisci, e poi capisci che questo fa parte di un disegno. Ma se dall’inizio sei troppo cosciente del tuo disegno, ciò rischia di rivelarsi troppo, d’essere insistente.
È per motivi simili che lei rifiuta di fornire un’interpretazione troppo precisa del suo film?
Ci si aspetta troppo da un regista al di là del film, si pensa che abbia una spiegazione nello stesso tempo globale e dettagliata della sua opera. Ma non si farebbero le stesse domande ad un pittore o ad un musicista. Credo che ciò dipenda dal fatto che il cinema, per sua stessa natura, è considerato come un avvenimento reale, come un filmato d’attualità, in particolare se il tema trattato parla di un presente o di un passato prossimo conosciuto da tutti. Allora si interroga il cineasta come se fosse un uomo politico o un giornalista, si dimentica che si tratta d’invenzioni, che è un’arte surreale piuttosto che reale. Intendo surreale dal punto di vista della forma: la distorsione del tempo, la compressione degli avvenimenti. In Deer Hunter il problema è di condensare una guerra così varia in un limitato numero di minuti. Bisogna escludere qualsiasi logica e rifiutare la spiegazione, altrimenti il film durerebbe dieci ore. Così, ad esempio, non si può spiegare logicamente il ritorno, sano e salvo, di Michael da Saigon. Ciò mi ricorda la famosa domanda posta a John Ford: “Perché non abbattono i cavalli degli indiani? – Perché se lo facessero non ci sarebbe più l’inseguimento!”. Si utilizzano i fatti perché si adattino alle necessità drammatiche del film, per prerogative artistiche si deformano tempi e luoghi, il che non esclude che si possa affrontare il soggetto con una certa innocenza, senza vederne tutte le implicazioni. Ma, personalmente, trovo meraviglioso che nel mio film si trovino tutte queste metafore. Ciò non finisce mai di sorprendermi.
(Traduzione italiana in Positif dodici interviste, Arcana editrice, 1980)