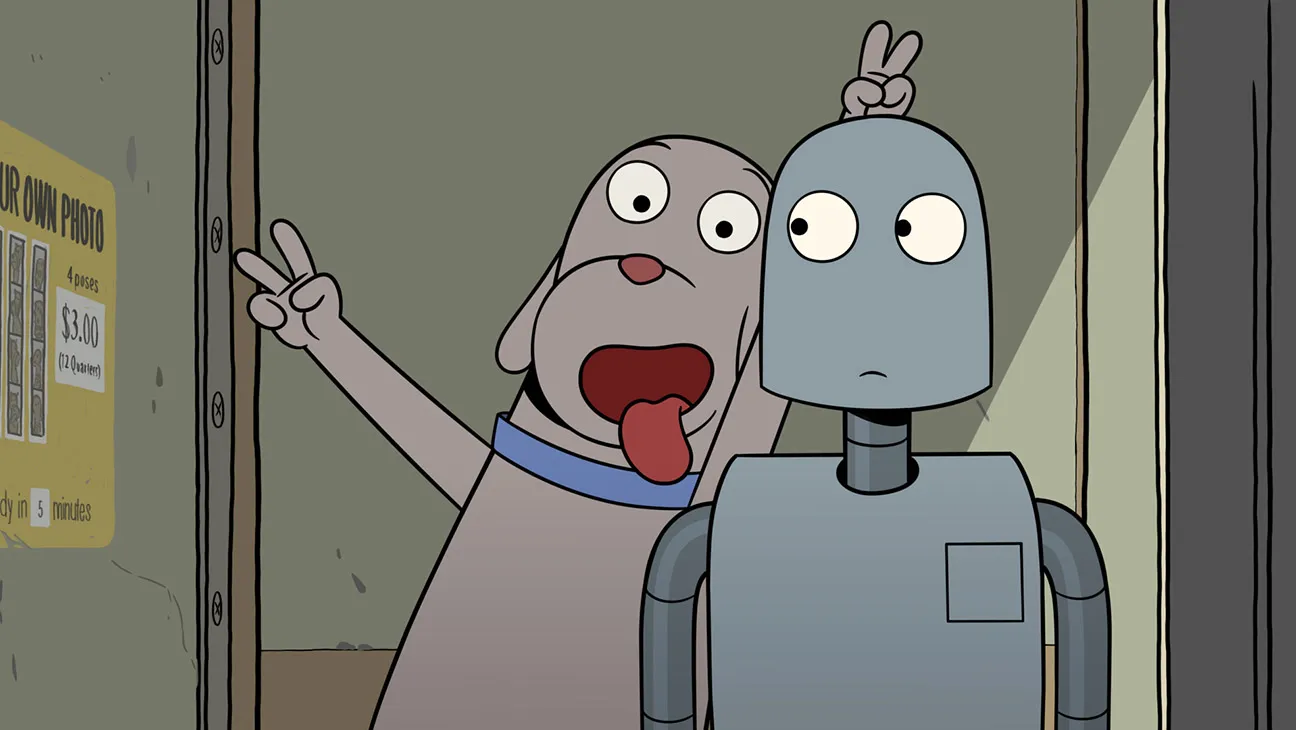Eyes Wide Shut e la “relazione di coppia
Il (bi)sogno dell’”altro”
Il film di Kubrick è lo sfaldamento di ogni confine tra corpo e mente, realtà e sogno, conscio e inconscio, maschera e volto, fedeltà e tradimento
di Eliana Elia
Qual è colui che sognando vede,
che dopo il sogno la passione impressa
rimane, e l’altro alla mente non riede,
cotal son io, che quasi tutto cessa
mia visione, ed ancor mi distilla
nel core il dolce che nacque da essa
(D. Alighieri, Paradiso, XXXIII, 58-63)
Tremendo è scri(vi)vere il sogno. E come guardare attraverso un caleidoscopio: le architetture perfette e luccicanti delle forme incantano e inquietano, ma non appena si tenta di raccontarle, mutano e ritornano uguali e diverse solo dopo che altre, altrettanto cariche di terribile fascino, si sono costituite, in un processo senza fine. Perché senza fine è il viaggio all’interno della conoscenza di se stessi; e Eyes Wide Shut è un viaggio, un’altra odissea kubrickiana nello spazio del nostro essere ontologicamente indeterminato, continuamente in bilico fra due mondi, fra la possibilità di elevarsi e porsi sul piano della pura intelligenza e la possibilità di abbassarsi fino alla bruta ferinità. Eyes Wide Shut è la sospensione di ogni logica disgiuntiva (lo stesso titolo è scelta di una realtà ossimorica), è lo sfaldamento di ogni confine fra corpo e mente, realtà e sogno, conscio e inconscio, maschera e volto, fedeltà e tradimento.
L’uomo è restituito alla sua ambivalenza, alla sua illimitata possibilità di plasmarsi, di trasformarsi nella relazione con l’altro da sé, sia questo “altro” un individuo, un sogno, una visione.
Corpo e mente
Il corpo è l’oggetto psichico per eccellenza (J.P. Sartre, L’essere e il nulla)
Un corpo ignudo apre il film. Il corpo esile e slanciato della Kidman che rimanda alle raffinate creature cranachiane, la cui grazia gracile e inquieta rivela la tensione non solo del corpo, ma anche della mente, verso il desiderio; una scultura di Eros e Psiche è uno degli elementi profilmici nel salone di casa Ziegler. Alice rinuncia all’avventura galante con il seducente uomo ungherese e quando questi cita l’Ars Amatoria di Ovidio quale inno all’amore come gioco e capriccio passeggero dei sensi, Alice, con deliziosa arguzia, preferisce ricordare del poeta dell’inganno in amore la solitudine dell’esilio. Alice si impone di allontanare la caeca voluptas: ma la sua voluttà non è “cieca” e il suo corpo è sguardo.
Nell’immagine allo specchio la m.d.p., dopo essersi avvicinata progressivamente ai corpi di Alice e di Bill, quasi a monitorarne il crescere del desiderio, si fissa sull’occhio di lei in primo piano (un altro occhio-icona si aggiunge all’oftalmica antologia kubrickiana) che guarda allo specchio e “riflette”, “specula”, costituisce lacaniamente il suo io immaginario in relazione all’altro e, scoprendone la fallacia, si propone di andare al di là, sull’altra scena non specularizzabile dell’inconscio (e la dissolvenza incrociata, che è un andare attraverso lo specchio – come l’Alice del fotografo e giocatore di scacchi Lewis Carroll – diventa nel film una marca dell’enunciazione che traduce il dissolversi dell’identità e di ogni idea di confine).
Alice prende atto dei suoi demoni notturni: la Venere di Cranach, come in una metamorfosi ovidiana, si trasmuta nella perturbante Sposa di Max Ernst, ove il gentile Cupido alato è sostituito dal temibile uomo-uccello con in mano una lancia fallicamente orientata verso il sesso della donna che, con la maschera animale e il mantello sotto il corpo nudo, rimanda alle figure femminili che nel film partecipano all’orgia. Alice scopre di poter essere altro – una potenziale Belle de jour – e di poter scardinare l’ordine razionale della propria vita. Un ordine di cui la ricca casa borghese è l’immagine alla quale fanno da controcanto le figurazioni naïf alle pareti (prati smaltati di fiori, foglie e frutti giganti, un gatto con grandi occhi belluini) che, nell’assenza di relazioni prospettiche, nella semplificazione iterativa degli elementi decorativi, diventano simbolo di una realtà istintuale più profonda e incontenibile. Sono i quadri dipinti dalla moglie di Kubrick, sua compagna di vita per più di quarant’anni: è il gioco degli incroci continui fra realtà e finzione – le coppie Kidman-Cruise, Alice-Bill – come il vero e finto Lee Ermey in Full Metal Jacket.
Anche il valzer di Sostakovich (e non di Strauss, perché non siamo più a Vienna), timbricamente esuberante, estroso nel ritmo, velatamente caricaturale, fa da controcanto alla rigorosa simmetria del montaggio alternato che scandisce prima i rituali dei preparativi alla festa, poi il dipanarsi secondo prestabilite linee-guida di una giornata-tipo di Alice (donna, moglie e madre premurosa) e Bill (medico scrupoloso legato al lavoro, alla famiglia, ai doveri sociali). Alice avverte il disagio, sente di non corrispondere più all’immagine che il marito ha di lei; vuole essere (ri)conosciuta. Nel bagno, prima della festa, chiede al marito di essere guardata ma egli, continuando a specchiarsi, afferma di non averne bisogno, di sapere già com’è. Il bagno è lo spazio simbolico dove all’intimità dei corpi – Alice sta orinando – non corrisponde l’intesa delle menti. In un’analoga scena ne La notte di Antonioni, Jeanne Moreau, nuda nella vasca da bagno – anche qui un marito e una moglie si apprestano ad andare a una festa alto-borghese nel corso della quale entrambi avranno incontri galanti – cerca invano lo sguardo (in)differente del marito (Mastroianni). Ma Eyes Wide Shut non è un film sulla crisi della coppia in senso antonioniano. La crisi, che deriva dalla rottura dello stato fusionale – uno stato che inconsciamente nasce dal bisogno di restaurare l’originario rapporto simbiotico fra madre e figlio, espresso nel mito della condizione paradisiaca dell’essere nel Tutto senza divisione fra sé e il mondo, fra l’Io cosciente e il non-Io inconscio – non porta all’estraneità, alla lontananza siderale o ad una strind-bergmaniana distruttività, ma alla trasformazione della coppia.
Il tradimento di Alice – non necessariamente un’altra relazione, reale o solo immaginata, ma anche un’autonomia di giudizio, un interesse, una qualsiasi diversità dall’altro può assumere i connotati del tradimento – rompe l’immobilismo simbiotico che rischia di compromettere l’identità di ciascuno. Bill, guardandosi narcisisticamente allo specchio, crede di vedere anche Alice. L’infedeltà della donna – che nella mente di Bill prende ossessivamente le forme stereotipate del tradimento sessuale (gli inserti in bianco e nero), ma che nel sogno di Alice risulta ancora più complessa, ambigua e o-scena (e infatti rimane fuori-scena, affidata solo al racconto e non alle immagini) – è il punto di partenza per entrambi di un processo di individuazione e di una conoscenza di sé attraverso il confronto con la diversità dell’altro. Lo sviluppo della coscienza di Bill che Alice ha suscitato – non fu già Eva a infrangere il paralizzante stato fissionale dell’essere nel Tutto e a spingere Adamo verso la conoscenza? – prende le forme di un simbolico rituale iniziatico (che rimanda anche al Flauto magico mozartiano) con prove da superare, parole-chiave da conoscere: Danimarca, che nella Traumnovelle rimandava all’ufficiale danese incontrato da Alice, è sostituita da Fidelio, titolo incompleto della Rettungsoper beethoveniana, Fidelio, o dell’amore coniugale, che esalta il rapporto coniugale e la pervicacia di una donna pronta a tutto pur di liberare il marito dalle catene.
Un processo di individuazione difficile, non privo di pericoli, dal quale entrambi riescono a uscirne “senza danno” (come dice Alice nell’epilogo) e “lucky to be alive” (come è scritto sulla prima pagina del New York Post che Bill compra nel suo vagare notturno), grazie al loro parlarsi e affidarsi a un reciproco racconto. Siamo distanti dalla antonioniana inaffidabilità del linguaggio come strumento di comunicazione e vicini -in un’epoca che ha sancito la fine delle Grandi Narrazioni e nella quale la comunicazione comunica solo a se stessa – a una valorizzazione delle micro-narrazioni. Dopo una notte di racconti, i due si ritrovano ancora a parlare pur nel frastuono e nel kitsch di un enorme negozio di giocattoli. Hanno compreso di essere “intessuti della stoffa di cui son fatti i sogni” (W. Shakespeare), che “la vita è una maniera del sogno o che il sogno è una maniera della vita” (J.L. Borges); hanno rinunciato alla speranza di sfuggire all’incertezza del vivere, a un legame tanto idealizzato quanto illusorio nella sua mortifera fedeltà; hanno rinunciato al “per sempre”, ma non a una vita insieme come accadimento continuo, conoscenza reciproca, racconto interminabile di parole e di corpi. Il fuck, parola finale del film – volutamente anti-romantica per meglio prendere le distanze da ogni “ortodossa”, conclusiva, concezione dogmatica dell’amore coniugale alla Denis de Rougemont – non è né un volgare sberleffo, né un prosaico ritorno alla mera corporeità (semmai è La notte a concludersi con un improvviso quanto disperante amplesso); è una proposta, è il pensiero del desiderio, è Eros e Psiche, Logos ed Eros, scelta consapevole di un modo (stra)ordinario per celebrare il rapporto con l’altro, la vita e la possibilità di generarla.
Il nudo femminile con il grembo gravido in un quadro del bagno di casa Ziegler è messo in contrasto con il corpo nudo della donna devastato dall’eroina: il corpo e la morte (come nella scena all’obitorio), il corpo che genera la vita. Non si può non accennare al ruolo della figlia di Alice e Bill, Helena (e ai quadri della figlia di Kubrick, presenti nel film), il cui ruolo è importante tanto nella novella di Schnitzler quanto nel film. La Traumnovelle si apre con la voce della bimba che legge una fiaba ispirata a Le mille e una notte. In Eyes Wide Shut Helena legge lo Schiaccianoci, non a caso la storia di un sogno (il sogno inquietante di Clara che deve salvare il suo principe/schiaccianoci da topi e pipistrelli) e di una notte di Natale, la festa che celebra al tempo stesso una nascita e la morte di un anno presente in quasi ogni scena del film con il sublime kitsch delle sue luci colorate e dorate. La Traumnovelle si conclude con il “chiaro riso” della bimba che apre “il nuovo giorno”. Nel film è il pensiero di Helena, che sta per svegliarsi, a spingere Alice e Bill, dopo una notte di pianto e smarrimento, a cominciare “il nuovo giorno”. E se la responsabilità parentale è alla base di ogni cura per l’altro come afferma Hans Jonas, l’autore de Il principio di responsabilità, l’ineludibile bisogno del bimbo è il “paradigma ontico” del non poter essere se non in relazione all’altro.
Maschera e volto
“La maschera è un istrumento misterioso, terribile. A me ha sempre dato e continua a dare un senso di sgomento. Con la maschera siamo alle soglie di un mistero teatrale, riaffiorano i demoni, i visi immutabili estatici che stanno alle radici del teatro”
(G. Strehler, in D. Sartori, Maschere e Mascheramenti)
In Eyes Wide Shut la maschera è segno e strumento dell’eclissi dell’identità, dell’addentrarsi dell’Io nel labirinto notturno, dove l’inconscio è l’incontrastato signore dei sogni. Le maschere nella scena dell’orgia – per varietà di forme, di colori e di intarsi degne di un carnevale veneziano – rinviano all”incipit de Il Casanova di Federico Fellini, un film in cui le visioni di sesso ridotto a performance meccanica non sono lontane da quelle dell’orgia kubrickiana e dove le movenze di Casanova con la donna-manichino – immagine estrema della negazione della possibilità di relazione con l’altro – sono simili al ballo in maschera fra “sconosciuti”, sulle ironiche note di Strangers in the night. La maschera è presente in tutte le tappe del viaggio di Bill nelle stanze più intime e oscure del suo essere; ma il percorso non è leggibile inequivocabilmente in. chiave onirica (come in alcune sequenze bunueliane, chiaramente ascrivibili alla dimensione del sogno/allucinazione), in quanto il registro narrativo usato è fortemente realistico: basti pensare all’attenta ricostruzione di New York, notturna ed equivoca, assai simile a quella di Fuori orario di Scorsese. Oniriche e/o reali, le scene traggono forza dalla loro ambiguità, simile all'”incertezza” o “esitazione” fra fantasia e realtà che Todorov riteneva propria del genere fantastico.
La maschera si frappone fra pulsioni di vita e pulsioni di morte. Il livido pallore, l’immobilità, la fissità dei tratti e l’assenza di sguardo della morte sono anche caratteristiche della maschera. Una maschera è nella stanza dove giace il cadavere del padre della figlia che dichiara il suo folle amore all’incredulo Bill. Maschere primitive sono appese al muro della stanza da letto della prostituta disposta a offrire sesso e un probabile contagio mortale. Di maschere e inquietanti manichini è affollato il negozio nel quale Bill prende in affitto il suo costume e dove assiste a una strana quanto perversa ronde fra due uomini e la ‘Politissima” figlia del proprietario. Durante l’orgia è Bill a indossare la maschera e più che mai potrà vedere l’anima animale sullo schermo notturno della scena onirica. Se nell’orgia felliniana de La dolce vita la brutalizzazione raggiunge il suo acme nel momento in cui una donna, cosparsa di vino, viene ricoperta di piume per essere resa simile a una gallina, nell’orgia di Eyes Wide Shut lo scardinamento delle più elementari leggi morali della convivenza è ancora più marcato per poter meglio alludere agli abissi sconosciuti, ai demoni e alle pulsioni inconfessate dell’inconscio. Il mascheramento, la danza, i passi ritmici, i comportamenti osceni di coppie simboliche, la segretezza – Bill come Penteo viola i sacri riti e deve essere punito – rimandano ai riti dionisiaci dai quali il teatro, antenato del cinema, ha tratto la sua origine.
L’orgia kubrickiana non è solo sogno, discesa nel mondo infero; è una “sciarada”, una “fìnta”, una “messa in scena”: con queste parole la definisce Ziegler nell’episodio estraneo alla Traumnovelle, che Kubrick aggiunge con l’intento di proporre metafilmicamente una riflessione sulla “messa in scena”, sulla “finzione”, sul cinema. Il pensiero corre alla “mescolanza di affinità e di scarti”, individuata da Christian Metz, fra “stato filmico” e “stato onirico” e alle riflessioni di Melanie Klein sul sogno come “teatro privato”, come “messa in scena” di una rappresentazione – riguardante le figure interne al sognatore e la loro relazione con il mondo – che diventa conoscibile solo attraverso la sua narrazione. Il racconto di Ziegler è la narrazione dell’avventura (onirica), è lo spazio dove si teatralizza il sogno già sognato, è il tentativo di “smascherarlo”, di decodificarlo, volutamente non riuscito nella sua interezza perché comunque un film (un sogno) non può mai essere esaustivamente svelato; può tuttavia “esistere” e diventare strumento di conoscenza attraverso il racconto che lo spettatore/critico, dopo la visione a occhi aperti, narra a se stesso con eyes wide shut (come sul lettino con le spalle rivolte all’analista, e pertanto a occhi chiusi, si racconta il sogno già sognato).
E come se Kubrick avesse voluto spostare l’accento sul racconto che nasce dalla creatività della “relazione di coppia” fra il film e chi lo fruisce. Un racconto che, se da un lato non esaurisce i significati del film – sconcertanti in Eyes Wide Shut nel loro continuare ad abitare il sogno schnitzleriano e al contempo a scaturire da un nuovo atto creativo – dall’altro continuamente trasforma chi il film lo avvicina, lo legge, lo ascolta. Un racconto interminabile, che si smarrisce nelle continue possibilità di dire, nelle infinite impossibilità di significare, nei vuoti… nei punti di silenzio… nel senso ritrovato e poi perduto… nel desiderio e nella paura del-non-anco-ra-pensato… del-non-ancora-scritto… con gli occhi chiusi.
* * *
La logica dell’inconscio in Eyes Wide Shut
Kubrick contro Eros
Il desiderio e l’impossibile in una riscrittura del racconto di Amore e Psiche
Di Giovanni Bottiroli
“Bambino!, sì, siete un bambino – ella disse reprimendo qualche lacrima; – voi sareste capace di amare sinceramente, voi!”
(H. de Balzac, Papà Goriot)
1. La psicoanalisi aiuta a comprendere e a riconoscere le opere d’arte, le opere d’arte aiutano a comprendere la psicoanalisi. Le opere d’arte – anche quelle imperfette (ma quante di esse, diceva Proust, sono cattedrali incompiute?) – le opere d’arte offrono alla psicoanalisi l’occasione per allontanarsi dalla propria versione stereotipata, e per riproporre il carattere problematico della ricerca inaugurata da Freud. Eyes Wide Shut ha certamente questo merito: ci costringe a chiederci “che cos’è la psicoanalisi?”, e quali siano gli strumenti che essa può offrirci per un tentativo di interpretazione che non pretende di sostituire l’intera valutazione estetica. Un’analisi stilistica dell’ultimo film di Kubrick richiederebbe più tempo, e altri strumenti: tuttavia molti dubbi sulla necessità delle scelte compiute da Kubrick possono essere affrontati, credo, solo immergendo questo film nel campo teorico della psicoanalisi.
2. Da Vienna a New York: realtà e verosimiglianza
La trasposizione del racconto di Schnitzler nella metropoli contemporanea potrebbe essere un errore estetico: nel corso degli ultimi decenni i sentimenti di colpa rispetto al tradimento coniugale, e in genere rispetto alla sfera del sesso, si sono fortemente indeboliti; la definizione della nostra identità è diventata assai più elastica; ci accontentiamo di assemblare le nostre esperienze, rinunciando volentieri alla coerenza e alla ricerca del significato. Se questa è la realtà di fine secolo, è certamente lo è in misura maggiore a New York rispetto alla provincia, e quando i protagonisti riflettono una condizione sociale privilegiata, la ripresa di un testo come la Traumnovelle, con le sue curiosità per il sesso e i tormenti del Super-io, può suscitare molti dubbi.
Quella borghesia non esiste più. Il soggetto borghese postmoderno vive sempre più serenamente la propria “disidentità”: siamo tutti molteplici, si dice, siamo tutti nomadi. Lo siamo, lo diventeremo; nel postmoderno la dilatazione del presente fa incombere qualunque utopia, giornalisticamente credibile. Se la nuova, o l’imminente condizione femminile, è rappresentata dalle donne descritte da Rosi Braidotti, da Judith Butler, da Teresa De Lauretis, o dal Manifesto cyborg della Haraway1, allora le lacrime di Alice nel film di Kubrick, le sue lacerate fantasie di adulterio possono apparire davvero anacronistiche.
Lungi dall’offrirci “la verità sul sesso”, così come ci avrebbe dato la verità sulla violenza in Arancia meccanica o il film definitivo sul Vietnam in Full Metal Jacket, Kubrick sarebbe incorso in un clamoroso infortunio. Queste obiezioni devono venire discusse preliminarmente.
Nel suo libro su Dostoevskij, Bachtin osservava che “non ogni uomo è un materiale egualmente favorevole per la raffigurazione artistica”. Perciò Dostoevskij avrebbe rapidamente abbandonato l’impiegato gogoliano, che forniva troppo limitate possibilità, a favore di personaggi più ricchi di autocoscienza2. Credo che queste considerazioni siano del tutto pertinenti per giudicare il lavoro di Kubrick. Egli avrebbe potuto scegliere personaggi “più contemporanei”, più nomadici e più euforicamente perversi. Bisogna chiedersi tuttavia se la disidentità di questi personaggi possibili, la loro adesione a una molteplicità che rifiuta ogni presenza del Super-io come paterno, patriarcale, repressivo e veteroborghese, non offra “troppo limitate possibilità” sul piano artistico. Come gli impiegati di Gogol, i soggetti nomadi e perversi (con tutte le varianti cibernetiche) dell’immaginario contemporaneo sono troppo semplici in quanto mancano di quel “gradino” all’interno della psiche che è precisamente l’Ideale dell’Io (Freud), e che non è semplicemente un’istanza di repressione, ma un fattore di complessità3; esso aumenta le interazioni nella psiche, e fa dell’Io non un banale esecutore dei capricci pulsionali, bensì lo sfortunato “servo di tre padroni”. Sfortunato e minacciato dalla bêtise – di fronte alle domande della libido, perfino l’uomo più intelligente rischia sempre di apparire stupido.
Kubrick avrebbe dunque individuato nel racconto di Schnitzler dei personaggi favorevoli alla raffigurazione artistica. Poco importa che, sul piano meramente statistico, essi possano risultare scarsamente rappresentativi dell’attualità. Ciò che vediamo è la realtà di due personaggi per cui il legame di coppia non è desueto e privo di motivazioni (non convenzione o ipocrisia, come per Ziegler): tuttavia questo legame appare, inizialmente, come assopito. L’impossibilità di “fare Uno” è un’utopia dimenticata, al sogno di una fusione reciproca è subentrata un’intimità dove prevalgono i momenti banali o volgari (Alice che fa pipì in presenza del marito). La festa li espone nuovamente al desiderio, e ciò che conta è che i protagonisti siano tali da essere realmente esposti alla “tentazione”: in effetti essi sono estremamente desiderabili (e non solo desideranti, come può esserlo ciascuno di noi). Inizia così la loro storia. Storia doppia, e asimmetrica in quanto le relazioni erotiche di Alice sono soltanto fantasticate, mentre quelle di Bill sono reali (sia pure, ovviamente, nella finzione narrativa).
Perché questa asimmetria? Dice Goethe che non al “perché”, ma al “poiché” si deve cercare una risposta4. Poiché Schnitzler e Kubrick ci presentano una storia asimmetrica, bisognerà cercarne le ragioni all’interno della narrazione o magari all’esterno, cioè nell’ombra che l’opera d’arte proietta come se fosse un corpo. Non l’ombra verticale e spezzettata di eventuali metafore o simboli, bensì l’ombra orizzontale e globale di una possibile allegoria. Il film di Kubrick non è né onirico né simbolico, ma non può fare a meno, come molte narrazioni perfettamente conchiuse in se stesse, di proiettare un’ombra mitica o allegorica.
Eyes Wide Shut potrebbe essere il rovescio, o comunque una riscrittura, della favola di Amore e Psiche. Nel romanzo di Apuleio, Eros fugge da Psiche dopo che lei lo ha scottato con alcune gocce d’olio bollente cadute dalla lampada; anche qui Eros fugge, e stavolta a causare la sua ferita è la confessione di un adulterio mancato. Ma mentre Apuleio ci racconta le disavventure e le prove a cui viene sottoposta Psiche, Kubrick (tramite Schnitzler) ci mostra le umiliazioni di Eros.
3. Poiché non esiste rapporto sessuale
Che il dottor William Harford vada incontro a una serie di frustrazioni e di insuccessi erotici, è del tutto evidente. Dopo la sua fuga dal letto coniugale, Eros (Bill) rinuncia a un’affascinante prostituta, subisce una dichiarazione d’amore non realizzabile, almeno nell’immediato, viene introdotto a un’orgia dalla quale viene ignominiosamente scacciato. Torna a cercare la prostituta, Domino, e viene a sapere che essa è sieropositiva. Quanto alla donna che lo ha salvato, in uno slancio di abnegazione che sembra presupporre un’infatuazione misteriosa e irresistibile, Bill ne ritrova il corpo in un obitorio, irrigidito e reso inaccessibile dalla morte.
Alle frustrazioni di Bill sembra contrapporsi il godimento di un’élite neanche troppo misteriosa. Esiste un paradiso del piacere – “non ho mai visto tante donne così stupende” racconta Nick Nightingale – ed è questo paradiso, con i suoi iniziati, a scatenare il desiderio mimetico del protagonista. Alla menzogna romantica dell’amore coniugale subentra dunque la verità romanzesca del desiderio suscitato da un mediatore5. Si desidera solo tramite un altro, e nella convinzione che l’altro abbia accesso al godimento. Ma l’altro gode davvero? O il paradiso resta per tutti inaccessibile?
La famosa tesi di Lacan “non esiste rapporto sessuale” è indispensabile per interpretare ciò che vediamo nella scena dell’orgia. Tutto l’episodio è dominato da una straordinaria ambiguità: niente di più affascinante, niente di più assurdo, del rito a cui il dr. Harford riesce ad assistere. Il grottesco minaccia ad ogni istante di irrompere nella serietà della cerimonia, e l’aspetto spudoratamente fallico della maschera che trascina via la donna che ha deciso di immolarsi va ad aggiungersi, suscitando un sorriso, ai movimenti meccanici dei corpi impegnati in copulazioni insensate. Ma passare al riso non è possibile. Quando si ride, si ride sempre di un individuo o di un gruppo di individui, e qui non ci sono più individui. I volti sono diventati maschere, i corpi mantelli. A questa condizione il rito trasmette il proprio fascino ipnotico. Esso rivela e nello stesso tempo nega il vuoto, il niente, a cui tenta di aggrapparsi il piacere sessuale.
4. “Puer” e “senex”: l’individuo e il branco
Chi sono gli happy few? E lecito avere delle forti perplessità sulla lunga scena che si svolge a casa di Ziegler, nel salone con il biliardo, scena poco intensa e, si direbbe, non propriamente necessaria. Si tratta, fra l’altro, della sola scena che Kubrick ha aggiunto alla storia di Schnitzler. Pur condividendo molte di queste perplessità, credo ci sia un motivo che può giustificarne la presenza (non faccio ipotesi sulle intenzioni di Kubrick, mi limito a giudicare il testo, il film): essa ci offre un’indicazione inequivocabile – anticipata dal personaggio che consegna silenziosamente una lettera a Bill6 – dell’identità del branco.
Il branco, l’orda. In quello che Lacan considera l’unico, e comunque il più suggestivo mito creato nel nostro secolo, cioè il racconto di Totem e tabù, Freud immagina (ispirandosi a Darwin) che nei tempi primordiali la vita sociale consistesse in gruppi guidati e dominati da un maschio maturo. Questo padre geloso teneva per sé tutte le femmine e scacciava i figli man mano che crescevano. Un giorno i figli si ribellarono e lo uccisero. Questo il mito che Freud ci ha consegnato (con tanta fede nel suo racconto da crederlo forse il rispecchiamento di eventi reali). Per noi si tratta in ogni caso di un mito: e poiché un mito non è un testo statico, poiché vive – come ci ha insegnato Lévi-Strauss – nella serie delle sue trasformazioni, siamo autorizzati a pensare che la coppia Schnitzler-Kubrick ne abbia elaborata una. In questa variante, le identità numeriche sono rovesciate: non un solo padre e numerosi figli, bensì il branco dei padri e il figlio.
Ecco uno dei contributi che il film di Kubrick offre per una comprensione non stereotipata della psicoanalisi: ci ricorda che in Freud la figura del padre non è soltanto quella del racconto di Edipo, dove il padre viene ucciso dal figlio (ma il mito comprende un episodio che Freud sembra aver dimenticato: l’infanticidio tentato da Laio)7; l’immagine freudiana del padre viene completata in Totem e tabù, con il ritorno sulla scena del padre geloso, detentore esclusivo delle donne.
Anche la scena primaria ci viene dunque presentata da Kubrick in una variante collettiva: il bambino che penetra abusivamente nella camera dei genitori e osserva il rapporto sessuale viene sostituito dal giovane che, grazie a una parola d’ordine ironica (Fidelio: sottotitolo “L’amor coniugale”) entra nella casa dell’orgia, dove il branco gode di donne stupende. Gode, o tenta di godere. I mantelli e le maschere conferiscono una dignità superiore, ma nascondono corpi invecchiati, indecenti, l’impotenza vergognosa di chi preferisce o è costretto a guardare. Almeno in un certo numero di casi; e per quanto riguarda coloro che realizzano l’orgia, l’unico aspetto capace di suscitare invidia e desiderio mimetico è la possibilità di fare ciò che fanno. “Io (le) scoperei meglio” è il pensiero che accompagnerà il puer scacciato dal paradiso, la spina nella carne che lo indurrà a tornare.
Perché i padri sono molti? Perché la figura del padre è stata moltiplicata nel branco? Ancora una volta dobbiamo intendere la domanda “perché?” non come la richiesta di nessi causa-effetto – la psicanalisi è sovente tentata dalla spiegazione causale, ma il suo vero oggetto “ha un’essenza differente, una densità psicologica concreta”, è il senso (Lacan)8 – e piuttosto come l’invito a non trascurare nessuno degli effetti testuali. Se, ad esempio, ci chiediamo perché Kubrick abbia scelto un attore dalla recitazione non sempre persuasiva come Tom Cruise, troveremo forse una risposta, sul piano testuale, nella bellezza dei suoi lineamenti un po’ adolescenziali esposti allo sguardo aggressivo del branco: Tom Cruise non è un cattivo interprete nel ruolo del puer.
La nozione di “puer” è stata introdotta da Jung ed è stata approfondita dalla scuola junghiana; la ripropongo qui in un’accezione prevalentemente freudiana, in relazione al mito dell’orda primitiva. Ciò che non dobbiamo mai perdere di vista, per evitare di cadere in un’applicazione meccanica di concetti psicoanalitici, sono i tratti semantici dei personaggi. Quali sono i tratti principali di Bill Harford? Seducente, immaturo, bambino. Immaturo perché infantile, serioso, troppo sicuro di sé – così sicuro della fedeltà di sua moglie da indurla a una rivelazione shoccante -e bambino, sempre di più: quando torna a casa dopo la prima notte, Alice lo fa coricare accanto a lei e gli accarezza i capelli, più simile a una madre che a una moglie; quando rientra nella camera da letto, durante la seconda notte, la vista della maschera accanto ad Alice addormentata lo fa scoppiare in singhiozzi. In uno stato di prostrata confusione, • Eros si rifugia piangendo presso il corpo di Afrodite.
Quanto all’orda, al branco: Bill non appartiene al branco dei senex, benché ambisca appartenervi, e neppure al branco dei giovani che egli incontra per strada, e dai quali viene oscenamente insultato. In effetti egli non appartiene a nessuno dei due gruppi: troppo “maturo”, troppo definito e riuscito per potersi mescolare ai più giovani – maschi, aggressivi, in preda al furore, capaci di intuire in Bill qualcuno che aspira al monopolio delle donne – e troppo puer per poter essere accolto nel branco dei senex. Eros si conferma un essere intermedio, vanitoso, volubile, intrigante, bugiardo, sciocco – nella realtà e nel sogno, Alice ride di lui, di un riso sguaiato e cattivo – tenero, smarrito.
5. Il terzo termine, il Fallo
Preferisco parlare di “branco dei senex” e non di “orda paterna” per evitare ogni riduzionismo edipico. E vero che i tratti paterni non sono del tutto assenti: nel già citato dialogo tra Bill e Victor Ziegler, quest’ultimo assume un atteggiamento almeno in parte protettivo e affettuoso – l’atteggiamento di un padre, costretto peraltro a confermare al figlio la proibizione della donna più desiderata. Così come non mancano tratti materni; oltre a quelli già indicati in Alice, come non giudicare “materno” il gesto di sacrificio che consente a Bill di uscire indenne dalla sua avventura?
Una versione della psicoanalisi con forte impronta edipica utilizzerebbe ancora un argomento a proprio favore: non è impossibile, e non è neanche difficile, vedere nella molteplicità dei senex la scissione dell’Uno, la proliferazione dell’unica figura paterna. Tuttavia è proprio questo genere di operazioni riduttive ad avere suscitato la stizza di Deleuze e Guattari nell’Anti-Edipo: non senza delle buone ragioni. Abbandoniamo dunque la dialettica dell’uno e del molteplice. Ma non per enfatizzare il molteplice nella sua pienezza desiderante, come in Deleuze-Guattari: con la loro battaglia contro il manque lacaniano, gli autori dell’Anti-Edipo hanno favorito molti errori e confusioni sulla “natura” del desiderio.
In breve: la psicoanalisi afferma che il desiderio è legato a un oggetto impossibile, e perciò deve scivolare lungo una catena di oggetti sostitutivi. Il desiderio sarebbe dunque vincolato a una mancanza; esiste inoltre un’asimmetria o uno squilibrio tra i sessi, perché le femmine sono “più mancanti” dei maschi. La nozione di “invidia del pene” ha suscitato le ben note ire da parte delle femministe, e a queste ire non è sfuggita neanche la distinzione lacaniana tra pene e fallo. Il fallo non è l’organo sessuale maschile, bensì un significante: un significante “eletto e problematico”, dice Lacan9. Ma, è stato obiettato, se il Fallo resta pur sempre il significante del desiderio, e se il desiderio è fomentato dalla mancanza, come non vedere in tutto ciò un semplice travestimento terminologico della freudiana invidia del pene? Il fallo sarebbe un pene duplicato.
La questione è più complessa. Il Fallo è il significante dell’impossibile, non perché (e comunque: non solo perché) il desiderio desidera un oggetto “impossibile” (vietato dal tabù dell’incesto), ma perché esso entra come terzo termine anche nella relazione duale, la più confusiva e osmotica. Il Fallo è la scissione del desiderio. Torniamo alla scena dell’orgia: che cosa desiderano, che cosa cercano i maschi nelle puttane? (Il termine è usato da Ziegler per designare e per degradare l’oggetto del desiderio di Bill, oggetto sublime per lui, e verso il quale poco prima, nell’obitorio, Bill si era piegato per posarvi devotamente le labbra). Ciò che si cerca nella prostituta, dice Lacan “è il fallo anonimo, quello di tutti gli altri uomini”10. Ciò che si cerca nell’orgia è dunque l’identificazione con il Fallo.
Comprendiamo meglio, ora, la funzione e la necessità delle maschere, e il loro effetto di fascinazione. Se la cerimonia a cui Bill assiste non è soltanto grottesca e insensata, è perché gli individui sono come assorbiti nella maschera del Fallo – il quale si dà, per l’appunto, solo come velo, come maschera. Esso è il terzo che scinde il desiderio. Non è un oggetto, benché possa venir simboleggiato da un oggetto: ad esempio, nel romanzo di Tristano e Isotta, il fallo è la spada che giace tra i corpi dei due amanti addormentati, è il segno di una divisione che sembra ipnotizzare il re Marco, e lo induce a rinunciare alla vendetta. Il Fallo non può coincidere con una persona, neanche la più desiderata, ed è perciò che il desiderio è infedele. L’ufficiale che avrebbe potuto introdursi come terzo devastante nel matrimonio di Bill e Alice rivela la sua “identità” nel sogno in cui egli è solo il primo dei molti uomini che possiedono la moglie del dr. Harford. Dice Alice (ignorando quanta verità ci sia nelle sue parole): “non so nemmeno con quanti uomini ho scopato”11.
6. Doppio inconscio
I sogni manifestano l’inconscio. Il linguaggio onirico ha una logica. “Tra le relazioni logiche – dice Freud – una sola si avvantaggia straordinariamente del meccanismo di formazione del sogno. E la relazione della somiglianza, della concordanza, della connessione…”. Nel sogno l’inconscio fa dunque prevalere la propria logica confusiva.
Se il racconto di Schnitzler e il film di Kubrick hanno un carattere onirico, non è perché confondano sogno e veglia, fantasia e realtà. Kubrick ha evidentemente giudicato questo tipo di confusione come troppo banale, e ha evitato l’insidia di troppo facili ambiguità sul piano narrativo. Il carattere onirico va riferito piuttosto al primato di una logica confusiva, alle relazioni di somiglianza e di sovrapposizioni che si creano irresistibilmente in uno spettatore, il quale guardi il film con occhi ben aperti.
Non vi è dubbio: basta osservare l’età media dei partecipanti alla festa di Ziegler per capire che questo rito mondano anticipa, ed è già, il rito che si svolgerà nella casa dell’orgia; che il maturo bellimbusto, da cui Alice viene quasi sedotta, rappresenta (al meglio) il branco dei senex; che Bill vorrebbe possedere tutte le donne, e che Alice è e non è una puttana. A collegare la festa e l’orgia ci sono elementi di connessione non metaforici (in qualche modo paragonabili a resti diurni non elaborati): il pianista, Nick, che compare in entrambi i luoghi, e la ex-miss, che viene soccorsa da Bill a casa di Ziegler, e che ricambierà il gesto salvifico nel momento in cui Bill si vedrà perduto.
Non possiamo avere dubbi: il racconto di Schnitzler-Kubrick diventa comprensibile solo tramite la logica dell’inconscio. Nella versione più divulgata – anche grazie al cinema – l’inconscio viene tuttavia considerato un serbatoio di rappresentazioni, che sono state rimosse, cioè allontanate dalla coscienza senza che la coscienza stessa sia stata resa partecipe di quest’operazione. Si pensi a Io ti salverò (Spellbound) oppure a Marnie di Hitchcock: la coscienza non ha più accesso alla scena del trauma (in Spellbound la morte del fratello minore del falso dr. Edwardes (Gregory Peck), avvenuta mentre i due giocavano quando erano bambini), ma solo a immagini sostitutive (le righe nere della vestaglia, le rotaie del treno, le tracce degli sci sulla neve, ecc). Il processo di guarigione consiste nel recupero delle rappresentazioni rimosse. Secondo questa prospettiva, l’esistenza dell’inconscio significa che il soggetto è diviso – tra sapere e non-sapere. Ed è in questa prospettiva che va intesa la celebre affermazione di Freud: “Dov’era Es, deve diventare Io”. Ma la scissione del soggetto nella teoria psicoanalitica non si riduce a questo: e l’inconscio non è soltanto un insieme di immagini appartenenti alla storia di un individuo. E anche una logica, un modo di pensare, che rende vertiginose le somiglianze e assimila tutti gli oggetti del desiderio.
Torniamo a Eyes Wide Shut. La passione per il giovane ufficiale appartiene alla memoria cosciente, o tutt’al più preconscia di Alice, e non al suo inconscio. Al suo inconscio appartiene invece il desiderio di essere posseduta da un numero illimitato di uomini, con il marito nel ruolo di spettatore. Svegliandosi dal sogno che realizza allucinatoriamente questo desiderio, la donna viene sopraffatta dal senso di colpa e si abbandona alle lacrime. Dunque nel sogno di Alice la logica del desiderio cancella i tratti individuali dell’oggetto, e li rende anonimi: è il Fallo anonimo, quello di tutti gli altri uomini, che Alice vorrebbe avere. Dovrebbe essere evidente che quest’oggetto di desiderio non è un oggetto: esso può presentarsi solamente celato in una maschera12.
7. Kubrick e Kleist
La maschera posata sul guanciale, accanto a Alice immersa nel sonno, vale come ammonimento a non sfidare il potere dei senex13, ma è anche il punto di congiunzione tra le avventure notturne di un marito e di una moglie. Che Bill e Alice si ritrovino uniti accanto alla maschera – il terzo termine, il Fallo – è una formidabile conferma dell’idea che ispira la psicanalisi lacaniana: l’incontro sessuale è sempre un incontro mancato.
Nell’Anfitrione (1807) di Kleist il terzo termine è Zeus, che scende sulla terra assumendo le sembianze del marito di Alcmena. Benché lo guardi con occhi bene aperti, Alcmena non riesce a capire se la persona che le sta di fronte, e che l’ha posseduta per una notte interminabile, sia o non sia suo marito. Ma non sono unicamente gli effetti confusivi che sovvertono l’amore coniugale a suggerire un rapporto tra l’opera di Kubrick e quella di Kleist. In entrambi i casi dobbiamo ammirare l’audacia delle battute conclusive. “Ahimé” dice Alcmena; “Dobbiamo scopare” (Let’s fuck) conclude Alice. In entrambi i casi, al di là dell’apparente divergenza, si ha la sensazione di una ferita che non potrà rimarginarsi. Vi è inoltre una somiglianza stilistica, che riguarda la tecnica del dialogo. Nella meravigliosa Scena quinta del Secondo atto, che Thomas Mann ha commentato quasi “alla moviola”, Kleist fa ripetere alla sua eroina le domande che Zeus le ha rivolto. “Ella ripete le sue parole, pensa”14. La necessità di questo raddoppiamento risiede nella densità enigmatica del significato. Che cosa viene chiesto esattamente in ciò che viene chiesto? Kubrick usa questa tecnica più diffusamente, e non sempre riesce a trasmettere la percezione della sua necessità. E anche per questo motivo che nella parte finale si riscontra una certa lentezza: uno dei difetti che, se avesse avuto ancora tempo, Kubrick avrebbe potuto correggere, e che danno al suo grande film il carattere dell’incompiuto.
NOTE
1 Cfr. R. Braidotti, Soggetto nomade. Femminismo e crisi della modernità, 1994 (trad. it. Donzelli, Roma 1995; J. Butler, Corpi che contano, 1993 (trad. it. Feltrinelli, Milano 1996); T. De Lauretis, Pratica d’amore. Percorsi del desiderio perverso, La Tartaruga, Milano 1997; D. Haraway, Manifesto cyborg, 1985 (trad. it. Feltrinelli, Milano).
2 Bachtin, Dostoevskij. Poetica e stilistica, 1963 (trad. it. Einaudi, Torino 1968, p. 68).
3 Non nego che un perverso possa raggiungere un’identità complessa, ma la perversità non è condizione sufficiente. Non è facile uscire dagli stereotipi – lo dimostra l’ultimo film di Almodóvar, in cui i ruoli previsti per il transessule restano quelli del maudit e del clown. Nella dinamica stessa della perversione – se è possibile, perché non farlo? – sono presenti la tentazione della semplicità e il disinteresse per il ridicolo.
4 “Come? Quando? E dove? Muti gli dei devono restare! // Tu attienti al poiché, e perché? non domandare” (Wie? Wann? und Wo? – Die Götter bleiben stumm! // Du halte dich ans Weil und frage nicht Warum?).
5 Per la nozione di “desiderio mimetico” si rinvia naturalmente a R. Girard, Menzogna romantica e verità romanzesca, 1961 (trad. it. Bompiani, Milano).
6 Si tratta verosimilmente di un servo (così è in Schnitzler). Ma il suo volto incartapecorito non mi sembra casuale.
7 Cfr. J Hillman, Variazioni su Edipo, 1987 (trad. it. Cortina, Milano 1992).
8 J. Lacan, Gli scritti tecnici di Freud. Il seminario, libro I (1953-1954), trad. it. Einaudi, Torino 1978, p. 3.
9 J. Lacan, Seminari 1956-1959 (raccolti e redatti da J.B. Pontalis), trad. it. Pratiche, Parma 1978, p. 90.
10 Ibidem.
11 Sono costretto a far riferimento alla versione italiana. In ogni caso, il “quanti” potrebbe avere anche il valore di “quali”.
12 Il Fallo è maschera perché nasconde-rivela una logica, la dimensione logica e modale del desiderio, non perché cela qualcosa o qualcuno.
13 E non solo come lapsus. Al testo di Schnitzler è stato infatti aggiunto il minaccioso pedinamento, ordinato da Ziegler.
14 Th. Mann, L”‘Anfitrione” di Kleist. Una riconquista, 1926 (trad. it. in Nobiltà dello spirito, Mondadori, Milano, p. 572).
* * *
Il tema dei soldi e del potere in Eyes Wide Shut
Doppi sogni che il denaro può comprare
L’ultimo film di Kubrick si rivela come il suo più politico, un complicato gioco sul circuito denaro/merce/denaro
“Cara, hai visto il mio portafoglio?”: questa domanda rivolta dal dottor Harford alla moglie nel loro appartamento in Central Park West, mentre si preparano per uscire, è la prima frase che si sente in Eyes Wide Shut. Se ogni titolo è una chiave di lettura per il testo, ogni incipit è la spia di un sottotesto: a partire da questa prima scena, in cui il piano-sequenza in steadycam sembra puntualizzare gli spazi abitativi e il loro corrispondente valore in denaro e in status symbol, il tema della ricchezza ritorna puntuale, ossessivo.
L’arrivo a palazzo Ziegler chiarisce il livello architettonico dei rapporti di potere: il lussuoso appartamento degli Harford non è comunque paragonabile con questa minireggia nel pieno centro di New York; un luogo in cui, come c’informerà il corteggiatore ungherese della signora Harford, al piano di sopra c’è un vero e proprio museo di bronzi del Rinascimento. “Conosci qualcuno qui?” chiede Alice, che non riesce a capacitarsi dell’invito a una festa così elitaria; e il marito ammette di non conoscere nessuno, di essere un estraneo in quell’ambiente di vera borghesia finanziaria, di veri ricchi. O meglio, l’unica persona conosciuta è il vecchio collega universitario Nick Nightingale, che dopo l’abbandono degli studi di medicina si è ridotto a fare il pianista, lavorando dove capita (e comunque lontano da Seattle, dove abitano la moglie e i figli): questo incontro stabilisce una scala nella gerarchia economica (Vélite finanziaria, la classe media dei young urban professionals, il neo-lumpen metropolitano dei cosiddetti working poors) che resterà costante in tutte le triangolazioni della storia.
Il lungo ballo fra Alice e l’ungherese, che ha per tema principale il rapporto fra il matrimonio e il libertinaggio sessuale, introduce comunque sottilmente l’equazione fra capacità seduttiva e possibilità economica: quando la signora Harford ammette che sta cercando lavoro nel settore del mercato dell’arte (è il caso di sottolineare che la moglie di Kubrick, Christiane Harlan, è una pittrice?), l’elegante straniero non manca d’informarla che egli ha buone conoscenze in quel settore. È il lato oscuro del mito di Don Giovanni: la fascinazione del potere è una promessa di magico problem solving, uno spiraglio sul mondo della libertà. Del resto, anche le due ragazze che stanno corteggiando Bill vogliono portarlo “dove finisce l’arcobaleno”; ovvero dove, secondo la favolistica popolare, si trova la pentola dell’oro.
Non è un caso che tutta la storia si svolga in periodo natalizio: il natale è esattamente la festa che maggiormente evidenzia la contraddizione fra gli originari contenuti religiosi (la nascita del Cristo come “buona novella”, annuncio che tutti gli esseri umani sono uguali) e la rilettura merceologica (le festività di fine anno come obbligo al regalo e dunque compulsione all’acquisto). Vediamo mamma e figlia incartare il regalo per il papà: un costoso volume sull’opera di Van Gogh, artista morto povero e le cui opere hanno adesso un valore feticistico valutabile in miliardi di lire. La modernità e la povertà di Van Gogh, il cui acceso cromatismo sembra affiorare nelle immagini del film (anche attraverso le tele firmate da Christiane Kubrick), entrano in antitesi con la classicità e la ricchezza dei bronzi rinascimentali: anche se, ovviamente, la vera questione è che gli Ziegler possono permettersi di collezionare delle opere originali, mentre gli Harford si limitano a guardare delle riproduzioni.
Che si accorra nel bagno del proprio amico miliardario (e che ha tele appese anche in bagno), o che si accorra al capezzale del proprio paziente senatore appena morto, la disponibilità del medico è connaturata all’etica professionale ma anche al legame economico che intercorre fra il lavoratore e il suo cliente pagante: tutte le relazioni diadiche del film, eccetto la relazione matrimoniale fra i due protagonisti, sono relazioni economiche (a cominciare da quella che inizialmente lega la piccola Helena alla babysitter – per finire con quella che lega la piccola Helena alla bambola Barbie). “E adesso che dobbiamo parlare di denaro?” chiede Bill alla giovane prostituta che l’ha introdotto nel proprio appartamentino (da studentessa di sociologia – con un destino parallelo a quello del medico mancato Nightingale) al Village: mentre l’amore non si può comprare (ed è forse questa la tragedia della totale inaffidabilità dei sentimenti come base dei rapporti sociali), il sesso in quanto servizio professionale è valutabile sia in termini di tipologia della prestazione sia in termini d’impegno temporale. Bill non ha pagato per entrare alla festa Ziegler e, in cambio, non si fa pagare per la sua “consulenza” riguardo la ragazza in overdose; il dottor Harford si fa pagare per palpare il seno delle proprie clienti e, in base al paradosso del matrimonio, non paga per stringere il seno della moglie (l’immagine di sesso allo specchio è, giustappunto, speculare rispetto alla scena della visita in ambulatorio) ma paga la “seduta” con la prostituta, il cui appartamento ad uso professionale è il controcampo dello studio medico del suo cliente.
Pagare per entrare: in questa metafora sessuale è racchiuso il segreto dell’ossessione architettonica di Eyes Wide Shut, il cui protagonista è sempre ripreso nella sua difficoltà o facilità rispetto al superare una soglia. Gli Harford entrano a casa Ziegler su invito ufficiale dei padroni di casa (e poi Bill viene chiamato ad entrare nella sala da bagno, dove si trovano due donne nude, una reale e l’altra dipinta); Bill entra a casa del senatore chiamato telefonicamente per dovere professionale (dopo averlo visto nell’androne, lo seguiremo fino alla penetrazione nel sancta sanctorum, dove lo attendono un uomo morto e una ragazza che lo bacerà – Eros e Thanatos nella stessa stanza, ovviamente da letto); dopo l’obbligo mondano e l’obbligo professionale, l’invito della prostituta Domino (“Vuole venire dentro con me?”) si configura come un primo passo in questa sorta di viaggio nel libero mercato. Invece di tornare a casa dalla moglie, il dottor Harford s’infila (sempre dopo essersi fermato sulla soglia) nel Sonata Cafè, controcampo del tetto coniugale: un luogo contraddistinto dal nomadismo tanto degli artisti quanto dei fruitori; libera circolazione mediata dal denaro.
La scena più emblematica di questa simbologia della soglia è quella all’esterno del negozio di costumi Rainbow: Bill chiacchiera con il padrone del negozio attraverso una grata, e (dopo aver tirato fuori il portafoglio per mostrare il proprio tesserino di riconoscimento) deve concordare una cifra supplementare per l’entrata; un altro cancello carcerario introduce nel negozio vero e proprio (luogo dei manichini e delle maschere, luogo delle identità o disidentità a pagamento) e, infine, un’altra vetrata introduce nell’ennesimo sancta sanctorum, dove si consuma una scena sessuale nient’affatto gratuita (in nessun senso). C’è un rapporto direttamente proporzionale fra il grado di estraneità della Donna (una componente della quale è l’età anagrafica) e la sua appartenenza alla sfera economica: il percorso Alice-Marion-Domi-no-figlia di Milich è davvero un allontanamento dalla casa intesa come famiglia (luogo della familiarità, della conoscenza personale) e un avvicinamento a “dove finisce l’arcobaleno” e si trova solo la logica del denaro (non per niente il Rainbow è un negozio, e la ragazza – al contrario della Barbie del negozio di giocattoli del finale – non ha un nome, essendo la sua identità inessenziale rispetto alla funzione merceologica).
Bill, nome del protagonista di Eyes Wide Shut, è un sostantivo che ha molti significati, alcuni dei quali ce lo fanno qualificare come un nomen-omen (un nome che designa il destino di colui che lo porta): bill è la lista degl’invitati alla festa, è il conto che viene pagato al Sonata Cafè o al Rainbow, è l’elenco dei degenti ospedalieri che il dottore consulta prima di andare all’obitorio; bills sono i cartelloni che arredano la scena metropolitana e, soprattutto, le banconote che il dottor Harford tira fuori per pagare la prostituta Domino o il taxista che lo porta alla reggia di Somerton e lo attende fino alla conclusione dell’orgia. Bill è l’iniziale di “billionaire” (miliardario) e anche dell’espressione “bill and coo” (il tubare degl’innamorati): insomma, ancora una volta, un significante in cui si sovrappongono la semantica degli affetti e quella del denaro. Se nella Traumnovelle di Schnitzler l’estraneità di Fridolin rispetto alla setta orgiastica allude alla questione ebraica, nel film scritto da Kubrick e Raphael l’estraneità del dottor Harford è surdeterminata dal suo status economico: com’è possibile arrivare in taxi ad una festa (gratuita – dunque, paradossalmente, fuori dalla portata economica dell’ acquirente medio) a cui tutti si presentano in limousine? La gratuità dell’orgia non implica la sua democraticità, al contrario: il costume cardinalizio del cerimoniere, così come il suo incensiere e il suo trono papalino, alludono ad un potere così elitario da non corrispondere al normale potere d’acquisto. Proprio in quanto gratuita, la festa dionisiaca – anche questa descritta attraverso la penetrazione della macchina da presa nello spazio del castello, spazio “orgiastico” proprio in quanto multiplo, “spettacolare” proprio in quanto sovrannumerario -ha un costo altissimo: la perdita d’identità personale (il potere mascherato è contemporaneamente occulto e disumano, ingiudicabile e immorale); la perdita di conoscenza sui meccanismi reali dello sfruttamento (il pianista che suona bendato, metafora dell’artista come buffone di corte dell’alta borghesia annoiata); il rischio della vita (la ragazza che si propone come vittima sacrificale). D’altra parte, il sogno orgiastico di Alice – che vive la stessa esperienza del marito, ma dal lato della vittima consenziente – è assolutamente gratuito, ma non per questo privo degli stessi rischi.
Il giorno dopo, alla luce del sole, la visita alle varie stazioni della via crucis rivela l’inaccessibilità diurna degli spazi disponibili durante la notte: il Sonata Cafè è rigorosamente chiuso e sprangato; il vialetto che porta alla reggia è bloccato da un cancello spiato da una telecamera a circuito chiuso. La libertà che apparteneva all’ordine della notte, sotto forma di possibilità di penetrazione negli spazi (previo pagamento della “consumazione” o semplicemente per esibizione della parola segreta), non è più all’ordine del giorno. E così il dottor Harford va in giro a mostrare il proprio portafoglio con tesserino in luoghi come la hall di un albergo (estrema rappresentazione architettonica dell’abitazione provvisoria a pagamento, l’esatto contrario di una casa – così come il portiere gay è l’esatto contrario di un angelo del focolare) e, dopo l’ennesima sosta in un bar (altro ambiente provvisorio a pagamento, luogo di flusso e di transito), nella hall di un ospedale e poi – ultima penetrazione – nell’obitorio, rappresentazione istituzionale di quel luogo finale non provvisorio che rappresenta la democratizzazione di ogni corpo e di ogni stato sociale.
Il lungo colloquio Harford/Ziegler, che a molti è sembrato inutile e noioso, è la puntigliosa esplicitazione della questione gerarchica: il billionaire è colui che può permettersi una stanza in cui giocare a biliardo (su un tavolo color rosso sangue) mentre sorseggia un whisky raro invecchiato un quarto di secolo (“Se vuoi te ne faccio mandare una cassa”); il suo medico ha diritto ad essere invitato alla festa “pubblica”, dove il pianista suona senza benda e la ragazza nuda ha un nome (Mandy) e un volto, ma non alla festa dell’élite, dove ogni pretesa identità scompare a favore del semplice gioco (anonimo e, per così dire, “attanziale”) del ruolo economico della domanda e dell’offerta, dell’acquisto e della vendita. La ragazza morta era solo una puttana; “È questo che era” si scusa Ziegler, come a dire: inutile preoccuparsi per chi, nel gioco del libero mercato, fa la parte della merce a completa disposizione di chi detiene il potere d’acquisto. In un mondo luhmanniano che si rivela diviso fra l’élite che può permettersi di soddisfare il proprio desiderio comprando l’oggetto corrispondente, e la massa di non-garantiti la cui identità si riduce a ciò che hanno da vendere (il corpo in quanto forza-lavoro, il corpo in quanto supporto di zone erogene e organi sessuali), il piccolo-borghese alla William Harford si ritrova sospeso in questo limbo ideologico: desiderare ciò che il ricco desidera per il semplice motivo che può permetterselo (era in fondo il tema di 8mm, l’apologo fallito di Andrew Kevin Walker e Joel Schumacher) oppure rinunciare al soddisfacimento del desiderio laddove questo presuppone la disumanizzazione del proprio oggetto (la reificazione di un soggetto)?
Ecco allora che Eyes Wide Shut si rivela il film più politico di Kubrick, quello in cui la connivenza fra le ideologie del potere (qui il liberalismo della globalizzazione economica, altrove il militarismo nazionalistico) e le istituzioni totali (la famiglia, l’esercito) viene saggiata sul terreno più contemporaneo: quello del sogno di libertà sessuale assoluta e di equazione fra piacere fisico e felicità. Non è dunque un caso che, in un quadretto familiare in cui mamma Alice fa fare i compiti alla piccola Helena, il problema di matematica verta su una differenza fra cifre di denaro (conoscibile attraverso un’operazione di sottrazione): la scuola, in quanto agenzia di socializzazione che nasconde un apparato ideologico di Stato, tende già a formare una capacità di ragionamento che sconfina nella razionalizzazione economica del mondo.
Eyes Wide Shut è un complicato gioco sul circuito denaro/merce/denaro: la festa come forma di scambio simbolico, il silenzio come prezzo del rapporto professionale, il destino come conseguenza delle possibilità di studio e lavoro, il matrimonio come gratuità del sesso, il desiderio come costituzione di un oggetto impagabile, il possesso come costituzione di un oggetto pagabile, il corpo come merce transazionale, il sentimento come domanda (e la risposta affettiva dell’altro come offerta sempre inadeguata all’eccedenza della domanda), la relazione parentale come diritto di sfruttamento del capitale sessuale, l’attesa come relazione col tempo quantificabile con un tassametro, lo stile come disponibilità di simboli di status, la salute come bene monetarizzabile, il corpo come proprietà vendibile in prima persona (in forma anonima perché il sesso, come il denaro, è un equivalente generale astratto di qualunque tipo di merce); e così via, in una litania di relazioni la cui mediazione è costituita dal denaro per vivere, cosa che fa del corpo (e del sesso) la perversa sintesi dell’essenza vitale (il sé-bios come distinzione primaria vita/morte) e dell’essenza mortale (la mortificazione dell’individuo anonimo come riduzione dell’anima a pura identificabilità anagrafica).
Alla fine di questa discesa agli inferi della globalizzazione, la sacra famiglia natalizia si trova riunita nel labirinto caldo di un negozio di giocattoli: e mentre nel freddo labirinto di Shining il figlio uccide edipicamente il padre, in questo ultimo spazio kubrickiano la coppia parentale ancora resiste. Lo shopping non è il male: è giusto che la piccola Helena voglia l’orsacchiotto o la Barbie. Non è giusto che Ziegler voglia Nightingale o Mandy: è il sostanziale acquisto di esseri umani il lato immorale del capitalismo finanziario. Ciò che classifica il matrimonio come luogo dell’amore è, fin dai tempi di Spartacus, la vera libertà sessuale, quella che sconnette la relazione fisica dalla relazione economica di compravendita del corpo. La prima cosa da fare subito è scopare, sì, ma scopare gratis et amore Dei.
SegnoCinema, Gennaio-Febbraio 2000, Anno XX n.101, pp. 2-12